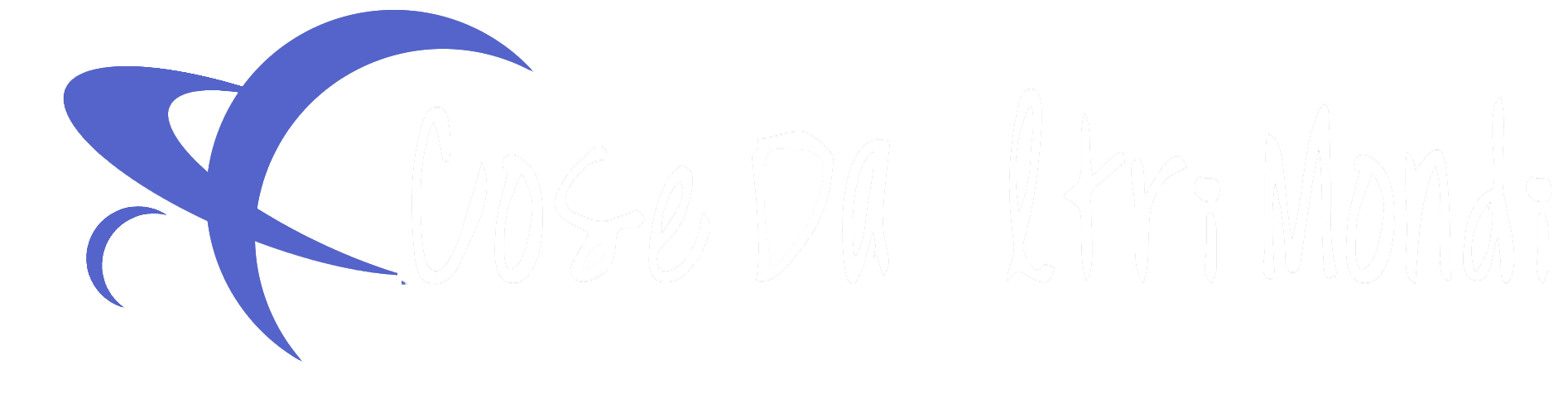Viaggio su Ikidea

Viaggio su Ikidea è un breve racconto di Luigi Valerio, che Vanni Mongini ha già presentato nella collezione di racconti L’alba dei miei compagni di viaggio. Abbiamo cambiato il titolo scelto da Luigi perché il suo sarebbe risultato un imperdonabile spoiler. La storia segue il fil rouge della fantascienza italiana sviluppando un pessimismo molto sentito da moltissimi scrittori italiani, che probabilmente meriterebbe un qualche studio sociologico dedicato. Studio che qui non abbiamo certo la capacità di svolgere. Una curiosità: ci ha colpiti il modo in cui Luigi scrive questa storia, alla Saramago, senza nemmeno un ‘a capo’. Lo abbiamo lasciato così.
In un pianeta di una galassia lontana, lontana, che chiameremo Ikidea la razza umana con la sua gente era arrivata per estrarre un prezioso materiale, necessario per i voli interstellari. La scoperta era stata fatta casualmente, ma ora, volontariamente gli uomini vi andavano; per sete di avventura e di denaro. Iniziarono in piccoli gruppi e poi col passare del tempo sempre di più, portando con sé le loro compagne e i loro figli. Poi passò altro tempo e nacquero i figli dei figli i primi veri ikidiani. Nel frattempo, da una sparuta colonia si era arrivati a una importante stazione spaziale che richiese una struttura adeguata al numero di esseri che vi abitavano. Ah, dimenticavo di dire che questo pianeta non era ospitale per l’uomo. La sua atmosfera era irrespirabile, la sua superficie sterile senza possibilità alcuna di rimedio e una temperatura media sui cento gradi sottozero. Quindi si dovette provvedere a strutture che rigenerassero l’aria importata, il bene più grande che ci fosse e, ovviamente riscaldata. Sorse così una grande città sotto una enorme cupola e sei piccole cupole ognuna delle quali conteneva la sede di un servizio essenziale. Vi fu così la cupola dell’amministrazione, quella dei trasporti e delle comunicazioni, della guardia cittadina e della giustizia; inoltre, vi era quella dei magazzini del cibo e dell’acqua, quella per la produzione dell’energia; e, infine quella della scuola. Qui lavoravo io. Ero arrivato solo da qualche tempo su Ikidea, dopo il mio divorzio avvenuto sulla terra. L’avvocato della mia ex moglie era stato così bravo che era riuscito a togliermi tutto, ogni bene mobile o immobile che fosse, praticamente mi aveva lasciato col solo vestito che avevo indosso. In quella situazione non mi rimase che recarmi al palazzo dell’Emigrazione Planetaria dove mi accolsero con favore poiché non erano molti i volontari che si presentavano: generalmente l’emigrazione era un atto coatto e investiva prevalentemente gente che aveva sospesi con la legge, fossero essi penali oppure no. Detti loro le poche referenze di cui ero in possesso e lasciai che fossero loro a trovarmi una destinazione adatta dove avrei potuto essere utile con la mia specializzazione. Qualche tempo dopo venni chiamato mi fecero firmare un contratto contenente degli atti di assenso e liberatori, io dal mio canto non chiesi neppure come si chiamasse il pianeta dove sarei dovuto andare, lo seppi solo all’arrivo. Sull’astronave con la crioterapia biologica che aveva raggiunto mete impensabili solo qualche tempo prima, il mio corpo venne immerso in una soluzione per cui il viaggio avvenne in uno stato di completa ibernazione, un lungo sonno senza sogni da cui mi risvegliai solo dopo centosettantasette anni. Si, centosettantasette anni di viaggio alla velocità di poco superiore a quella della luce, ero più vecchio di mio figlio che avevo lasciato sulla terra e forse anche del figlio di suo figlio se ne avesse avuto uno, eppure avevo l’aspetto che avevo alla partenza; lo specchio me lo disse appena fui in grado di specchiarmici. Sbarcai solo io su Ikidea, mi venne assegnato un alloggio, sufficiente alle esigenze di una persona che non aveva famiglia. Ero insegnante e insegnavo una materia che sembrava assurdo insegnare in quel luogo, ma chi aveva deciso lo aveva fatto a ragion veduta. Non ci si può dimenticare delle proprie radici. Avevo trovato il modo di rendere la storia interessante e i miei scolari la seguivano con passione. Si trattava di cinquecento ragazzi di varie età divisi in classi che alternavano le varie materie in orari di studio programmato. Di fronte all’edificio della scuola vi era un piccolo locale dove poter fare qualche pausa sorbendosi una bibita o un caffè, fu così che arrivato da poco sul pianeta e non conoscendo nessuno feci amicizia con il barman Alan, un uomo di non grande statura dai capelli arruffati e gli occhi vivaci, un naso importante che risaltava sulla faccia dove spiccava un sorriso che sembrava ingenuo che nascondeva una innata arguzia. Ogni giorno dopo le prime ore di insegnamento vi era una pausa ricreativa, per gli studenti e per i professori. Il mio carattere ombroso non mi aveva favorito nei rapporti con gli altri colleghi da cui mi tenevo a debita distanza, incapace di fare il primo passo. Ma, un giorno, accadde l’imprevedibile. Entrando nel locale indirizzai ad Alan una frase che ormai aveva assunto la struttura di un ‘classico‘ ovvero, ‘Alan preparami il solito!’ e lo dissi mentre contemporaneamente un’altra persona diceva la stessa cosa. Mi voltai a vedere di chi si trattasse e incrociai il suo sguardo, due grandi occhi scuri pieni di dolcezza, ma solo il suo sguardo poiché lei, perché si trattava di una donna, faceva parte del gruppo etnico di religione islamica. Ci sorridemmo, imbarazzati e divertiti. Nonostante nei secoli si fossero andate perdendo molte vecchie usanze, quella dei gruppi religiosi esisteva e resisteva ancora. Personalmente sono agnostico, ma sono tollerante nei confronti di chiunque professi un suo credo, purché lo faccia senza fanatismo. Iniziò così un rapporto che di giorno in giorno si trasformò in legame. Dapprima i suoi occhi che sorridevano ogni volta che ci incrociavamo, poi un primo ‘ciao‘, a seguire un invito a dividere lo stesso tavolino a bere il caffè. Fu in una di queste occasioni che lei scoprì il volto e vidi il suo bel sorriso. Quindi iniziammo a scambiarci idee e opinioni sul lavoro. Poi un invito a una passeggiata nell’area verde della città e un susseguente invito a cena. A ogni nuovo incontro sentivo il mio cuore battere impazzito e mi chiedevo se non fosse davvero impazzito, venivo da un matrimonio fallito e non mi sentivo ancora pronto per iniziare un nuovo rapporto. Nell’abbraccio che avvenne in seguito sentii che anche il suo cuore palpitava e parlava più di mille parole. Naturalmente i suoi nutrivano delle riserve nei miei confronti non professando io la stessa religione e non avendo un lavoro che mi consentisse un tenore di vita adeguato al loro. Il padre era un facoltoso commerciante di oggetti di pregio, e la famiglia viveva in una certa agiatezza; questo creò imbarazzo e difficoltà nei nostri rapporti. Raccontandomi questo piangeva sapendo il peso di questo ostacolo che si frapponeva tra noi. Io cercavo di consolarla, piano piano superammo il fatto della nostra diversità e delle difficoltà che avrebbe creato. Si fece strada in me un sentimento che crebbe dapprima inconsciamente e lentamente ma, che alla fine, scoppiò e fu impossibile trattenere. Anche in lei avvenne la medesima trasformazione dall’amicizia prendeva posto qualcosa di diverso, di importante. Un amore. Quando il nostro rapporto si consolidò, fu allora che accadde il fatto, un grave incidente all’impianto di filtraggio dell’aria della cupola della scuola e proprio nel momento in cui erano presenti tutti i cinquecento studenti. Scattò l’allarme, quello sonoro di una sirena che annunciava il guasto e quello pratico, l’isolamento completo della struttura previsto onde non compromettere l’intera città qualora si fosse verificato un fatto del genere. Ovviamente questo comportava che tutti i ragazzi e gli insegnanti presenti fossero divisi dal resto del loro mondo. Con i mezzi di comunicazione si accertò la natura dell’incidente, ma la soluzione ci venne prospettata dall’ingegnere capo e prevedeva la necessità di un sacrificio. Bisognava entrare in un locale dove era possibile ripristinare tutto, con delle semplici manovre. La sola difficoltà che questo locale era altamente radioattivo e colui che vi si fosse inoltrato andava incontro a morte certa. Il preside riunì tutti gli insegnanti, eravamo una ventina e ci illustrò chiaramente la situazione, entro poche ore l’aria sarebbe finita e tutti sarebbero morti, lentamente a cominciare dai più piccoli. Ci guardammo, inizialmente senza comprendere; poi fu chiaro il suo intento. Stava chiedendo alla coscienza di noi tutti di trovare la soluzione al problema. Alcuni di noi avevano famiglia, altri addirittura i figli che frequentavano la scuola. Ma chi se la sarebbe sentita? Chi coscientemente sarebbe andato incontro alla propria morte sacrificandosi per gli altri. Tutti volevano vivere, ma questo condannava inevitabilmente tutti. Uscendo dalla riunione, con l’animo in subbuglio, sulle scale incontrai una bambina, avrà avuto sei, sette anni. Mi fermò e mi chiese con quella vocina che hanno le bimbe di quell’età – È vero quello che dicono i ragazzi più grandi, che moriremo tutti? – La guardai e in un istante compresi quello che avrei fatto, le sorrisi e le dissi – No, non sarà necessario! – La accarezzai e mi incamminai verso quel destino che non avrei voluto ma che sentivo necessario, perché la mia vita avesse un senso, uno scopo. Recandomi verso il fabbricato dove si trovava il locale la trovai nel corridoio, guardandomi lei comprese, mi corse incontro abbracciandomi e mi disse -Perché tu, perché proprio tu – le risposi – Perché non io? – E lei con gli occhi pieni di lacrime – Ma io ti amo! – la guardai e le presi la mano e le sorrisi – Anche io ti amo e avrei voluto amarti e vivere tutta la mia vita con te, ma è necessario che io lo faccia, altrimenti nessuno lo farebbe, la vita di uno vale più che la vita di molti – allora lei mi disse in un ultimo tentativo di trattenermi – Vengo con te – Non le risposi nulla, la baciai, dolcemente, e con uno sforzo di volontà mi staccai poi non mi volsi a guardarla ancora, sapevo che se lo avessi fatto non avrei avuto più il coraggio di fare ciò che stavo per fare. Giunsi infine davanti alla porta, quella porta da cui non ci sarebbe stato ritorno, lo dichiarava chiaramente anche la scritta sul cartello. Aprendola pensai – Se ci sei, dammi la forza – La rinchiusi dietro di me, venni investito da un calore che mi penetrò fino alle ossa. Sentii le forze venirmi meno, ma non volli sentire oltre. Raggiunsi la consolle e mi sedetti dinnanzi alla tastiera, seguii le istruzioni mentre la mia vista si stava lentamente annebbiando e premendo l’ultimo tasto non vidi più nulla.
Dedicato alle mie nipoti Isabella a Lucrezia
Copertina tratta da SUBSTANCE, art by NIKLAS LUNDBERG

Luigi Valerio
Nasce a Padova nel 1951 e incontra la fantascienza nel 1966 con un romanzo di Pohl e Williamson. Ha creato il Club Padovano di Fantascienza assieme a Filiberto Bassani. Conosce persone del mondo del cinema e di teatro, attori e registi. Si diletta di poesia con cui ha anche vinto dei premi e possiede una importante collezione di pellicole.