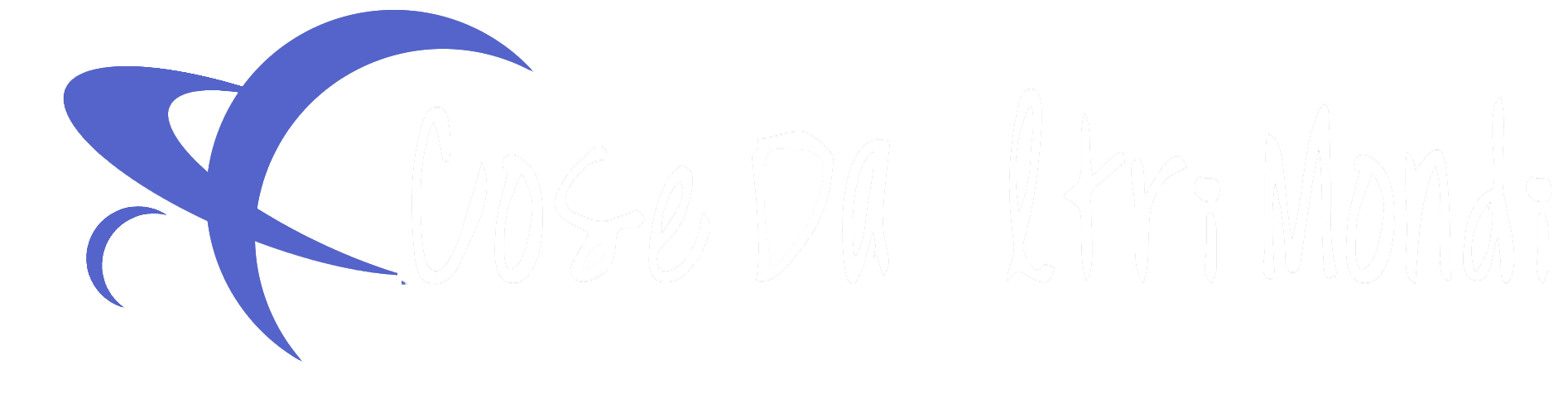NÉ ARIEL NÉ CALIBANO

La copertina è World © di Roberta Guardascione
disegnata appositamente per Cose da Altri mondi.
Scelti dal Direttore
Premessa
Nel 1980 scrissi Una notte di 21 ore. Il racconto fu pubblicato lo stesso anno su Oltre il Cielo e segnò l’inizio di una nuova fase nella mia produzione fantascientifica.
Le ragioni erano due: con quel racconto cominciavo a sondare l’affascinante e terribile campo del comportamento umano di fronte all’inconoscibile o comunque in una situazione di crisi. La seconda ragione fu che piacque a Sandro Sandrelli, e nel 1963 apparve sul terzo numero dell’antologia Interplanet ottenendo così, con il crisma antologico, l’attenzione di un più vasto pubblico. Tra quel pubblico c’era anche il regista Mario Bava che pensò di farne un film.
E nel 1965 uscì sugli schermi Terrore nello spazio.
A quanto dicono gli addetti ai lavori fu il primo film italiano di fantascienza tratto da un racconto italiano.
Nel 1982 rappresentò l’Italia al XX Festival del Cinema di Fantascienza di Trieste nella sezione Dal libro allo schermo.
Questi dati non vengono elencati per autocompiacimento ma per spiegare la ragione per cui quel racconto fu considerato per diversi anni una sorta di “manfesto” della mia produzione.
Poiché sono nettamente contrario alle etichette, mi sentivo un po’ fuori posto ad essere indicato come “quello della notte di 21 ore“. Però, nello stesso tempo, ero lieto che ciò servisse a evidenziare il tipo di fantascienza che ho sempre cercato di promuovere, cioè una fantascienza italiana antropologica dove sia l’uomo il protagonista e non il gadget. Dopo 25 anni mi piace vedere che questa tendenza si è irrobustita e anche da oltre oceano ora si guarda un po’ di più a quello spazio interno a cui alcuni di noi tendevano anche se in tono più sommesso di quanto poi fece la New Wave inglese.
Un motivo derivante per il quale fui lieto che quel racconto avesse una notevole diffusione riguardava la tipologia dell’alieno. A quel tempo gli alieni erano generalmente mostruosi e apertamente “contro”. In Una notte di 21 ore i mostri contro cui i terrestri dovevano combattere erano quelli del loro stesso inconscio, i più sottili, i più difficili da vincere perché non apertamente “contro” e del tutto inesistenti dal punto di vista materiale. Per alieno ho sempre preferito un’astrazione piuttosto che una descrizione particolareggiata la cui alienità fosse proporzionale alla mostruosità fisica. Questa tipologia divenne quasi una costante nei lavori successivi.
Poi c’era la nebbia, il medium che fa intuire al personaggio ciò che i sensi normali non permettono, la chiave per farlo entrare in altre dimensioni, fargli supporre cosa c’è “al di là”. Sarà perché sono veneziano e abito in una città che fra acqua e nebbia è molto spesso sospesa in bilico tra reale e immaginario dove lo straordinario è il quotidiano, però la nebbia è un altro ingrediente che ripresi più volte e che spesso ha avuto un peso determinante nell’economia della vicenda.
Nella versione cinematografica Mario Bava calcò la mano più sulla componente horror che sull’analisi comportamentale dei personaggi, ma si sa, lo schermo ha altre esigenze.
Questo riagganciarmi al cinema non è fatto a caso. Un giorno Luigi Cozzi mi chiese cosa ne pensavo di una sceneggiatura che fosse il seguito di Terrore nello spazio. Non sono un patito di serial, tutt’altro, ma rileggendo il vecchio racconto vidi che alcuni punti potevano essere sviluppati senza doverli stiracchiare, anzi poteva essere l’occasione per approfondire e spiegare il comportamento psicotico dell’equipaggio della Vega.
L’idea cominciò a farsi largo e, come succede a tutti quando un’idea comincia a frullare ed è sentita, non c’è niente da fare, ci trasformiamo in femmine (quando il sesso lo richieda) e dobbiamo partorirla. Ed ecco che, pensando alla sceneggiatura, si formò il plot di questo nuovo racconto, o forse fu pensando già in chiave di racconto che scrissi una bozza di sceneggiatura. Il palcoscenico era lì che aspettava, con i banchi di nebbia che da 25 anni continuavano a velare e svelare relitti di astronavi e uomini morti pronti a rialzarsi. Bastava rimettere in moto il meccanismo.
Poi c’era un altro fattore: durante questi ultimi anni avevo scritto quasi esclusivamente un genere di fantastico per portare avanti un discorso iniziato nel 1980 con il racconto De ludis in tempore, che poi è lo stesso discorso a cui accennavo prima nei confronti della fantascienza: intendo un fantastico basato sul nostro retaggio culturale e storico, sul nostro bagaglio di miti e leggende senza dover chiedere a prestito improbabili saghe ed epopee esotiche.
Ma questo adesso non c’entra. Voglio solo dire che, dopo qualche anno di assenza dallo spazio (se non per brevi incursioni), sentivo anche la nostalgia di ripartire a bordo di un’astronave. E poi c’era il fascino di rivisitare i luoghi e riprovare le emozioni ormai così lontani nel tempo.
Mancava il titolo. Uno degli aspetti che volevo evidenziare era il provincialismo cosmico, l’errore di interpretare un’alienità in forma manichea. E quel pianeta senza nome, quasi un’isola sperduta dove si verificavano fatti al di là delle facoltà umane, dove intervenivano forze che sembravano alimentarsi nella magia, mi si presentò come il campo d’azione dell’opera più “fantastica” scritta da Shakespeare.
Pertanto, chiedendo debitamente scusa al bardo, diedi i nomi di Ariel e di Calibano alla dicotomia inconoscibile che condiziona la permanenza di sei umani su un pianeta polveroso intorno al quale ruotano tre satelliti, che nasconde un segreto dalle strane analogie con… ma vediamo cosa sta succedendo a bordo della Da-reth, con quel computer che ha un comportamento così strano…
Renato Pestriniero
Capitolo 1
Avevano messo sotto pressione anche i due sensitivi, malgrado nessuno si aspettasse grossi risultati: le loro facoltà coprivano l’intero campo della psicotronica, ma si manifestavano al meglio sulla materia vivente più che nella tecnopatologia. E il problema a bordo della Da-reth riguardava esclusivamente le apparecchiature. Il computer segnalava anomalie che in realtà non esistevano. La prima volta s’era accesa la spia che indicava irregolarità nel flusso di una pompa. Ma, se effettivamente il flusso fosse stato irregolare, altri quattro sistemi ne avrebbero denunciato le conseguenze. Poi la spia si era spenta.
Poche ore più tardi il computer aveva annunciato un’emergenza e il grafico apparso sui monitor indicava l’indebolimento di un pannello a causa di micrometeoriti, benché il segnalatore d’impatto fosse rimasto muto.
A bordo della Da-reth c’era perplessità più che preoccupazione. L’equipaggio era formato da uomini che non si lasciavano certo andare al primo segnale di pericolo: non si sarebbero trovati a bordo di quella nave né in quel quadrante dello spazio. Però dovevano chiarire la situazione al più presto.
Quando anche l’emergenza sul pannello si autoannullò con la stessa indifferenza con cui si era annunciata, toccò al portellone di dritta. Sui monitor apparve la scritta starboard hatch open – malfunction – starboard hatch open – malfunction… e così di seguito. Impossibile, ovviamente.
La perplessità nei sei membri dell’equipaggio aumentò.
«Ci vorrebbe qualcosa di solido dove posare i piedi e poter lavorare in pace,» disse Mark Boveri, «Fare un check-up con il 78% delle apparecchiature in attività non è nemmeno da pensare.»
Frank Emmerick era il comandante, e quello che Boveri aveva detto ad alta voce lo aveva già pensato. Sì, bisognava correre ai ripari prima che la missione fosse messa realmente in pericolo.
Emmerick si sivolse a Shennon: «Van, vedi un po’ se il nostro amico riesce a darci qualche indicazione.»
Van Shennon eseguì in silenzio. Sul monitor cominciarono a sfilare i parametri di pianeti con caratteristiche ottimali per accogliere gli uomini della Da-reth, che però venivano sistematicamente annullati quando entravano in rapporto con la posizione della nave.
Il segnale d’allarme annunciò che il margine di tempo per l’EVA era entrato in zona critica. Poiché non c’era alcuna attività extraveicolare in corso, gli uomini si limitarono a guardarsi l’un l’altro senza fare commenti.
L’avvertimento si esaurì da sé.
Sul monitor le possibilità di un atterraggio di emergenza continuavano a diminuire. Infine rimasero le coordinate dell’unico pianeta che si trovava all’interno del quadrante in cui la Da-reth si trovava in quel momento. Le coordinate si ritirarono a lato del monitor e cominciarono a scorrere le informazioni relative al pianeta.
«QD-3391,» commentò Emmerick ad alta voce, «Nessun interesse pratico ha quindi abbandonato. Bene, cerchiamo di arrivarci al più presto.»
Shennon chiese al computer una traiettoria al massimo della spinta. Sul monitor apparvero le modifiche di rotta da apportare, che continuarono ad aggiornarsi con il variare della posizione spaziale della nave rispetto al pianeta.
«Chissà quanto ci sarà di vero in tutto quello che dice,» osservò Daniel Whitmore, il più anziano dell’equipaggio, riferendosi al computer. Dall’alto dei suoi 53 anni si divertiva a dare giudizi con un distacco che, il più delle volte, veniva considerato incosciente più che filosofico.
Shennon si girò a guardarlo. «Troppe informazioni, Dan. Adesso non si tratta di mostrare un portellone aperto che invece è chiuso. Qui dovrebbe immaginare un intero pianeta ed elaborare in continuazione le informazioni mantenendole coerenti.»
«Ma sì, ma sì.» Sorrise Whitmore.
Shennon scrollò le spalle. La Da-reth, obbedendo agli ordini del computer, si avventava lungo la traiettoria che l’avrebbe posta su un’orbita stabile intorno a QD-3391, un pianeta presentato dal computer con caratteristiche ambientali adatte agli umani. Fino a pochi anni prima, un’opportunità del genere avrebbe fatto sensazione, ma da quando i motori Neilson-Berry avevano permesso di spingersi a velocità e quindi a distanze imprevedibili, i pianeti con tali caratteristiche erano scaturiti numerosi dalle profondità dello spazio. Nonostante ciò nessuna traccia di vita intelligente era stata ancora trovata, avvalorando così la teoria secondo la quale l’intelligenza era un’eccezione terrestre non riscontrabile altrove.
Fu quindi con estrema indifferenza che gli uomini della Da-reth continuarono ad avvicinarsi a QD-3391. L’unica ansia era per il computer che continuava a spargere i più impensabili avvisi di pericolo. Ma, almeno per il momento, le informazioni ricavate dalla sua memoria circa la posizione di QD-3391 e le istruzioni per l’avvicinamento sembravano esatte. Emmerick aveva rinunciato alle orbite previste dal regolamento decidendo per una curva che avrebbe portato la Da-reth direttamente su un punto dell’emisfero diurno.
Scendere sulla superficie del pianeta fu come trovarsi su un deserto della Terra a 8000 metri di altezza, con l’unico inconveniente di pesare una decina di chili in più. Il paesaggio si presentava come una crosta polverosa chiazzata da banchi di nebbia.
Fu dato subito inizio alla fase attiva, cioè le rilevazioni che ogni unità deve effettuare in caso di atterraggio su un corpo celeste, anche se in emergenza, quando le condizioni dei moduli di esplorazione e dell’equipaggio lo permettano. Vedersela con il computer era lavoro di Van Shennon e Mark Boveri, tutti gli altri potevano togliersi dai piedi.
«Vi lascio anche Geen.» Disse Emmerick.
«E perché? Non puoi portarti via anche lui?» Scherzò Shennon.
Emmerick rispose alla proposta di Shennon: «Nossignore. Voglio che almeno un sensitivo rimanga a bordo.»
«Va bene, va bene,» concesse Shennon, «Vorrà dire che ci farà il caffè.»
«Grazie,» disse Geen Benoit, «Sarà un vero piacere.»
Erano schermaglie consuete tra normali e sensitivi.
I due gruppi si divisero. Mark Boveri e Van Shennon cominciarono a darsi da fare con il sistema nervoso del computer. Geen Benoit si ritirò subito nella sua cabina.
Facevano parte dell’altro gruppo, oltre a Frank Emmerick, il vecchio Daniel Whitmore e Hans Ludqist, il secondo sensitivo. Si imbarcarono su uno dei moduli di esplorazione e iniziarono una serie di giri intorno alla Da-reth sempre più ampi fino a che l’astronave fu solo una traccia intermittente sul monitor. L’emisfero era illuminato da una stella talmente lontana che riusciva a dare appena un lucore crepuscolare. Vista dall’alto, la superficie si stendeva in una monotona uniformità polverosa attraversata da veli di nebbia, sottili increspature e da improvvise crepe.
QD-3391 faceva parte del grande numero di pianeti che, una volta classificati per la loro inutilità pratica – cioè commerciale – venivano abbandonati in attesa di una eventuale spedizione scientifica, sempreché qualche Fondazione o sponsor si prendesse la briga di sovvenzionarla. Ovviamente la tesi ufficiale non era questa.
Il modulo della Da-reth continuava a girare in ottemperanza al regolamento che richiedeva un rapporto su una zona di almeno cento miglia di raggio dal punto di discesa. Sembrava che la missione dovesse continuare sonnolenta fino al raggiungimento del limite previsto, ma improvvisamente Hans Ludqist avvertì qualcosa. «Dan,» disse rivolto a Whitmore che pilotava il modulo, «Prova ad abbassarti.»
Emmerick guardò il giovane sensitivo. I suoi occhi chiari erano fissi dinanzi a sé nell’atteggiamento classico di ricezione. «Cosa senti?» Chiese.
Il sensitivo non rispose. Qualcosa aveva risvegliato il senso misterioso che le continue manipolazioni genetiche gli avevano casualmente fornito. Chiuse gli occhi, le sue labbra cominciarono a muoversi ma non ne usciva alcun suono coerente. Anche il vecchio Whitmore se ne stava tranquillo ai comandi senza dar sfogo alle solite battute ironiche.
Emmerick posò una mano sulla spalla di Whitmore. L’uomo si girò e Emmerick gli fece cenno di rallentare. Il modulo diminuì di spinta e picchiò leggermente. Il sensitivo mosse la testa in un cenno di assenso. «Sì… più basso, vola più basso Dan… c’è qualcosa sotto di noi… abbassati e vola in cerchio…»
Senza far commenti Whitmore eseguì. La superficie sotto di loro continuava a presentarsi anonima a grigia. Nella luce crepuscolare l’orizzonte appariva vicino.
Il tempo sgocciolò mentre il modulo si avvicinava alla superficie in una spirale che diventava sempre più stretta a seguito delle indicazioni sussurrate dal sensitivo. Gli strumenti non davano alcun segnale di pericolo.
Ma ecco che, tra leggeri sbuffi di nebbia, apparve una zona inaspettatamente smossa; la grigia monotonia della superficie risultava interrotta da tracce ben diverse dalle linee tortuose delle fenditure o dalle increspature di polvere. Era come se un bambino si fosse divertito a giocare con la sabbia sulla riva del mare e le onde non avessero ancora spianato il ricordo dei suoi giochi.
«Da-reth! Da-reth!» Chiamò Emmerick.
«Eccoci Frank. Che succede?»
«Tracce sulla superficie. Stiamo abbassandoci.»
«Che genere di tracce, Frank?» Era Shennon che poneva le domande.
«Non lo sappiamo ancora. La polvere appare smossa… è stato Hans a localizzare il luogo.»
Subentrò subito la voce di Geen Benoit. «Cosa senti, Hans? È forte?»
«Direi proprio di sì, ma non riesco a individuare la natura del segnale… mai sentito niente di sinile.»
«Frank,» Geen Benoit si rivolse al comandante: «Che ne dici se prendo l’altro modulo? Vorrei esserci anch’io.»
«Negativo. Voglio che almeno uno di voi rimanga a bordo. Qui è sufficiente Hans. Van, hai preso nota della posizione?»
«Certamente. Vi seguiamo e rimaniamo in contatto.»
«Bene. Ora scendiamo. Dan… lì, dirigi su quell’avvallamento butterato. Individuato qualcosa, Hans?»
«Il segnale è molto chiaro e forte, senz’altro una zona esopatogena,» mormorò il sensitivo, «Ma non riesco a determinarne la natura.»
«Qualcosa di vivente?»
Il sensitivo fece un segno affermativo ma non fu una risposta decisa. Emmerick si soffermò a fissarlo per un lungo momento, colpito da quell’indecisione.
«Quasi ci siamo,» annunciò Whitmore, «Cerco di posarmi il più leggermente possibile. Che ne dici, Frank, faccio bene? Così non disturbiamo nessuno.»
Emmerick non rispose alla battuta di Whitmore, i suoi occhi erano fissi su qualcosa di natura indiscutibilmente artificiale. «Cos’è quello…» disse a bassa voce.
«E perché credi che voglia scendere in punta di piedi?» Osservò Whitmore, «Quella roba lì non è certo una scherzo della nebbia.»
Il modulo si posò sulla polvere con una leggerezza che ancora una volta suscitò l’ammirazione di Emmerick. Il vecchio Dan Whitmore era insuperabile per certe cose malgrado i suoi difetti, ed Emmerick era contento di averlo con sé in quella circostanza: la sua esperienza e il suo modo distaccato di osservare le vicende della vita erano una garanzia. Come, per esempio, il modo con cui aveva preso atto di trovarsi di fronte a un accadimento che stava al di là dei fenomeni naturali per quanto inaspettati potessero essere.
Prima di aprire il portello del modulo Emmerick interrogò ancora una volta il sensitivo con lo sguardo. Hans Ludqist fece un cenno di impotenza.
«Va bene,» concluse Emmerick passando a parlare sul microfono da polso, «Ora usciamo. Non voglio scambi in voce. Seguite le nostre tracce sul monitor. Sarò io a chiamare.»
«Ricevuto. Però se vi perdiamo sul monitor io arrivo.»
«Solo se anche le comunicazioni saranno interrotte. Chiudo.»
I tre uomini scesero sulla superficie polverosa. Si muovevano lentamente, osservando intorno con ansia comprensibile, cercando di penetrare i bassi vapori che li circondavano. Vista così, la superficie del pianeta dava l’impressione di una stanza vastissima con pareti e pavimento grigi, evanescenti nella morbidezza della nebbia. Il silenzio era totale. Lo spesso strato di polvere annullava il rumore dei passi. La prospettiva era venuta a mancare. Ora si trovavano inseriti in un particolare dell’insieme, e le strane asperità viste dall’alto adesso non erano più percepibili. Quanto li circondava non aveva la drammaticità di pochi minuti prima, ma nella mente dei tre uomini era rimasta fotografata in modo indelebile l’immagine di un oggetto. In quella direzione Hans Ludqist si stava dirigendo con passo lento però deciso. Gli altri lo seguivano senza fare commenti, limitandosi a guardare di continuo ai fianchi e alle spalle.
Ed ecco che dall’alto di una gibbosità riapparve l’oggetto, un po’ sbiadito dalla nebbia ma in tutta la sua incredibile allucinante concretezza: un’asta usciva dalla polvere. Era inclinata, dall’apparenza metallica, di disegno rettangolare. A poca distanza dall’estremità tagliata netta, la verticalità dell’asta veniva interrotta da un triangolo isoscele con il vertice dei due lati uguali rivolto verso l’alto. Da un esame più ravvicinato l’asta e il triangolo risultavano un blocco unico, quasi una lancia stilizzata, dalla cui punta l’asta si prolungava per circa mezzo metro.
I tre uomini si arrestarono accanto all’oggetto. Spirava un alito appena percettibile, troppo lieve per provocare fruscio, quasi un movimento d’aria attraverso un’immensa porta aperta che riusciva a smuovere i granelli di polvere alla superficie.
Quella presenza silenziosa eppure mobile era stata accettata inconsciamente dai tre uomini come una costante di quel pianeta insieme all’uniformità della superficie, alla luce crepuscolare proveniente dalla stella lontana, ai ghirigori di nebbia che si formavano e svanivano senza causa apparente.
Il sensitivo fissava l’asta. Rimase a lungo in quella posizione in uno stato di rêverie. Emmerick non lo sollecitò.
Improvvisamente Hans si girò di scatto sul lato destro. Gli altri seguirono il suo sguardo. Il grigio della nebbia si confondeva con il colore della polvere.
«C’è un…» Hans aveva alzato il braccio a indicare la provenienza di messaggi che solo la sua diversità riusciva a captare. Whitmore si mosse in quella direzione.
«Dan! Non muoverti!»
«Solo pochi metri, Frank.» E il vecchio pilota continuò deciso per alcuni passi ancora.
«Dan! Te lo ordino!»
«Un’ombra, Frank! C’è un’ombra laggiù… che si muove!»
Il sensitivo era come paralizzato nella posizione di indicare il punto dove Whitmore si stava dirigendo incurante degli ordini di Emmerick, manifestando una tensione fortissima: le sue labbra si muovevano ma ne uscivano suoni incomprensibili.
Emmerick si trovava ad affrontare una situazione anomala: doveva stare accanto al sensitivo per sapere da dove arrivava il pericolo, e contemporaneamente era spinto a seguire Whitmore sia per difenderlo in caso di necessità, sia per rendersi conto lui stesso di cosa stava succedendo nella nebbia.
Whitmore era già una figura sfocata, ben presto sarebbe svanito del tutto. Continuava a chiamare i compagni e a inseguire quella strana ombra. Poi si fermò. Emmerick sopraggiunse cauto, una mano serrata sul braccio di Hans. Il modulo era scomparso alle loro spalle, cancellato dalla nebbia.
«Non mi sono spinto oltre,» disse Whitmore, e nella sua voce Emmerick notò un’incrinatura. Era la prima volta che la notava.
«Troppo lontano. Quell’ombra si muoveva troppo velocemente. Hans, tu che ne dici?»
Il sensitivo si stava riprendendo dal suo stato di trance. Si guardò intorno, lentamente, come sondando l’aria. «È andato,» disse, «Lo sento ancora ma adesso è troppo lontano per raggiungerlo.»
«Stavi per dire che cosa sentivi, prima…» Indagò Emmerick.
«Forse un animale, Frank,» intervenne Whitmore, «Una specie di scimmione.»
«Ma che stai dicendo!»
Il sensitivo dimostrava di trovarsi di fronte a un’esperienza nuova, ed era questo l’aspetto che preoccupava Emmerick. Anche ammesso che su quel pianeta ci fosse una forma di vita, perché Hans non riusciva a inquadrarla? Perché quel dubbio, quella impossibilità di esprimersi?
«Non so… non posso… sono molto confuso…» Mormorò Hans Ludqist.
Emmerick insistette: «Pensi sia un animale come ha detto Dan?»
«Forse. Ma c’è anche intelligenza… qualcosa che viene da lontano… una macchina biologica… ecco, sembrerebbe una macchina biologica.»
Whitmore ed Emmerick si guardarono interrogativamente. Poi Whitmore indicò con il pollice la direzione in cui si era spinto poco prima: «Guardate un po’ le impronte dello scimmione. Io non sento con la mente ma vedo molto bene con gli occhi, e vi assicuro che quell’ombra si stava allontanando come un grosso scimmione, basta guardare la polvere.» Il vecchio Dan indicò un punto pochi metri davanti a lui. C’erano le affossature che normalmente un uomo lascia su quel tipo di terreno. «Provengono da dietro quella duna,» spiegò Whitmore, «Ecco… e quello è il punto dove l’ombra è passata. Poi è sparita.»
«Non mi piace,» disse a bassa voce Emmerick, «Presto, torniamo al modulo.» Avvicinò il polso alle labbra: «Da-reth!»
«Eccomi, Frank.» La voce di Shennon.
«Qualcuno o qualcosa ci sta osservando. Ci siamo allontanati dal modulo per una ventina di metri. Adesso uno di noi rimarrà nel modulo mentre gli altri due proseguiranno seguendo quelle maledette tracce.»
«Quali tracce, Frank? Cosa avete visto?»
«Per il momento niente di preciso. Dan dice di aver visto un’ombra e Hans sente qualcosa di strano che non riesce a inquadrare.»
«Ma hai parlato di tracce.»
«Sono affossature, hanno tutta l’aria di orme lasciate da qualcosa che sta andando a spasso qua intorno.»
«Hans!» Geen si intromise nel dialogo con la trepida sollecitudine che caratterizza i rapporti tra sensitivi, «Hai bisogno di me? È un Ariel o un Calibano?»
Nel loro linguaggio, i sensitivi chiamano così le presenze che non riescono a definire con certezza ma di cui avvertono le emanazioni rispettivamente di amicizia o di ostilità. Hans scuoteva la testa: «Non riesco a capire, Geen… né l’uno né l’altro… eppure tutti e due…»
«Shennon!» Chiamò Emmerick, «Voglio uno stato di preallarme sulla Da-reth. Adesso Dan rientra nel modulo e io seguo le orme entro un raggio di un centinaio di metri. Hans viene con me. Intanto Dan farà un rapporto sull’oggetto che abbiamo trovato.»
«Anche un oggetto! Ma allora c’è un sacco di roba su questa palla di polvere!»
«Tutto da controllare. Mark! Vedi cosa dice il computer sulla storia di questo pianeta.»
«Ricevuto.»
«E io che faccio?» Chiese Geen Benoit.
«Aguzza le orecchie. Cè una strana Tempesta nell’aria!»
Quando avevano preso terra con il modulo, la bruma sembrava vapore sfilacciato, ma poi si era ispessita e la visibilità era andata riducendosi velocemente. Dall’alto avevano potuto osservare quella strana nebbia che si formava e si dissolveva spinta dal soffio continuo che probabilmente percorreva l’intera superficie del pianeta. Frank Emmerick sperava che quel banco, capitato proprio nel momento meno adatto, se ne andasse con la stessa velocità con cui era giunto e permettesse un campo di osservazione più vasto. Tra l’altro, voleva che quella situazione fosse più chiara prima del sopraggiungere della notte, voleva capire o per lo meno farsi un’idea di cosa fosse quell’asta e di chi stava girando nascosto dalla nebbia, anche se si rendeva conto che non sarebbe stato facile.
Whitmore gli si accostò. «Prendete armi più pesanti.»
Frank Emmerick annuì. Perché mai Hans non riusciva ad inquadrare chi lasciava quei segni sulla polvere? Pensò ancora. Né Ariel né Calibano aveva detto il sensitivo, eppure tutti e due… Cosa significava?
La silhouette scura del modulo emergeva dalla nebbia a mano a mano che si avvicinavano. Il vecchio Withmore si installò al posto di guida, sistemò il laser accanto a sé e si apprestò a fare rapporto alla Da-reth. Intanto Frank Emmerick e Hans Ludkist già si stavano riallontanando seguendo le proprie tracce, solo delle affossature nello spesso strato di polvere. Superarono l’asta piantata resistendo alla tentazione di fermarsi ed esaminarla subito, e proseguirono fin dove la polvere mostrava chiaramente il breve tratto che Whitmore aveva coperto da solo all’inseguimento dell’ombra. Quando raggiunsero le orme che non erano state prodotte dai loro passi, Hans fece per seguirle ma Emmerick lo fermò: «No, aspetta. Non voglio fare il gioco di questo… qualsiasi cosa sia. Farsi seguire potrebbe essere un trucco per portarci lontano. Meglio seguire le orme che ha lasciato avvicinandosi.»
I due uomini si incamminarono nella direzione opposta. I segni erano ancora chiari malgrado il continuo soffio del vento avesse già arrotondato gli orli e diminuito la profondità. Hans si manteneva accanto a Emmerick ma sembrava seguisse più i misteriosi messaggi che la sua mente captava che non i segni concreti lasciati sulla polvere. Si arrestò di colpo. Emmerick si guardò intorno, l’arma pronta e il cuore che gli pulsava alle tempie. Il sensitivo indicò una duna alla sua sinistra: «Là dietro, dobbiamo andare là dietro. Adesso sento chiaramente la fonte anche se…»
«Cosa pensi ci sia lì dietro, Hans?»
Il sensitivo scosse la testa: «Non sono preparato a questo, mi sfugge… né Ariel né Calibano…»
«Ve bene, va bene, però le tracce non portano dietro quella duna, proseguono in questa direzione.»
«Non c’è differenza… la sento provenire da entrambe le parti… però dietro quella duna…»
«D’accordo, andiamo a vedere.»
Dalla sommità videro altre ondulazioni polverose che si spingevano sin dove la nebbia permetteva di vedere. Fra quelle dune c’erano macchie di vegetazione del tutto particolari: decine di aste ognuna con un triangolo isoscele incastrato poco sotto l’estremità si alzavano come un’inquietante foresta nana fino ai confini creati dalla nebbia e certamente oltre. Alcune aste erano abbattute. Emmerick notò che la loro lunghezza era notevole, tre metri almeno. Quindi, se le altre erano della stessa lunghezza, e tutto lo faceva supporre, erano conficcate nella polvere per oltre un metro.
«È molto forte adesso,» mormorò il sensitivo, «Fa male… è un pulsare continuo…»
«Voglio vedere più da vicino.» Emmerick lo disse più a sé stesso che a Hans Ludqist. Scese dalla duna e ben presto si trovò in mezzo alle aste. Hans rimase qualche passo indietro. Il comandante della Da-reth ne osservò parecchie ma non scorse alcun segno che potesse svelarne la natura o il significato.
Per il sensitivo sembrava adesso che le aste non esistessero, la sua espressione era di incredulità e paura. Malgrado continuasse a esaminare quegli oggetti misteriosi, Emmerick non perdeva d’occhio il comportamento del sensitivo: si rendeva conto della sofferenza cui era sottoposto il compagno, ma doveva rimanere in quel luogo fino al massimo della sopportabilità.
Le aste conficcate nella polvere sembravano metalliche, perfettamente integre come uscite da una catena di montaggio.
«Frank… Frank…» Il sensitivo indicava una zona dinanzi a lui. Emmerick vedeva le solite depressioni e piccole dune che sfumavano nella bruma. Un ghirigoro di nebbia lasciò intravedere una zona più scura delle altre, ed era lì dove adesso Hans si stava dirigendo, perduto nel suo mondo di sensazioni.
Dopo pochi passi i due uomini si trovarono di fronte a una vera e propria fossa, una buca profonda circa un metro. La polvere e la terra erano franate ai bordi ma era chiaro che si trattava di fenomeno recente. Il fondo della fossa era scuro, compatto, e mostrava l’impronta di qualcosa che, dopo essere rimasta lì per molto tempo, fosse stata tolta di recente. Accanto alla fossa, coricata sulla polvere, una delle solite aste. La parte inferiore aveva un colore nettamente più scuro. Emmerick vi passò la mano: era fredda e umida, come fosse stata divelta da poco.
Per la prima volta Emmerick sentì dentro di sé una sensazione strana: da anni volava a bordo di astronavi, ed era sceso sulla superficie di molti pianeti dove il pericolo era sempre in agguato, ed erano pericoli orrendi e imprevedibili perché scaturivano da ambienti al di fuori della Terra e delle sue regole. Ma questa volta c’era qualcosa di diverso, qualcosa che era oltre lo stesso imprevedibile, più sottile, che scavava nel profondo dell’animo e portava alla superficie terrori ancestrali.
«Hans… dobbiamo tornare subito al modulo.» Afferrò il sensitivo per un braccio, «Perché non riesci a capire cosa ci sta intorno!» Scuoteva il compagno quasi a imporgli una spiegazione logica di quella situazione. Gli occhi di Hans erano fissi sul bordo opposto della fossa, e allora anche Emmerick vide il particolare che lo sconvolse del tutto. «Oh, mio Dio!» Esclamò con voce soffocata. Inconfondibili tracce di passi partivano dall’orlo della fossa e si allontanavano nella nebbia. Erano le stesse orme che avrebbero girato intorno alle dune per arrivare dove Whitmore aveva visto l’ombra. Qualcosa era uscito da quella fossa e ora stava vagando fra le dune, e poteva essere ovunque, nascosto dalla nebbia, silenzioso, mentre camminava sulla polvere… ovunque… poteva essere ov…
Emmerick si girò di scatto puntando il laser. La superficie grigia si stendeva fin dove l’occhio poteva vedere. Volute di nebbia continuavano a sfilacciarsi morbide. Trascinò Hans con sé: «Al modulo, presto! Hans… svegliati!» Lo scosse per le spalle cercando di trarlo dallo stato di trance dal quale il sensitivo non riusciva a liberarsi, sembrava doversi accasciare da un momento all’altro, il suo volto era una maschera di sofferenza.
Era necessario chiedere aiuto alla Da-reth… e proprio in quel momento la Da-reth si fece sentire e per Emmerick fu come una mano amica tesa per portarlo a casa. Ma le prime parole che pervennero dalla Da-reth lo fecero sprofondare in un’angoscia se possibile ancora più oscura. Perché le voci di Van Shennon e di Mark Boveri si sovrapponevano terrorizzate: «Frank! Siamo contornati da mostri! Cristo… arrivano da tutte le parti! Frank! Dan! Ci sentite?»
«Sto dirigendomi verso…»
«Da-reth!» Questa era la voce di Daniel Whitmore dal modulo, «Che sta succedendo? Da-reth! Sono Dan, chi è che sta arrivando?»
«Emmerick a Whitmore. Dan, accendi tutte le luci del modulo e fa girare il riflettore. Siamo a poca distanza, dovremmo vederlo… fa presto, Dan!»
«Ricevuto, sto accendendo tutto… ecco, dirigo il riflettore nella direzione in cui ti sei allontanato…»
«No! Fallo girare, ci siamo spostati e abbiamo perso l’orientamento.»
«Ricevuto, Frank, il riflettore sta girando. Non dovrebbe essere difficile vederlo. Adesso il modulo sembra un albero di Natale… Da-reth! Cercate di fare un po’ meno baccano! Che sta succedendo laggiù? Di che genere di mostri stai parlando, Van?»
Mentre Whitmore ed Emmerick si stavano scambiando le istruzioni per ricongiungersi, era continuato un intreccio eccitato fra i tre uomini rimasti sull’astronave. Emmerick sapeva di che si trattava, e comprendeva benissimo il loro comportamento. Ma rimase in silenzio per non aumentare la confusione e concentrò le forze per sostenere Hans che sembrava non essere più in grado di proseguire, lo incitava a camminare e a parlare mentre teneva gli occhi sbarrati nel tentativo di scorgere le luci del modulo filtrare attraverso la nebbia che sembrava farsi sempre più fitta.
E finalmente un lampo scoppiò al limite sinistro del suo campo visivo. Tenne lo sguardo fisso in quella direzione. Due secondi e ancora il lampo.
«Ecco il riflettore. Fatti forza, Hans, da questa parte, ci siamo quasi… su, ancora un sforzo…»
Pochi passi, e anche le altre luci cominciarono a filtrare attraverso la nebbia e infine la sagoma familiare del modulo fu davanti a loro. Dan Whitmore uscì dal portello e, sempre parlando con la Da-reth, prese un braccio di Hans, se lo passò intorno al collo e trascinò il sensitivo dentro il modulo. Emmerick aiutò a spingere il compagno, poi si chiuse il portello alle spalle.
«Via!»
Whitmore avvertì la Da-reth della manovra che stava facendo. Dall’astronave Van Shennon continuava a fare rapporto su quanto stava succedendo all’esterno, ma le sue indicazioni non erano precise. Anche l’altro sensitivo a bordo della Da-reth, Geen Benoit, sembrava in condizioni di trance anomala. Intanto Mark Boveri aveva predisposto le misure di difesa e sarebbe stato lui a dirigere il rientro del modulo.
Il ritorno all’astronave prese pochi minuti perché adesso si trattava solo di una linea retta da percorrere alla massima velocità. Whitmore mantenne una quota di alcuni metri dalla superficie. I banchi di nebbia si susseguivano intercalati a zone libere. Intanto il cielo si stava oscurando.
Tra poco sarebbe scesa la notte.
* * *
I sei uomini erano di nuovo riuniti all’interno della Da-reth. Durante l’avvicinamento era stato possibile vedere dall’alto parecchie tracce sulla polvere che si intrecciavano intorno all’astronave, ma era stata una visione frammentata a causa dei banchi di nebbia.
Il fatto di trovarsi ancora tutti insieme aveva però sollevato notevolmente gli animi. Passati i primi momenti di angoscia, la razionalità e la professionalità dei sei uomini si erano imposte. Loro e l’astronave erano adesso pronti a ogni evenienza.
Mark Boveri aveva chiesto al computer tutte le informazioni relative al pianeta. Scoperto casualmente nell’11, cioè 173 anni prima, nessun’altra spedizione l’aveva raggiunto. Si era ripetuta la storia di tutti i pianeti che, non offrendo fonti di sfruttamento e di guadagno, difficilmente venivano studiati in loco da spedizioni esclusivamente scientifiche, anche quando il primo contatto presentava delle anomalie. Come QD-3391 per esempio. Le informazioni che la precedente spedizione aveva inviato alla Terra erano negative agli effetti dello sfruttamento, ma erano le uniche disponibili perché nessuno della spedizione aveva fatto ritorno; un fatto singolare che forse avrebbe potuto essere riesaminato se, poco dopo, la Terra non avesse dovuto leccarsi le ferite causate dal conflitto del ’13. E dovevano passare molti anni prima di rimarginare quelle ferite. E così, come tantissime altre cose, l’insolita scomparsa della prima spedizione su QD-3391 era stata dimenticata.
Nell’11 le astronavi che mettevano il naso in quadranti spaziali ora accessibili grazie alla scoperta dei motori Neilson-Berry non erano ancora attrezzate per essere del tutto autosufficienti. Ogni missione era quindi composta di due unità, una di esplorazione e una di appoggio. La missione che aveva avuto il primo contatto con QD-3391 era formata dalla Vega, unità di esplorazione, e dalla Orione, nave di appoggio.
Il disastro era avvenuto al momento dell’atterraggio. Proprio nella fase finale di atterraggio, la Orione era precipitata per ragioni mai chiarite. Le attrezzature e le riserve erano andate perdute nella quasi totalità, e l’intero equipaggio composto di cinque uomini era deceduto.
La tragica notizia pervenne alla Terra, assieme alle informazioni sul pianeta, dalla Vega. Comandante della nave superstite era Pat Wheaver. Nei pochi messaggi trasmessi dopo il disastro aveva confermato l’impossibilità di tornare sulla Terra senza i mezzi andati distrutti con la Orione.
Di quegli uomini non si seppe più nulla. Poiché le informazioni trasmesse erano state sufficienti per dimostrare che il pianeta non offriva risorse, QD-3391 fu messo nel mucchio di quelli di interesse scientifico “da accertare”.
Poi ci fui il conflitto e tutto andò a catafascio.
QD-3391 aveva un periodo di rotazione tale per cui le notti duravano all’incirca ventun ore terrestri. Intorno ad esso ruotavano tre satelliti, due dei quali di dimensioni notevoli, almeno due terzi della nostra Luna. Il terzo era praticamente un sasso di pochi chilometri e seguiva un’orbita molto vicina al pianeta e quasi del tutto circolare; i suoi passaggi erano quindi frequenti e veloci.
Adesso la piana dove la Da-reth si era posata stava per essere avvolta dalle prime ombre.
Emmerick aveva deciso di non spostare l’astronave, non poteva permetterselo con quel computer che faceva i capricci, anche se, dal momento dell’atterraggio, non erano sopravvenuti allarmi di sorta. Tutta la potenza difensiva e offensiva della Da-reth era all’erta, e questo dava una notevole sicurezza.
Oltre alla decisione di non spostare la nave e continuare il controllo del computer, era stata valutata la necessità di effettuare un’altra esplorazione della superficie sfruttando l’ultima luce del giorno e ottenere il maggior numero di informazioni possibili.
Questa volta presero posto nel modulo Mark Boveri e il sensitivo Geen Benoit. Il comando della missione fu affidato a Van Shennon. Tutti i membri dell’equipaggio avrebbero così avuto l’opportunità di verificare di persona quella incredibile realtà.
Il modulo si staccò dall’astronave madre quando il grigio del crepuscolo si stava tingendo di una soffusa luce rossastra. Ma non erano i colori della Terra. Nelle registrazioni fatte da Pat Weaver 173 anni prima era stata segnalata quella caratteristica cromatica dovuta a uno dei due satelliti maggiori. Durante le lunghe notti di tanti anni prima, quella luce rossastra che filtrava attraverso i veli di nebbia aveva certamente aumentato l’atmosfera inquietante del pianeta, forse aveva contribuito alla misteriosa fine dell’equipaggio della Vega.
Il radar del modulo non riceveva echi intorno alla nave. Le sensazioni che avevano così debilitato Hans Ludqist erano scomparse. Rimaneva però l’enigma delle presenze che si aggiravano e che, per usare il linguaggio dei sensitivi, non erano né Ariel né Calibano.
La linea con la Da-reth fu tenuta aperta e ogni parola e suono venivano registrati.
Durante la prima mezz’ora di ricognizione i rapporti dalla Da-reth furono privi di novità mentre quelli dal modulo ripetevano quanto già noto: tracce, presenza di aste un po’ dappertutto, isolate o a gruppi, zone di polvere smossa. Il vento soffiava sempre costante sia per intensità che per direzione.
L’annuncio che fece sobbalzare gli uomini all’interno della Da-reth fu dato da Mark Boveri: «Grossa massa davanti a noi, leggermente spostata sulla dritta. Sembra una grande cupola nera… opaca.»
Dalla Da-reth venne la conferma: «La vediamo distintamente anche noi sui monitor. Geen, senti niente?»
«Negativo. Nessuna presenza. Lì non c’è niente di vivo.»
Van Shennon disse: «Allora noi ci avviciniamo e facciamo un paio di giri, poi scendiamo. Sei d’accordo, Frank?»
«Affermativo. Tu Van te ne stai all’interno del modulo e copri Mark e Geen.»
«Bene. Ora siamo quasi sulla verticale. Come ti arrivano le immagini?»
«Sembra una costruzione… una cupola sfondata.»
Quando il modulo passò sull’altro lato dell’oggetto scoprirono che non si trattava di una cupola bensì di una superficie curva che emergeva dalla polvere come una grande ala nera, tozza e cosparsa di protuberanze angolose. Sorvolarono più volte l’oggetto, poi il modulo si posò pochi metri fuori dell’area coperta dalla grande ala. Vista dal suolo, le sue dimensioni apparivano colossali, almeno un centinaio di metri in altezza per altrettanti in ampiezza. La luce del riflettore penetrò all’interno dell’immensa caverna artificiale dove la parete nera sorgeva dalla polvere e si sviluppava in una gigantesca superficie a sbalzo sopra le loro teste.
E alla luce del riflettore apparvero una decina di aste.
«È un vero incubo.» Mormorò Emmerick a bordo della Da-reth fissando le immagini sul monitor.
«Sono uguali a quelle che avete visto voi?» Chiese Shennon.
«Come gocce d’acqua.»
«Allora noi scendiamo,» disse Mark Boveri, «Forza, Geen, si esce. E drizza bene le orecchie.»
Geen Benoit sorrise e seguì in silenzio il compagno. Erano esseri patetici i sensitivi. Risultato indiretto dell’ingegneria genetica usata su generazioni di esseri umani per gli scopi più diversi, essi portavano in sé una sensibilità estremamente sviluppata. La materialità del mondo agiva su di loro negativamente, ed essi ne subivano le conseguenze in misura tale che, se non venivano inquadrati in attività specializzate, non riuscivano a condurre una vita normale e superare i problemi e le angosce giornaliere. Nella grande maggioranza finivano suicidi. E coloro che, come Hans Ludqist e Geen Benoit, avevano un’attività ben definita, partecipavano alle azioni cui erano destinati con impegno e anche con entusiasmo, ma non riuscivano a inserirsi interamente nella sfera di comportamento “normale”, agivano con distacco e sembravano appartenere a una dimensione leggermente sfasata.
E forse era proprio così. Introversi, taciturni, ricettivi a ciò che stava al di là del concreto, potenziali artisti, stabilivano in modo naturale rapporti talmente stretti tra loro che spesso non esitavano a sacrificarsi l’uno per l’altro. Tra loro si riconoscevano subito. Col tempo avevano formato una specie di consorteria che agli occhi del mondo appariva un po’ ambigua.
In alcune situazioni e in determinati ambienti venivano perseguiti apertamente come conseguenza di una sorta di razzismo. Ci furono anche casi di incriminazione per avvenimenti di cui loro non erano assolutamente colpevoli. Ma, nella storia dell’uomo, c’è sempre stata la necessità di capri espiatori.
Geen Benoit seguì quindi di buon grado il compagno. Ognuno era armato di laser, ma non sarebbe stato certo il sensitivo a sparare per primo.
La grande ala nera si protendeva sopra le loro teste come un’immensa tettoia. Il riflettore del modulo era stato sistemato in modo che il cono di luce fosse il più ampio possibile per illuminare l’intera area coperta.
All’esterno l’aria diventava sempre più rossastra a mano a mano che uno dei due satelliti maggiori si alzava sull’orizzonte. La nebbia si stava dissolvendo, almeno nella zona intorno a loro. Il modulo, accanto alla gigantesca costruzione, sembrava un insetto.
Sotto l’ala nera c’era il silenzio più assoluto, anche il continuo sospiro provocato dal vento non riusciva a penetrarvi. Alte sopra di loro pendevano strutture apparentemente metalliche alcune delle quali, malgrado la loro origine aliena, sembravano danneggiate.
«Un relitto,» disse Boveri, «Queste strutture sono senz’altro parti di macchine, apparati… la massa sepolta sotto la polvere dev’essere gigantesca.»
I due erano giunti accanto alle aste. Solo pochi metri più in là la base dell’ala nera sorgeva dal suolo.
«C’è polvere smossa accanto alle aste.» Osservò Boveri. Poi si rivolse ai compagni sulla Da-reth: «Voi che avete più esperienza di me, che ne dite?»
«Sembrano orme della stessa natura, ma quelle che abbiamo visto noi erano fresche. Queste qui potrebbero risalire a chissà quando, non c’è azione di vento là sotto.» Disse Shennon.
Intervenne Emmerick: «Mark. lascia perdere e cerca di capire qualcosa di quell’affare nero.»
«Va bene, Frank. Ora ci accostiamo. Come va, Geen? Ancora nulla?»
Il sensitivo scosse la testa.
«Bene, almeno per il momento non abbiamo visite.» Commentò Boveri.
Più si avvicinavano alla parete nera, più emergevano i particolari della struttura. Quella che era sembrata in un primo momento una semplice superficie scura si era trasformata in una parete irta di strutture, di incavi, rientranze e sporgenze, fessure e ripiani e aperture che creavano un complicato gioco di incastri.
«Van!» Chiamò Boveri, «Restringi il cono di luce e puntalo in quell’angolo. Ci sono dei segni che sembrano caratteri.»
Era quanto restava di una scritta, segni di colore chiaro che potevano essere lettere o numeri o ideogrammi, qualsiasi cosa salvo un qualcosa di decifrabile. La prima impressione che quei segni davano era la loro totale alienità ma la certezza che quel relitto – o quello che era – fosse estremamente vecchio.
«L’unico dato certo è che siamo di fronte a un altro enigma.» Borbottò Boveri. Sia lui che Geen Ludqist usavano anche le loro torce personali per illuminare maggiormente la superficie circostante, le asperità.
Fu Geen a scoprire la profilatura vagamente triangolare.
«Guarda, Mark,» disse a bassa voce il sensitivo, «Sembrerebbe un portello.»
Mark Boveri si avvicinò. Un lato del triangolo era leggermente sollevato e formava una stretta fessura.
«Già, potrebbe esserlo,» confermò Boveri, «Un portello non del tutto chiuso, forse scardinato quando quest’affare è finito qui. Forse si tratta di un passaggio per entrare all’interno…»
«Un momento, Mark» intervenne Emmerick, «Sei sicuro che possa essere un accesso?»
«E chi può essere sicuro di qualcosa su questa palla di polvere? Però ci scommetterei la paga di un mese, Frank, secondo me da questa parte si entra. Il problema è come aprire del tutto il portello.»
«A che distanza sei dal modulo?»
«Una ventina di metri, forse venticinque.»
«Van, quanto cavo abbiamo sul verricello?»
«Siamo a posto, Frank, cinquanta metri. L’avevo pensato anch’io.»
«Bene, non voglio che il modulo sia spostato più vicino. Avanti con il verricello.»
«Ricevuto, Frank. Ora apri il contenitore così sfilo il cavo fino al portello.»
«Negativo. Tu te ne stai all’interno del modulo. Sfila il cavo e sarà Mark a venire a prenderlo.»
Mark si avviò subito verso il modulo mentre il ronzio del verricello echeggiava all’interno di quella sorta di hangar. Bastarono pochi minuti per stendere il cavo e fissare il gancio sul bordo del portello. Poi Boveri alzò l’indice e lo fece girare. Il cavo si stese, si sollevò da terra e fu messo in tensione. A seconda della velocità con cui Boveri faceva ruotare il dito Van Shennon regolava la velocità del verricello. Quando il cavo fu al massimo della tensione il dito di Boveri si mosse lentissimamente. E lentissimamente il portello cominciò a schiudersi. Quando esaurì l’arco di apertura consentito dalla posizione del cavo, Boveri aprì la mano. Shennon bloccò il verricello.
L’apertura non era granché ma senz’altro sufficiente per far passare un uomo. Subito Boveri diresse il raggio della torcia all’interno e altrettanto fece Geen.
«Qui non si vede niente ma abbiamo trovato la porta del castello. Adesso non resta che farsi annunciare al…»
«Un momento,» lo interruppe Emmerick, «Non ce ne andremo senza aver ispezionato quel… quell’oggetto, però dobbiamo studiare un piano. Allora, Van rimane nel modulo e vi copre con il riflettore puntato sul portello, voi due entrate ma dovete essere di ritorno entro dieci minuti esatti. In qualsiasi punto vi trovate o qualsiasi cosa vedete dovete calcolare il tempo del ritorno ed essere fuori non oltre i dieci minuti. In caso di difficoltà o interruzione delle comunicazioni Dan e Hans arrivano con il secondo modulo. È tutto chiaro?»
Conferma da parte di tutti.
«I dieci minuti cominciano da adesso. Mark, continua a parlare e descrivi anche a voce tutto quello che vedi e registri.»
Attraverso gli auricolari pervenne la voce di Mark Boveri mentre si addentrava cautamente nel corpo della misteriosa costruzione, seguito da Geen Benoit.
«È buio e silenzio, almeno a livello fisico. Tu senti qualcosa, Geen?»
«Ancora niente.»
«C’è una specie di corridoio… le pareti sono in condizioni migliori di quelle esterne ma sempre tappezzate di incavi e protuberanze… e hanno anche molte scritte… insomma quei segni che abbiamo visto fuori. L’aria è pesante e c’è un odore… niente, non saprei proprio come definirlo, lo sentirete da voi quando sarà il vostro turno. Non vedo prese d’aria, l’unica comunicazione con l’esterno sembra sia quel port…»
«Mark…» La voce di Geen Benoit aveva una nota ansiosa.
«C’è qualcosa, Geen?» Mark aveva puntato la torcia sul volto del compagno. Il sensitivo si teneva la testa stretta tra le mani, aveva gli occhi serrati e un’espressione di angoscia.
«Geen sente qualcosa! Sta male…»
«Fuori!» Ordinò Emmerick, «Mark, uscite subito e tornate al modulo! Sta pronto, Van, se vedi qualcosa che si muove tra te e loro tienila sotto tiro!»
«Ricevuto, Frank, adesso li vedo… stanno uscendo… o mio Dio! Cos’è quello!»
«Van, che succede? Sul monitor è inquadrato solo il portello…» E in quel momento, da bordo della Da-reth, videro i due uomini stravolti dall’orrore. Se ne stavano impietriti accanto al portello fissando con occhi sbarrati qualcosa sulla loro destra non inquadrata dalla telecamera. Poi sentirono il laser di Van Shennon e lui che urlava.
«Correte! Li tengo a bada io, presto… correte! Ma Cristo perché non vi muovete!»
Le scariche laser continuavano ma dall’interno della Da-reth non potevano vedere il bersaglio. I due uomini lasciarono il portello e si precipitarono verso il modulo. Sul monitor della Da-reth le loro figure sembravano non avvicinarsi mai nel gioco della prospettiva, poi uscirono fuori campo sul lato sinistro a mano a mano che si avvicinavano al modulo.
Dopo il grido di Van nessuno aveva più parlato, i soli rumori erano i sibili dei laser e quelli provocati da Mark Boveri e Geen Benoit che entravano nel modulo chiudendosi il portello alle spalle. La camera automatica continuava a inquadrare la scena: c’era il cavo teso che formava una linea leggermente arcuata fino all’apertura triangolare dov’era agganciato, una zona di terreno polveroso e lo sfondo costituito dalla massa nera dell’ala illuminata dal riflettore. Poi entrarono in campo due figure che non appartenevano all’equipaggio della Da-reth. Quando furono colpite dalla luce diretta del riflettore, i loro particolari furono messi in evidenza. Gli uomini a bordo della Da-reth boccheggiarono. Le due figure procedevano verso il modulo ergendosi e stirandosi su una serie di arti filiformi estremamente flessibili che fuoriuscivano dalla parte inferiore del corpo come matasse. La struttura del corpo appariva metamaterica e ricordava gli artropodi. Anche il dorso, di colore più scuro, richiamava lo strato chitinoso che riveste quel tipo di invertebrati. La parte superiore era formata da un complesso di tubuli intrecciati, un viluppo apparentemente gelatinoso che alla luce del riflettore faceva intravedere all’interno un brulicare di globuli scuri.
Il laser colpiva malgrado la comprensibile imprecisione di Van Shennon, ma sembrava non recare danno eccessivo a quei due esseri che, al più, venivano impediti nel loro avanzare ritmico. Uno dei due mancava in larga parte di ciò che appariva come un dermascheletro, ma quella mutilazione non era stata causata dalle scariche dei laser.
Da quando la mente di Geen Benoit aveva avvertito qualcosa era passata una manciata di minuti durante i quali l’equipaggio della Da-reth si trovava ad affrontare una situazione al di fuori di ogni schema prevedibile. Intanto i due esseri continuavano ad avanzare. Mark Boveri aveva subito affiancato il compagno sparando con il laser al massimo dell’energia, ma ormai era chiaro che le armi non servivano. Geen Benoit si era abbattuto sul fondo del modulo, sopraffatto.
Quando i due esseri furono a qualche metro dal modulo, Van Shennon perse il controllo e si precipitò ai comandi mettendo in funzione i getti. Mark Boveri si accorse troppo tardi di quanto stava facendo il compagno e urlò. Ormai il modulo aveva cominciato ad alzarsi. Si sollevò con un balzo brusco in una nube di sabbia e subito dopo s’inclinò sul lato sinistro trattenuto dal cavo ancora fissato. Il gancio scivolò e il cavo scattò sferzando l’aria. Il modulo continuò ad alzarsi ma ormai la sua traiettoria era stata modificata, e Van Shennon non era più in grado di manovrare. Anziché sollevarsi al di là della grande ala nera vi andò a sbattere contro e precipitò al suolo.
Dalla Da-reth avevano potuto seguire la scena trasmessa attraverso la telecamera esterna, avevano visto la superficie allontanarsi quando il modulo si era alzato, avevano visto il cavo serpeggiare impazzito per una frazione di secondo, quindi una lastra nera aveva coperto lo schermo. Poi c’era stato l’urlo di Mark Boveri e tutto era scomparso nel fragore della caduta.
«Sul modulo, presto!» Disse Emmerick dopo un attimo di mutismo incredulo.
Il secondo modulo con Daniel Whitmore e Frank Emmerick si staccò dall’astronave e si diresse alla massima velocità sul luogo del disastro. Quando fu sopra il relitto, il riflettore illuminò una scena agghiacciante: il modulo era capovolto e schiacciato. Uno dei getti era ancora parzialmente in attività e sotto la grande struttura nera la sabbia vorticava a creava mulinelli. Dalle lamiere della cabina usciva la parte superiore del corpo di Van Shennon. A poca distanza i due esseri alieni, immobili, sembravano contemplare quello strazio. Il motore ancora acceso faceva vibrare il relitto e creava un frastuono insolito, amplificato, echeggiante.
Non servirono parole per dividersi i compiti, tutto era già stato pianificato durante il breve percorso. Mentre Daniel Whitmore spazzava con il laser la zona dove si trovavano i due alieni seminascosti dai vortici di sabbia, Frank Emmerick si precipitò verso il relitto. Hans Ludqist era rimasto a bordo della Da-reth per evitare che la sua mente venisse compromessa.
Bastò un’occhiata per capire che Shennon non aveva più bisogno di alcun aiuto. Soffocando l’istinto di fermarsi accanto al compagno perduto in modo così improvviso e drammatico, Emmerick si portò sull’altro lato della macchina. Mark Boveri stava cercando di estrarre dalle lamiere il corpo di Geen Benoit. Benché la tuta di Boveri fosse strappata e macchiata di sangue, non sembrava che egli avesse subito ferite gravi. Il sensitivo era esanime. Emmerick interrogò Boveri con lo sguardo.
«Solo svenuto!» Gridò Boveri per superare il frastuono del motore, «Troppa pressione sul cervello!» La tuta di Benoit era intrisa di sangue in misura vistosa lungo il braccio sinistro.
Dal portello spalancato del secondo modulo il vecchio Dan Whitmore continuava a sparare a tratti nel turbinio della sabbia e urlando ai compagni di fare presto. Quando li vide avvicinarsi smise di sparare e si precipitò alla console di comando. Il vecchio astronauta manteneva una calma sorprendente. Emmerick salì sul modulo e Mark Boveri sollevò il sensitivo per le ascelle. Emmerick lo prese e lo trascinò all’interno.
Pur agendo con velocità e coerenza non mancavano di tener d’occhio la nuvola di sabbia che li circondava, consci che da un momento all’altro i due alieni avrebbero potuto riapparire. Mark Boveri saltò all’interno del modulo. Nel momento in cui si afferrò al corrimano Whitmore diede il massimo di spinta e il modulo schizzò in verticale in un ribollire di sabbia.
Tutto si era svolto in una manciata di minuti.
Whitmore fece in silenzio una larga curva e puntò sulla Da-reth. Sotto di loro i due relitti, quello alieno, gigantesco e nero, e quello minuscolo del modulo, svanirono nella luce ormai scarsa.
Il pensiero di Emmerick e di Whitmore e di Boveri era rivolto al loro compagno rimasto tra i rottami. E il dolore per quella perdita veniva stravolto dalla necessità di lasciare il suo corpo alla mercé di quelle abominazioni.
Il modulo sorvolò a volo radente la superficie ormai buia. Apparso come un immenso deserto, quel pianeta stava dimostrandosi un nemico feroce. Quando furono all’interno della Da-reth si sentirono a casa.
Adesso sulla piana era ormai notte, una notte dall’inquietante luminescenza rossastra che sarebbe durata ventun ore.
* * *
«Non mi risulta che a quel tempo i sensitivi facessero già parte degli equipaggi.» Osservò Boveri
«Infatti.» Confermò Whitmore.
A bordo della Da-reth gli uomini stavano preparandosi ai turni di guardia e commentavano le informazioni date dal computer sulla prima spedizione.
Il comandante dell’astronave superstite Vega, quel Pat Wheaver che aveva trasmesso alla Terra le allucinate impressioni su QD-3391, aveva parlato delle incomprensibili reazioni dell’equipaggio durante il sonno. Descriveva il fatto come una sorta di trance durante la quale i suoi compagni compivano azioni insensate, quasi si trasformassero in bambini inconsapevoli delle conseguenze che avrebbero provocato.
Pat Wheaver aveva trasmesso quelle informazioni alla Terra perché ormai certo che non vi avrebbe più fatto ritorno: lasciarle registrate solo sul libro di bordo sarebbe stato inutile. Secondo il rapporto risalente a 173 anni prima, un suo compagno si era recato nella cabina di comando e con gioia fanciullesca aveva tentato di distruggere i sistemi. Parlava di una forza che cancellava i freni inibitori dell’Ego e faceva riaffiorare le profonde esigenze dell’inconscio istintuale. Informazioni vaghe, che sarebbero state giudicate frutto di una mente squilibrata se loro stessi non avessero vissuto di persona gli avvenimenti di quelle terribili ore.
«Dal che si deduce,» continuò Mark Boveri, «Che su questo pianeta qualcosa agisce sulla mente umana, e i nostri sensitivi ne risentono in maniera traumatica.»
Geen Benoit non si era ancora ripreso completamente. Assieme a Frank Emmerick e a Mark Boveri sarebbe rimasto a bordo mentre gli altri due avrebbero fatto il primo turno di guardia di quattro ore. Poiché i sistemi di allarme diretti dal computer non erano affidabili era stato deciso di tenere sotto controllo diretto una fascia di terreno intorno alla Da-reth.
«Non più lontano di cinquanta metri.» Ricordò Emmerick.
I due uomini scesero sulla superficie. Si diressero in direzioni opposte, guardinghi, l’arma pronta a far fuoco. E con un’angoscia che non riuscivano a scacciare. In quel momento non c’era traccia di nebbia. La notte aveva la luminescenza di certe località all’estremo nord della Terra, solo che qui era rossastra.
In cielo ricomparve il terzo satellite, quel ciottolo che rotolava basso e veloce, incredibilmente lungo un’orbita la cui altezza non era compatibile con la densità dell’atmosfera e la forza gravitazionale del pianeta. Per pochi istanti fu illuminato dalla luce della stella, poi entrò nel cono d’ombra e scomparve.
La prima ora passò tesa, gonfia di sensazioni e di falsi allarmi. La seconda fu più tranquilla, e ci fu anche qualche scambio di battute. A metà della terza ora arrivò pigramente un banco di nebbia. All’inizio era una leggera foschia, poi divenne più denso, e in pochi minuti i due uomini e la Da-reth furono contornati dagli ormai familiari ghirigori grigi che fluttuavano lenti e ipnotici trascinati dall’alito che correva instancabile la superficie del pianeta.
L’angoscia cominciò ad attanagliare nuovamente gli uomini.
Hans Ludkist avvicinò il polso alle labbra: «È strano,» disse, «Ho percezioni visive che sono solo formazioni di nebbia ma niente di mentale… per la prima volta da quando ci siamo avvicinati a questo pianeta ho la mente completamente libera.»
Tornò il silenzio.
L’urlo di Hans Ludkist arrivò quando mancavano due minuti al termine della terza ora.
«Dan!» Gridò subito Emmerick, «Non muoverti dal tuo posto. Occhi aperti ma rimani dove sei. Hans! Arriviamo!»
Emmerick e Boveri scesero dall’astronave e si diressero verso la postazione del sensitivo. Lo trovarono in preda a shock. Boveri si allontanò di pochi passi, poi si arrestò di colpo. Sulla polvere c’erano tracce che si allontanavano nella nebbia.
«Frank, guarda qui.»
Emmerick osservò le tracce, poi si passò il dorso della mano sulla fronte. «Si tratta di quelle?» Chiese a Hans che, muto, seguiva i loro movimenti. Il sensitivo accennò di sì con la testa.
«Cos’hai visto esattamente?»
«Shennon.»
Emmerick e Boveri si guardarono. «Che hai detto?» Giunse la voce di Whitmore, «Ho capito bene, Hans? Hai detto di aver visto Van?»
«Non muoverti dal tuo posto, Dan,» ordinò Emmerick, «Forza, Hans, dicci cos’hai visto veramente.»
«Credevo fosse una delle solite allucinazioni causate dalla nebbia… invece era lui… tutto schiacciato e coperto di sangue raggrumato… oddio Frank! Andiamo via da questo posto! Subito… andiamo via!»
«Sei sicuro di non aver visto uno di quei… di quegli esseri che…»
«No, assolutamente. Quello era Van Shennon, mi ha guardato e aveva un’espressione di dolore… di pena… aveva il petto schiacciato orrendamente ma gli occhi… Dio! Quegli occhi!»
Negli auricolari ci fu come un gorgoglio.
Hans continuò: «Sembrava volesse parlarmi… tentava di alzare l’unico braccio che gli era rimasto… poi scomparve nella nebbia…»
«Aaiut… aaghh…» Negli auricolari.
«Dan! Dan! Rispondi!»
Un ansare, un rantolo.
«Rimani con Hans.» Emmerick si allontanò dirigendosi verso la postazione di Daniel Whitmore. Lo trovò riverso sulla sabbia. C’erano tracce di passi intorno al suo corpo.
«Frank! Tutto a posto?» Era Boveri, «Frank!»
«Tornate a bordo! Subito!»
«Che cosa… cosa è successo a Dan!»
«A bordo ho detto! Sto arrivando anch’io.»
Più tardi, nel modulo di comando della Da-reth, i quattro uomini superstiti stavano osservando muti una piastrina di riconoscimento ossidata dal tempo. Già il fatto che quella piastrina, così normale, così terrestre, fosse lì, era sconvolgente. Ma, forse, la misura non era ancora colma. Si intravedevano segni che un’accurata pulitura del metallo aveva rivelato essere lettere della loro lingua. C’era una O e una doppia R, e poi una N che poteva anche essere una M, e una F che poteva anche essere una E. L’ultima lettera era completamente cancellata ma la penultima era sicuramente una O. La parola intera, trascritta su un pezzo di carta, risultava …ORR…N(M)…F(E)…O
I quattro uomini non riuscivano a nascondere l’angoscia.
Daniel Whitmore era stato strangolato da qualcosa uscita dalla nebbia e in essa subito scomparsa. Aveva lasciato tracce sulla sabbia, le stesse tracce trovate vicino a Hans Ludkist, le stesse che giravano intorno alle dune e accanto alle aste. Adesso erano rimasti in quattro. Avrebbero potuto essere in tre perché Hans Ludqist aveva corso il pericolo di fare la stessa fine di Daniel Whitmore. Lui diceva di aver riconosciuto il cadavere di Van Shennon… un’assurdità. Ma quale logica poteva esserci su quel pianeta?
Verificare l’asserzione di Hans sarebbe stato facile, bastava tornare al relitto: se il corpo di Van era ancora incastrato lì sotto, Hans si era sbagliato. Ma l’idea era stata scartata, troppo pericoloso. Almeno per il momento. E poi… se non avessero trovato il corpo? Nessuno aveva fatto questa ipotesi ad alta voce. Quella piastrina era una prova che chi si aggirava intorno e lasciava tracce non apparteneva agli esseri artropodi e, forse, non era affatto alieno.
A questa conclusione erano arrivati tutti e quattro indipendentemente l’uno dall’altro anche se la logica si rifiutava di accettare quella probabilità. Per questo ognuno teneva dentro di sé certe conclusioni, perché quella piastrina era stata trovata nel pugno di Dan Whitmore, strappata nella colluttazione con chi lo aveva ucciso.
Fu Emmerick a rompere il silenzio dopo aver guardato gli altri e avuto conferma dai loro sguardi che tutti pensavano alla stessa cosa. «Va bene, Mark, fatti dare gli equipaggi della prima spedizione.
Mark Boveri interrogò il computer, e sul monitor scrosciarono i nomi:
Equipaggio della nave da esplorazione Vega
* Pat Wheaver (comandante)
* Dudley Hustin
* Lorry Anderson
* Eb Doyle
* Cliff Donovan
Equipaggio della nave appoggio Orione
* Peter Hustin (comandante e fratello di Dudley Hustin)
* Mike Shepleton
* Vaco Ramirez
* George Mancuso
* Burt Mallory
Seguì un lungo momento di silenzio durante il quale gli occhi dei quattro uomini erano fissi sullo schermo. Poi Geen Benoit mormorò: «Non è possibile.»
Mark Boveri disse: «Frank, pensi anche tu che possa essere la sola spiegazione?»
Frank Emmerick non rispose. Adesso il suo sguardo si era spostato sulla piastrina. Poi disse a bassa voce, quasi a sé stesso: «Si potrebbe pensare a qualcosa che vive su questo pianeta e se ne sia… impossessato…»
Era chiaro che si trattava di un estremo tentativo di autoconvincimento. Perché la N sulla piastrina era proprio una N, e la F era in realtà una E. E quelle lettere erano al posto giusto per formare il nome di Lorry Anderson, uno degli uomini della Vega, la nave arrivata su quel pianeta 173 anni prima e mai più ripartita.
Il resto della lunga notte di ventun ore trascorse all’interno della Da-reth. Dai monitor non pervennero immagini sconvolgenti, solo banchi di nebbia che apparivano e svanivano trascinati dall’eterno alito di vento. Ma prima che quella lunga notte fosse finita il pianeta riservò un’altra sorpresa ai quattro uomini, anche se non riguardava strettamente il pianeta stesso: Gen Benoit e Hans Ludqist percepirono contemporaneamente un netto richiamo proveniente dal piccolo satellite, un richiamo questa volta per niente doloroso o traumatico, ma imperioso.
«Non c’è ostilità,» assicurarono i due sensitivi, «Non c’è traccia di quanto abbiamo percepito finora. Però dobbiamo andare, è lassù che troveremo la risposta alle nostre domande.»
Mancava poco all’alba. Il modulo si staccò dalla Da-reth e si immise su una traiettoria che l’avrebbe portato a incontrare il masso che vorticava intorno a QD-3391, il più piccolo dei tre satelliti. E che probabilmente non era un normale satellite.
* * *
Come una mosca su un sasso.
Questa era l’immagine che si era formata nella mente di Frank Emmerick mentre erano in avvicinamento al satellite, una grossa roccia sulla quale il modulo si sarebbe posato. Ma ci sarebbe stata gravità sufficiente per mantenerlo agganciato? E una volta sbarcati, come avrebbero potuto spostarsi in quell’ambiente che preannunciava una quasi imponderabilità?
I due sensitivi percepivano sempre più forte il richiamo provenire dalla roccia, e la loro ansia adesso era angosciosa ma, questa volta, come per una trepida attesa. A mano a mano che si avvicinavano al minuscolo satellite i due sensitivi si chiudevano sempre più nel loro mondo particolare fatto di sensazioni alle quali gli altri erano refrattari. Infine i loro occhi non videro più nulla benché fossero aperti, erano entrati nella dimensione in cui poteva realizzarsi un contatto con le entità che dirigevano quel mondo bizzarro e allucinante.
Del tutto inaspettata – ma ormai cosa poteva essere prevedibile? – la gravità risultò essere simile a quella di QD-3391 benché la superficie del satellite fosse priva di atmosfera. Quella gravità avrebbe potuto trattenerla… sempreché fosse stata prevista l’esistenza di un’atmosfera. Fu quindi necessario usare le tute e i caschi. Questa necessità influì negativamente dal punto di vista psicologico su Emmerick e Boveri: non sapendo con chi o che cosa avessero a che fare, avrebbero preferito disporre di una maggiore libertà di movimento. C’erano le armi, d’accordo, ma potevano servire? Forse solo come psicoprotesi.
I due sensitivi si erano subito diretti verso un punto ben preciso. Agivano affiancati, muti, nel pieno delle loro possibilità. Emmerick e Boveri li seguivano a pochi passi, le armi pronte, lo sguardo che si spostava continuamente sul paesaggio bianconero. Tutto ciò che non veniva colpito dalla luce della stella lontana si confondeva con il nero dello spazio, e tutto ciò che ne era illuminato appariva come un comune angolo di montagna terrestre senza però la minima traccia di vegetazione, solo roccia sulla quale avevano lavorato milioni di anni, accidentata e butterata in anfrattuosità, martoriata da fenditure. Ed era verso una di quelle fenditure, che apparivano come una rete nervosa, dove i due sensitivi erano diretti.
Ma tutto questo apparteneva ormai al passato. Adesso i quattro uomini si trovavano all’interno della Da-reth, e il sistema di QD-3391 con i suoi tre satelliti era scomparso frammischiato alla miriade di luci cosmiche. Stavano tornando a casa. E i due sensitivi registravano quanto era avvenuto dal momento in cui il satellite li aveva chiamati.
Geen Benoit e Hans Ludqist parlavano alternativamente ma era come se parlasse uno solo di loro. Parlavano usando quello strano stile comune a tutti i sensitivi quando registrano le loro intrusioni in dimensioni precluse agli esseri umani comuni. In quelle parole c’era la spiegazione dei fatti misteriosi accaduti non solo all’equipaggio della Da-reth ma anche agli equipaggi della Orione e della Vega. Per quanto fosse stato possibile tradurre in parole comprensibili, era la storia di un popolo che in un passato lontanissimo aveva abitato il pianeta chiamato QD-3391 e subìto l’invasione e l’annientamento da parte di una razza intelligente proveniente dalle profondità cosmiche ma inconcepibilmente aliena, almeno per quanto riguarda tutto ciò che rientra nella sfera dell’umano, impermeabile anche alle facoltà di comprensione dei due sensitivi.
Quando, dopo la partenza degli invasori, i pochi sopravvissuti stavano per estinguersi apparve un essere solitario e misterioso. Da quanto i due sensitivi poterono intuire si trattò di una teofania, una sorta di materializzazione proveniente forse da un’alternativa spaziotemporale, da una dimensione incomprensibile. Quell’essere solitario dette ai pochi rimasti la conoscenza e la possibilità di comunicare con la mente. Rimase su QD-3391 il tempo necessario per raccogliere intorno a sé tutti i superstiti, di dar loro inconoscibili facoltà e di infondere una nuova speranza. Poi scomparve. Ma prima promise che un giorno sarebbe tornato per vedere se erano riusciti a far fruttare i doni ricevuti, a svilupparsi e moltiplicarsi nel suo ricordo, a salvarsi dall’estinzione e dai pericoli provenienti dallo spazio. Se tutto ciò si fosse realizzato, li avrebbe portati con sé su un pianeta dove il pericolo era sconosciuto.
Il tempo era trascorso, la vita su QD-3391 aveva ricominciato a fiorire, la conoscenza acquisita si era sviluppata in misura imprevedibile affinandosi talmente da raggiungere una simbiosi tra scienza, tecnologia applicata e potere della mente. Fu sondato lo spazio, furono scoperti numerosi mondi abitati da esseri senzienti dove, con il trascorrere del tempo, quel nuovo popolo migrò. QD-3391 rimase un pianeta deserto ma fu trasformato in un santuario. E per evitare altre aggressioni fu catturato un asteroide e agganciato in un’orbita stabile diventando il terzo satellite, un satellite diverso da quelli naturali perché al suo interno una piccola rappresentanza di quell’antichissimo popolo si era installata formando un nucleo di difesa e per attendere l’essere che li aveva salvati e dimostrare che il suo messaggio era stato osservato.
Da lassù continuarono a spiare la superficie di QD-3391 diventata un unico deserto di sabbia percorso da correnti che trasportavano perenni banchi di nebbia. Qua e là apparivano solo i resti di quanti nel frattempo erano giunti dallo spazio e non erano più ripartiti, resti di macchine e di esseri incomprensibili venuti per prendere possesso, per conquistare. Dal piccolo insignificante satellite le sentinelle tenevano sotto controllo chi si avvicinava, e quando un certo confine veniva superato, cominciavano a intervenire sui sistemi e sulle menti. Non potevano permettersi di lasciar passare chi poteva rappresentare l’avanguardia di altre invasioni. Però lasciavano due alternative: lasciare quel quadrante spaziale o atterrare su QD-3391 per riparare i danni e andarsene.
La seconda fase era diretta sugli equipaggi che riuscivano ad atterrare felicemente. A loro avrebbe pensato un esercito orrendo formato dai corpi di coloro che erano morti durante la prima invasione. Comandati dal satellite, si presentavano ai nuovi venuti e bastava la loro incerta apparizione nella nebbia per minare ogni volontà. I difensori di QD-3391 potevano intervenire sui visitatori anche direttamente dalla loro base sospesa intaccando il meccanismo che governava le loro menti, e lasciare che il deterioramento si sviluppasse da solo a seconda delle diverse caratteristiche psicologiche. Così era successo agli uomini della Orione e della Vega, ritornati bambini incoscienti, felici di distruggere i sistemi per vedere come erano fatti ridando libero sfogo all’inconscio istintuale tenuto soffocato dall’Ego.
Con il tempo i relitti delle astronavi provenienti dallo spazio si erano moltiplicati, venivano coperti dalla sabbia, e aumentava anche la popolazione silenziosa e immobile che riposava sotto quella stessa sabbia, e così corpi diversissimi si aggiunsero a quelli autoctoni a rinforzo di un esercito sempre più terrificante. A segnare i luoghi dove i corpi riposavano c’era il simbolo dell’artefice della loro salvezza: un triangolo attraversato da una lunga retta. Sotto quel segno, esseri provenienti da qualsiasi parte del cosmo si trovarono affratellati nella morte fisica, gli uni accanto agli altri, per un fine comune: attendere il ritorno di chi aveva evitato l’estinzione di una forma di intelligenza.
Era una storia crudele e bellissima che a volte veniva spiegata se si presentavano forme di vita in grado di poterla comprendere fin nella sua essenza. Con la Da-reth erano arrivati due esemplari in grado di farlo e in possesso della chiave per poter capire certi misteri del continuum spaziotemporale. Nello stesso modo in cui, grazie alle loro facoltà spicometriche, potevano percepire anche la linea cronotopica di qualsiasi corpo, quei due esseri avrebbero potuto risalire alle origini della storia e comprendere.
Adesso Geen Benoit e Hans Ludqist quella storia la stavano registrando con parole umane.
Quando gli uomini della Da-reth erano tornati dal satellite, non era più stato necessario controllare il computer, non avrebbe più dato allarmi ingiustificati. L’astronave aveva quindi abbandonato quel pianeta dove la notte dura ventun ore e dove spira continuamente un vento leggero che stende su tutta la superficie macchie di nebbia.
I corpi di Daniel Whitmore e di Van Shennon adesso facevano parte dell’esercito di difesa come ne facevano parte da 173 anni terrestri gli equipaggi della Vega e della Orione. E poi c’erano i morti viventi di chissà quanti altri pianeti. Tutti avrebbero contribuito a mantenere la promessa, permettendo così ai discendenti di QD-3391 di migrare sul pianeta dove non esiste pericolo, quale ricompensa per aver mantenuto vivo il ricordo dell’essere misterioso e solitario e aver diffuso nel cosmo il messaggio della sua esistenza.
Renato Pestriniero
Renato Pestriniero, veneziano, sposato, una figlia. Fino al 1988 capo reparto presso la filiale veneziana di multinazionale svizzera. Dal suo racconto “Una notte di 21 ore” il regista Mario Bava ha tratto il film “Terrore nello spazio.” Esperienze televisive, radiofoniche, fotografiche e figurative.