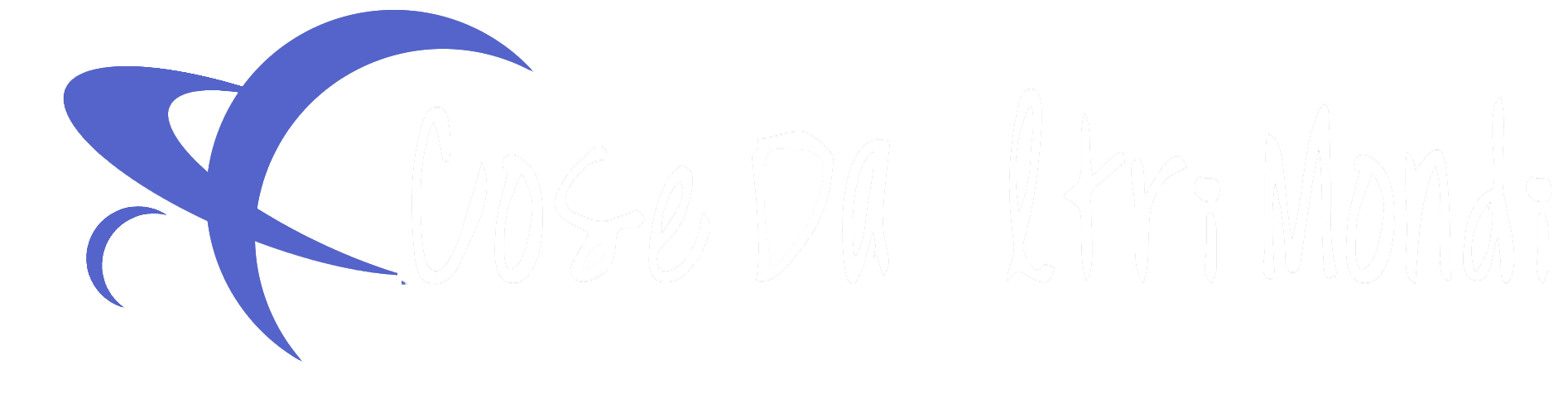DELIRIO, DI ADALBERTO CERSOSIMO

La copertina è World © di Roberta Guardascione
disegnata appositamente per Cose da Altri mondi.
Scelti dal Direttore
Se moriamo, non piangete:
il nostro è un mestiere
pericoloso, ma lo spazio vale una vita.
Virgil Grissom
Stava sognando. Non poteva essere capitato proprio a lui.
Questo fu il suo primo pensiero lucido dopo la confusione degli istanti immediatamente seguenti al risveglio.
Roteava sul proprio centro di gravità. Mosse un braccio. Non ottenne altro risultato che di accelerare il moto rotatorio. Un lampo di luce, una sfera azzurra e accecante e accanto una grigia più piccola. Ancora il lampo di luce accecante: una rete di maglie luminose, una ragnatela di punti fosforescenti. Al centro della ragnatele Lui. Solo.
Era solo, perso nello spazio, chiuso nel fragile guscio di una tuta. Il lampo di luce gli ferì gli occhi attraverso il vetro schermato del lunotto del casco.
A ogni giro su se stesso, poteva vedere avvicendarsi in una fantasmagorica girandola di ombre e luci, il sole, poi la terra e la luna, le stelle.
I pensieri ritornavano, e con essi i ricordi, nella parte cosciente della mente: “La nave è esplosa; il dispositivo di salvataggio mi ha catapultato incolume nello spazio.”
“Sono solo nello spazio, senza che nessuno sappia quello che mi è accaduto!”
Ora ricordava con chiarezza i momenti prima dell’incidente. Aveva chiamato la base lunare per ricevere conferma della rotta, come era solito fare a ogni viaggio di ritorno verso la Terra. Dalla base aveva ordinato di fare una correzione della traiettoria; poi erano stati forniti i dati necessari.
Qualcosa non doveva aver funzionato all’istante dell’accensione dei reattori.
L’accelerazione lo aveva schiacciato contro il sedile; le spie luminose sul cruscotto scandivano ritmicamente i secondi: due, tre, quattro secondi… poi il ritorno alla coscienza solo nello spazio.
“Per quanto tempo sono rimasto svenuto?” La domanda esigeva una risposta che era di importanza vitale: quanto ossigeno poteva ancora avere?
Conosceva tutte le storie che gli spaziali narravano sulla morte gelida nello spazio. Spesso anche lui le aveva raccontate ai nuovi arrivati: “Una morte terribile. Diversa da tutte quelle conosciute. Mentre il naufrago trattiene il respiro per prolungare la disponibilità di ossigeno, prega che lo vengano a cercare, che non lo lascino così, senza nemmeno una speranza. Basterebbe il conforto di una voce ad alleviare la sofferenza; ma negli auricolari del casco non c’è che il borbottio delle scariche. Il termostato della tuta si raffredda; dopo alcune ore, quando pure sta per finire l’ossigeno, il naufrago sente nel corpo la morsa del gelo inconcepibile dello zero assoluto.”
“Meglio strappare il condotto dell’ossigeno e farla finita in un istante,” aveva detto un suo collega alla base di Marte.
Non era un sogno. Alla sua sinistra, quasi sotto di lui, scorgeva a ogni rotazione la sfera verde-azzurra del pianeta.
“Come un palloncino appeso sotto un portico per rallegrare una festa d’estate,” pensò. Improvvisa lo colse la nostalgia lancinante dell’aria e delle stagioni della Terra ricca di profumi, frementi di vita e di sensazioni, che da tempo non provava.
Allora urlò di malinconia e di dolore.
Urlò, imprecò, maledisse , invocò, poi maledisse ancora. Rise di un riso che portava con sé tutta l’amarezza della solitudine.
“Un caso! Una volta su un milione! Il massimo dell’improbabilità! Avrebbero detto che era stato fortunato, se l’incidente fosse capitato mentre si distaccava da un’orbita circum-terrestre. Il dispositivo di sicurezza aveva funzionato perfettamente, nel momento in cui la nave si disintegrava.”
Era una cosa quasi impossibile. Un vero colpo di fortuna.
È difficile per un pilota sopravvivere alla nave che esplode. Se non si fosse trattato di un incidente improvviso, avrebbe fatto in tempo ad avvertire la stazione lunare prima di catapultarsi fuori. Lo sarebbero venuti a cercare, lo avrebbero tratto in salvo.
Era vivo, condannato a una morte infinitamente peggiore.
Dalla base lunare non si erano forse neppure accorti dell’incidente. Anche se se ne fossero accorti, nessuno avrebbe mai pensato che il pilota era sopravvissuto.
“Perché non mi venite a cercare? Sono vivo! Capite?”
“Aiutatemi, vi prego… non lasciatemi morire così come un cane!” La voce ritornò distorta e amplificata alle orecchie come l’eco in una gola montana. La portata della radio della tuta era troppo limitata, nessuno lo poteva udire.
“Mi sentite? Qualcuno mi ascolti, per favore. Non lasciatemi solo… non lasciatemi… SOLO!”
Respirò a fondo. Bevve l’ossigeno ed era un assetato che si buttava su una sorgente dopo un lungo cammino.
“Maledetti, perché non mi venite a cercare?” Una risata gli gorgogliò in fondo alla gola.
Quanti sogni aveva fatto il giorno del brevetto! C’erano stati gli applausi. Una sala era gremita di gente. E i discorsi dei generali, dei politicanti.
“Gli uomini della nuova frontiera, coloro che apriranno alla Terra la via delle stelle… Non vi saremo mai sufficientemente grati.”
“Vigliacchi! Che cosa ve ne importa di noi? Dov’è tutta la vostra gratitudine?… perché non mandate qualcuno a cercarmi?” I pensieri ora gli vorticavano nella mente sovrapponendosi in una sequenza di immagini che destavano ricordi sopiti, sensazioni da tempo dimenticate.
Vide le nubi azzurre e viola giocare al tramonto sulle sabbie marziane; gli sembrò di sentire gli eterni venti di Marte frusciare sulle dune. Sfilarono davanti ai suoi occhi le verdi distese di ghiaccio di Urano e già l’immagine si confondeva mentre i vulcani di Giove fiammeggiavano sopra i ribollenti fiumi di ammoniaca.
Era la fine dell’estate sulla Terra quel giorno.
Si erano fermati al lato del sentiero per riposare, dopo la lunga marcia tra i boschi di larici e di abeti. Erano felici e lo si sentiva dal tono allegro delle voci. Lui l’aveva aiutata a togliersi lo zaino dalle spalle e si erano seduti accanto a una roccia ricamata di licheni verdi e bruni. Guardavano le nuvole passare sopra le cime degli abeti e il cielo era un limpido lago azzurro.
Ora lo teneva stretto per mano come pervasa dal timore che lui volesse sfuggire. L’aveva condotto verso gli alberi, dove il bosco era più denso e il terreno diveniva un elastico soffice tappeto di aghi bruni.
La voce dei compagni giungeva ovattata alle loro orecchie in quell’universo di lunghe ombre verdi, immerso in un pulviscolo di polvere dorata.
I suoi capelli avevano il profumo delle bacche di ginepro e le labbra il sapore dolce e acre delle mele acerbe e il suo amore per lei era stato più forte di quello per lo spazio.
La luce cruda dei riflettori illuminava a giorno la spianata dello spazioporto, cancellava le stelle in alto, il resto del mondo attorno.
Avanzavano nell’abbacinante lume bianco-azzurro e mai come in quei momenti la solitudine li mordeva dentro il petto. Avanzavano stretti nelle tute, ciascuno solo con i propri pensieri, verso la nave che torreggiava davanti a loro.
– Non andare – lei aveva detto. – C’è posto anche per te qui sulla Terra. Avanzava sotto la luce spietata con nella mente il ricordo dolce di lei e nelle orecchie il suono delle sue ultime parole.
La camera era candida, pregna dell’odore sgradevole dei medicinali. Il dottore stava in piedi accanto al letto con le mani affondate nelle tasche del camice.
“Te la sei vista brutta, ragazzo!”
Il medico scuoteva impercettibilmente il capo.
“Tutto quel tempo esposto alle radiazioni solari con la sola protezione di una tuta normale. Oh, ti daranno una medaglia per questo! Se non riparavi in tempo l’ugello del reattore, sareste finiti con la nave dentro la corona solare.”
Si era avviato alla porta per uscire, poi era tornato sui propri passi. “Vuoi che avverta qualcuno? Parenti, amici, tua moglie?”
“Non sono sposato, dottore.”
Aveva scosso di nuovo la testa.”Meglio così. Sarebbe stato più difficile dirtelo. Sei rimasto troppo a lungo esposto alle radiazioni senza un’adeguata protezione; sei diventato sterile, ora.”
I ricordi tornavano e fuggivano come onde di una risacca marina mentre vagava nel silenzio dello spazio.
Qualcosa brillò vivido per un ingannevole istante nel baratro profondo che gli si stringeva attorno.
Un’astronave?
Il cuore impazzì in petto. Pregò di non essersi sbagliato, di aver visto giusto. Un nodo di commozione lo serrò alla gola.
Di nuovo quel riflesso improvviso che non era la luce di una stella.
Guardò l’oggetto che rifletteva i raggi del sole. Veniva verso di lui.
Commozione, gioia, riconoscenza; un magma di sensazioni gli traboccò dentro.
“Mi avete sentito. Non mi abbandonate!”
“Oh… vi ringrazio… vi ringrazio… vi…”
“Ma perché non mi chiamate? Mi sentite? Mio Dio, parlatemi… dite qualcosa. Non resisto… non ce la faccio PIÙ.”
Nessuna voce umana giungeva attraverso gli auricolari ad alleviare la sua sofferenza. Solo il silenzio e a tratti le scariche attutite, incostanti, simili a voci di un temporale lontano.
“No! non parlate… ho capito! Solo la mia trasmittente funziona; voi mi potete ricevere mentre io non posso sentirvi… lo so, vi state affannando per dirmi che arrivate.”
“Vi ho visto, state tranquilli… Ma fate presto, mio Dio. Non so quanto ossigeno mi rimane.”
La nave si avvicinava con una traiettoria costante. Presto ne avrebbe intersecato la rotta.
Allora sarebbero usciti per prenderlo a bordo e la sua agonia sarebbe finita. Avrebbe respirato a pieni polmoni l’ossigeno, assimilando a ogni sorsata un nuovo istante di vita.
Per qualche attimo la nave scomparve alla sua vista, mentre compiva una rotazione su se stesso. Quando la rivide era molto vicina e rifletteva con la sua superficie metallica i raggi del sole. Non urlò. Non ne aveva più la forza.
Ma gli occhi gli si riempirono di lacrime, impedendogli così la vista.
Il relitto metallico lo sfiorò silenziosamente, galleggiando nel nulla. Un rottame della sua nave esplosa che nelle ingannevoli dimensioni del vuoto siderale poteva essere scambiata da chiunque per un’astronave.
Aveva davanti agli occhi un caleidoscopio di macchie di colori, uguali a quelle che da bambino vedeva dopo aver fissato a lungo il sole.
Le lacrime, evaporando, formavano una compatta superficie sul vetro del casco, ed essa gli impediva di vedere all’esterno.
Col corpo torturato dai singhiozzi, invocando selvaggiamente la grazia di una morte istantanea, piombò nella notte pietosa dell’incoscienza.
Faceva un freddo tremendo: i fiocchi di neve turbinavano attorno, sbattendogli sul viso, spinti da un vento impetuoso. Si era perduto nella tempesta. La nebbia calata improvvisamente gli impediva di scorgere gli alberi nel bosco. C’era una luce di fronte a lui, distante, appena distinguibile. Vi si diresse inciampando e cadendo nei cumuli di neve soffice e gelida.
La capanna aveva una sola finestra attraverso i cui vetri filtrava la luce. Aveva i piedi gelati negli stivali e ogni passo era un’acuta fitta di dolore.
C’era un uomo chino di fronte al camino; quando entrò, l’uomo si volse a guardarlo. Gli sfuggì dalla gola un grido di gioia. “Papà!” urlò, correndogli incontro.
Era una landa desolata, sotto un cielo grigiastro, rischiarato da un pallido sole invernale. Qualche tronco scheletrico sorgeva qua e là tra le rocce e la sabbia.
Camminava da tempo immemore e non sapeva bene dov’era diretto.
Tutto il corpo doleva per il lungo cammino; a ogni respiro i polmoni davano una fitta più acuta. Dopo ogni passo sembrava che ci fosse meno aria in quella brulla pianura.
Doveva tornare indietro, lontano, dove c’era qualcuno che lo attendeva, ma era passato tanto tempo dall’inizio del viaggio e non ce l’avrebbe fatta a ripercorrere tutta la strada.
Lentamente, ritraendosi con tutte le proprie forze, uscì dalle nebbie dell’incoscienza.
Sorrise amaro, per quegli istanti di lucidità che il caso gli voleva ancora offrire.
“È la fine,” pensò, alzando il braccio verso il condotto dell’ossigeno. Il destino si era preso gioco di lui troppo a lungo, ora gli avrebbe forzato la mano ad agire.
Il braccio ricadde inerte; non aveva più la forza di muoverlo. Non poteva neppure abbreviare la sua sofferenza. Era un insetto e attendeva al centro della ragnatela che il ragno gli succhiasse dal corpo le ultime gocce di linfa vitale.
“Chissà se c’è qualcuno a cui importi ciò che mi sta capitando.” Gli uomini non lo potevano più udire; non c’era nessuno ad ascoltarlo. Solo le stelle, indifferenti, a vegliare la sua agonia.
Sapeva di essere condannato e la cosa ormai lo lasciava quasi insensibile.
Tossì. Con gli occhi pieni di lacrime, sentiva a ogni singulto un artiglio lacerargli i polmoni.
Se solo avesse potuto metter fine a quel tormento.
La meteora viaggiava nel vuoto a velocità inimmaginabile. Era una scheggia di cristallo non più grande di un’unghia e dura come il più puro diamante.
Non ci sarà mai sicuramente concesso di sapere se la sua orbita intersecasse per caso quella del naufrago, o se così fosse voluto; ma forse la Divinità non dimentica mai le sue creature. Il cristallo cosmico attraversò la tuta dell’uomo all’altezza del cuore, scomparendo poi, nella sua inimmaginabile corsa, nel vuoto profondo.
Originariamente pubblicato sulla rivista Altair n. 2, 1976.
Adalberto Cersosimo
Nato nel 1943, docente di scienze e matematica, pubblicò il suo primo racconto nel 1964, e fu uno dei protagonisti del primo fandom italiano nella metà degli anni '60. Negli anni '70 continuò la sua proficua attività di narratore fantasy e sf. Scrisse molti articoli di critica e informazioni per pubblicazioni come Gemini, Verso le Stelle, Perry Rhodan, Spazio 2000. Dal 1979 al 1981 diresse il Concorso Letterario delle Edizioni Nord.