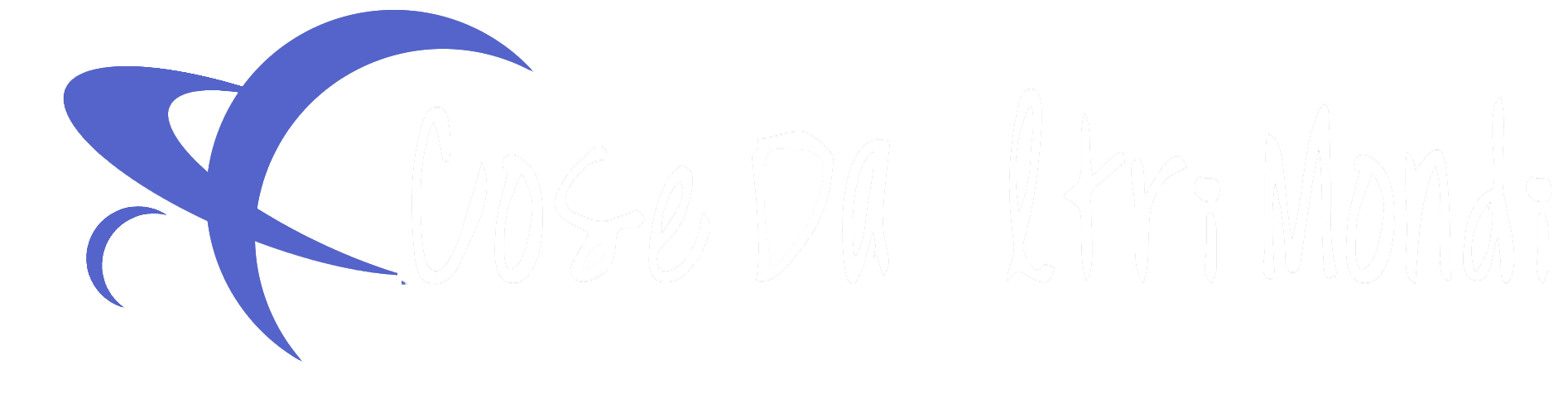“LA FUGA” DI HELEN ROWE HENZE

Mondi Passati – Vintage
(The Escape, Weird Tales, giugno 1923)
 Helen Van Arsdale Rowe Henze nacque a Springfield, in Pennsylvania, nel 1899; si trasferì da bambina a Kansas City, e qui lavorò tutta la vita come segretaria in un cementificio, ma il suo vero amore era la letteratura. Scrisse racconti pubblicati su testate autorevoli come il Saturday Evening Post, il New York Times e il Washington Post, ma solo uno a carattere pulp o fantastico, appunto La fuga. Pubblicò cinque raccolte di poesie fra il 1948 e il 1961. Fu anche autrice di canzoni, fra cui The Half Loaf, musicata da Andrew Lloyd Webber. Morì nel 1973
Helen Van Arsdale Rowe Henze nacque a Springfield, in Pennsylvania, nel 1899; si trasferì da bambina a Kansas City, e qui lavorò tutta la vita come segretaria in un cementificio, ma il suo vero amore era la letteratura. Scrisse racconti pubblicati su testate autorevoli come il Saturday Evening Post, il New York Times e il Washington Post, ma solo uno a carattere pulp o fantastico, appunto La fuga. Pubblicò cinque raccolte di poesie fra il 1948 e il 1961. Fu anche autrice di canzoni, fra cui The Half Loaf, musicata da Andrew Lloyd Webber. Morì nel 1973“Ne è sicuro?”
Il dottore annuì brevemente. “Sicurissimo, e quanto prima, tanto meglio!”
Donaldson afferrò lo schienale della sedia al suo fianco fino a che le sue nocche non sbiancarono.
“Non c’è niente da aver paura,” disse il dottore con una certa sufficienza. “L’appendicite è piuttosto comune. Ne operiamo un centinaio all’anno in ospedale.”
Donaldson si mise in piedi lentamente.
“Le farò sapere presto,” disse, guardandosi in giro con aria svagata.
“Molto bene. Ma Le consiglio di fare in fretta.”
Donaldson si avviò verso la porta.
“Le farò sapere,” mormorò. E uscì.
Scese in strada. Era un uomo di altezza media, e piuttosto magro. Portava vestiti decenti, di qualche anno prima, ma ancora buoni. Si capiva che ne aveva cura, anche se se ne vergognava un po’. I suoi occhi azzurri vagavano straniti da un oggetto a un altro, e le sue labbra sottili cercavano di mantenere una postura ferma, ma si abbassavano un po’, se, per caso, se ne dimenticava. Ma il suo passo procedeva come suo solito, corto, incerto, le spalle un po’ piegate, gli occhi riprendevano il loro vagare incerto, tutta la figura esprimeva il desiderio di occupare il minor spazio possibile, come se il suo corpo e la sua anima fossero schiacciati da un desiderio di inconsistenza.
Mentre usciva dallo studio del dottore, i suoi occhi pallidi si muovevano seguendo la folla per la strada. Perché non poteva essere qualcun altro? Eccoli lì, tutti così contenti e incoscienti di lui di e dell’ombra che pendeva su di lui. Incoscienti! Questa era la parola che terrorizzava la sua mente da dieci lunghi anni. E che aveva lo staso significato dell’anestesia – incoscienza!
Donaldson continuò a camminare e girò in una stradina che lo portò a casa sua. Entrò con la sua chiave. L’atrio nudo risuonò cupamente ai suoi passi. La spoglia, ombrosa sala gli diede solo un gelido benvenuto. Quando la signora Saunders era diventata la sua governante, c’era più calore. Non c’era quel tetro silenzio quando lui entrava. Era stato parecchi anni prima, e da allora la sua paura era cresciuta durante la sua lunga permanenza, come un grande, alto mostro che rosicchia nel buio. Era una subdola, sospettosa paura che lo scansava dagli altri. Viveva da 10 anni tutto solo, fatta eccezione per la signora Saunders, la governante, ma alla fine anche la sua presenza era diventata di troppo, e lui l’aveva mandata via.
Cominciò stupidamente a farsi da mangiare. C’era solo prosciutto, formaggio, mezza pagnotta e qualche patata, che lui pelò, in piedi vicino al lavabo. C’era anche una piccola torta che uno dei vicini gli aveva mandato qualche giorno prima. Erano persone gentili, incapaci di comprendere la vita solitaria di Donaldson, che lo compativano e di tanto in tanto gli mandavano dei dolci o della marmellata per insaporire i suoi pasti.
Una volta, quando lui si prese un’influenza, il signor Saunders gli aveva portato mezza caraffa di whisky, ma Donaldson era rabbrividito e aveva alzato le mani come per proteggersi dall’altro e aveva gridato: “Non voglio niente! Vada via! Mi lasci stare!”
E il vicino si era ritirato, attribuendo lo strano comportamento alla malattia. Ma no, la paura di Donaldson per il whisky era legata alla bestiale paura che fiutava i suoi passi come un cane o che si acquattava nell’ombra accanto a lui.
Da quella terribile, indimenticabile notte, quando lo aveva bevuto per la prima e ultima volta, ne aveva avuto un selvaggio terrore. La sola vista gli ricordava ancor più vividamente il volto, rigido, bianco di sua moglie mentre cadeva a terra, e il segno rosso del BORDO lungo la sua tempia. Si ricordava che era corso via e aveva portato a casa Jack Dingler con sé poche ore dopo, e l’avevano trovata. I vicini erano stati così solidali con lui nella sua disgrazia. Anche quegli stessi vicini che gli avevano portato il whisky ed erano venuti in casa dicendo mestamente: “Povero signor Donaldson. Non è più stato lo stesso da quando la signora è stata assassinata. La sua mente è come sconvolta.”
Avevano ragione. La sua mente era sconvolta. John Donaldson sapeva di cosa doveva aver paura. Da dieci lunghi anni, la paura si nascondeva alle sue spalle. La sua compostezza e la sua fiducia in se stesso svanirono. Era diventato un codardo, con l’onnipresente paura che lui, in qualche modo o con qualche parola o azione, rivelasse il suo segreto. Stava sempre allerta. La paura, il motore che non lo lasciava dormire. Teneva sempre la porta sprangata di notte, e la stanza vicino alla sua sempre vuota, per paura che parlasse nel sonno.
Questa era la sua più grande paura, che una volta o l’altra, nell’incoscienza, lui parlasse. imparò a prendere le più grandi precauzioni riguardo alla sicurezza personale. Non aveva mai fatto lunghi viaggi, né assunto rischi inutili. E adesso: un’appendicite!
UNA notte, una settimana dopo, Donaldson si svegliò di soprassalto, il suo corpo madido di sudore. Aveva avuto un terribile sogno. Era come se avesse visto il viso bianco di sua moglie con il segno rosso lungo la tempia, solo che stava in piedi e lo guardava con un’insolita, spettrale espressione negli occhi, e dietro a lei, guardandolo da sopra le spalle, c’era il volto di un satiro, lungo e giallo.
Poi questa figura si scostò e venne verso di lui, tenendo delle catene in mano. Catene per lui, Donaldson! Aveva già avuto sogni del genere, con qualche dettaglio diverso, ma sempre con la stessa terribile suggestione. E sempre lui si era svegliato come adesso, bagnato e freddo, in preda alla stessa mostruosa paura, pungendolo con mille spilli, strappandogli la pelle, paralizzandolo con un inspiegabile, spaventoso brivido.
Si chiese se avesse parlato nel sonno. Certo, non c’era nessuno a sentirlo, eppure se lo chiese. Era qualcosa di cui non poteva essere mai certo, un’angosciante, minacciosa incertezza che pendeva su di lui, che non lo avrebbe mai lasciato.
E quelle catene! Aveva una visione mentale di se stesso ai lavori forzati, con la palla al piede.
Guardò il suo orologio. Era più tardi di quel che pensava – le sei. Si alzò dal letto e si vestì in fretta. Sapeva per esperienza quale fosse il metodo migliore per scacciare il pietrificante effetto dei suoi sogni. Era l’attività fisica, camminare e camminare fino allo sfinimento. Allora la sua mente si sarebbe liberata da quel folle, nervoso terrore, e si sarebbe ridotto alla costante, accanita paura che non gli concedeva tregua.
Aprì la porta e s’incamminò in strada. Il sole del mattino cominciava a illuminare il grigio, deserto vicolo. Qualcuno dall’altra parte della strada chiuse una finestra. Donaldson si strinse nelle spalle, serrando le labbra. Anche così presto potevano vederlo. Doveva sembrare un passante casuale, uno sfaccendato in una passeggiata mattutina.
Ma si dovette sforzare, perché una paura irragionevole lo colse. Qualcosa alle sue spalle sembrava spronarlo a camminare più in fretta. In realtà, gli sembrò che i suoi piedi andassero più in fretta del resto del suo corpo, come se obbedissero al volere di quel qualcosa alle sue spalle, mentre di fatto lui si stava spostando a un’andatura moderata.
Aveva la sensazione di due entità distaccate. Una era il John Donaldson che si mostrava al mondo, un uomo esile, senza sostanza, che camminava un po’ timidamente per la strada, e l’altra era il codardo, l’essere terrorizzato, che scappava dalla cosa che lo seguiva; all’erta, teso a eludere il suo inseguitore. Una volta, in un impulso irresistibile, s’infilò in un vialetto. Poi, vergognandosene di colpo e riprendendosi, tornò fuori, camminando spavaldo, gli occhi fissi su un cavallo di passaggio, cercando di apparire indifferente.
Verso mezzogiorno tornò verso casa, e, ricordandosi che non aveva fatto colazione, e che non c’era niente da mangiare in casa, si fermò alla drogheria all’angolo. Il droghiere stava servendo un altro cliente, ma lo guardò e gli fece un cenno.
“Sarò da lei in un minuto, signor Donaldson.” E poi: “Che cos’ha? Si sente male?”
Donaldson si sedette di colpo su un barile di farina, tenendosi il fianco, il volto grigio dal dolore. Il droghiere corse a prendere un bicchiere d’acqua.
“Tenga, beva questo. Che cos’ha? Posso aiutarla?”
Ma Donaldson si limitò a scuotere la testa, incapace di parlare. Poco dopo lo portarono a casa, quando il dolore s’era calmato un po’, e chiamarono un dottore per visitarlo. Donaldson non voleva un dottore, ma il droghiere si era spaventato per il suo pallore e non badò alle sue proteste.
Il verdetto fu quello che Donaldson si aspettava, appendicite e la necessità di un’operazione urgente. Lui ascoltò, sdraiato sul letto, uno strano dottore, con la sensazione che, nonostante il dolore al fianco, che si discutesse di qualcun altro. Non poteva assumere quell’anestesia! Il dolore poteva ucciderlo; che lo uccidesse! Sempre meglio che quelle tremende catene. Perché sapeva che, una volta incosciente, la verità sarebbe venuta fuori, che tutto il veleno che lo ammattiva da anni sarebbe scaturito dalle sue labbra senza freni, una volta che fosse finito sotto anestesia. Quante volte l’aveva già riferito nel silenzio della notte? Quale dei suoi secreti i muri della sua camera non avrebbero potuto ripetere? Lo avranno ascoltato più e più volte.
Il dottore ripeté la sua diagnosi e Donaldson annuì.
“Sì,” disse meccanicamente. Doveva compiacere quell’uomo, perché un rifiuto l’avrebbe reso troppo insistente. Quando il dottore fu andato, fu di nuovo al sicuro. Tutti avevano quegli attacchi; non significavano niente.
“Tornerò a vederla stasera,” disse il dottore, mentre si preparava a uscire.
“No,” disse Donaldson, “non torni, starò bene.”
“Sarò qui,” disse il dottore, e uscì.
Una grande e improvvisa stanchezza assalì il malato, una sovrastante sonnolenza, un desiderio di dormire, una delle primarie, insistenti urgenze che non poteva andare respinta.
Quando si svegliò si era fatto buio. Non sapeva l’ora. Le luci arrivavano in casa dalla strada. Il ticchettio dell’orologio era l’unico udibile. L’oscurità della camera sembrava palpabile, come se fluttuasse sopra e attorno a lui, respirando. Poi l’orologio rintoccò le otto. Donaldson si ricordò. Il dottore sarebbe tornato presto. Poteva arrivare da un momento all’altro. Solo che non doveva! Sentì dei passi sulle scale. Era lui e la porta non era chiusa! Donaldson si alzò e andò alla porta. S’era dimenticato il dolore al fianco. Era consapevole solo della sua difficoltà a muoversi, come in un incubo, come se trascinasse dei pesi ai piedi. Il dottore era sulla veranda. Donaldson si agitò. Cosa tratteneva i suoi piedi?
“Non entri,” ansimò. “Sto bene!”
Allora arrivò il dolore, come una coltellata improvvisa, lancinante. Gridò, un atroce, incontrollabile urlo, e si spinse in avanti.
* * *
Ci fu uno strano, insolito odore, e silenzio. Non il vuoto silenzio della sua casa, ma il silenzio dato dall’assenza di movimenti umani.
Fu travolto dalla nausea. Aprì gli occhi per un attimo e poi li richiuse. Era in una stanza dalle mura bianche, in oscurità. Dietro la persiana chiusa poteva sentire il calore del sole. Un raggio penetrò tra la tenda e lo stipite della finestra e colpì il muro opposto. Era pieno giorno. All’improvviso, veloce e dritta come una freccia scoccata da un arco teso, la mente di Donaldson tornò alla lucidità.
Era in un ospedale, ed era finita… l’operazione. Era stata l’anestesia a nausearlo. Che cosa aveva detto? Si era tradito? Eppure si trovava lì, sdraiato tranquillo in quella stanza. Comunque non potevano portarlo via finché era malato.
Stavano aspettando… aspettando finché lui non stesse abbastanza bene da mettergli le catene! Lo sapeva. Ecco perché erano così tranquilli, per non renderlo sospettoso. Avrebbe chiesto all’infermiera. Lei poteva dirgli se aveva parlato.
Ma l’infermiera non c’era. Non sapeva che lui fosse sveglio. bene, avrebbe aspettato e chiesto. Forse non aveva parlato. Non sempre si fa. Il sole splendeva contro la persiana. Luce, speranza! Forse l’avrebbe rivisto, libero! Forse sarebbe tornato a camminare per le strade, in pieno giorno.
La porta si aprì ed entrò l’infermiera. Venne al suo capezzale. Lui le sorrise tranquillo, indifferente. Le fece la sua domanda con aria disinvolta.
“Infermiera,” cominciò. La sua voce sembrava lontana, più debole del dovuto.
L’infermiera sorrise. “Come sta il mio paziente? Si sente meglio?”
“Infermiera,” si sforzò di dare alla sua voce un tono fermo, ma disinvolto. Fece persino un debole sorriso. “Ho… hmm… parlato sotto l’etere?”
“No, neanche una parola. Ora riposi tranquillo e tornerò fra un po’.” E lei uscì.
Donaldson singhiozzò. Era ancora al sicuro. Glielo aveva detto lei. Non avrebbe ingannato un uomo malato. Eppure… era davvero così? Si ricordò di aver letto da qualche parte che ai pazienti si diceva sempre che non avevano parlato, perché saperlo avrebbe eccitati e danneggiato la loro convalescenza.
Ecco perché aveva detto così. Volevano che stesse bene, per potergli mettere le catene. Non aveva esitato un po’ prima di rispondere? Gli era sembrato che lei lo guardasse in maniera un po’ sospettosa. Adesso ne era sicuro. Ecco perché. Non volevano che lui sapesse che loro sapevano. Volevano essere sicuri di prenderlo.
Solo in quel momento i pensieri di Donaldson furono interrotti da un suono in strada. Alcuni veicoli che sferragliavano sull’asfalto e il suono di una campana. Due infermieri passarono nel corridoio, e l’orecchio teso di Donaldson colse le loro voci:
“Cos’è quel rumore?” chiese una.
“Non lo so,” rispose l’altra. “Sembra una sirena della polizia.”
Gli erano addosso! Cosa doveva fare? Gettò indietro le lenzuola. La sua mente lavorava veloce come un fulmine. Non l’avrebbero mai preso. Toccò il pavimento. Come fece a raggiungere la porta, non lo sapeva neanche lui. La paura ti fa forte. La richiuse e barcollò all’indietro, quasi ricadendo sul letto.
Sapeva cosa doveva fare. Tolse le lenzuola dal letto con mani febbrili. Le lenzuola – ecco cosa voleva! Strappò qualche centimetro di bordo estraendo l’orlo grezzo del tessuto. Poi strappò una striscia lunga quanto tutto il lenzuolo. Rideva eccitato. Non l’avrebbero mai preso!
In quel momento, la ferita al fianco si riaprì, ma non se ne curò. Non era consapevole di nulla, se non del suo folle piano. Sembrava che i suoi sensi lo avessero abbandonato. Era come se fosse in un sogno. Sentiva come se la sua mente si fosse staccata, e dall’esterno guidasse il suo corpo a fare quelle cose, e come se lui stesse spingendo l’altra metà di se stesso a fare solo certi movimenti stabiliti.
Legò un capo della striscia alla testiera del letto, poi salì sul letto e si sdraiò. Arrotolò l’altro capo della striscia attorno al collo. La testiera del letto era ornata da anelli in ferro battuto bianco. Sollevò le ginocchia e spinse con i piedi in modo da infilare la testa in una di quelle aperture per farla sporgere fra il letto e l’angolo della stanza. Ora aveva il collo in mezzo ai due pali della testiera, piegato all’indietro e respirava emettendo deboli suoni rauchi, come proteste della gola. Sapeva che non poteva strangolarsi fino a morire, perché non appena fosse giunta l’incoscienza, avrebbe automaticamente allentato la presa. Se avesse potuto legare l’altra estremità! Questa sarebbe stata una mossa sicura.
Il sangue gli saliva alla testa. Strinse il nodo, molto stretto. Gli parve di annegare. Le tempie pulsavano, e le orecchie battevano come se delle onde gli picchiassero dentro la testa, ora ruggendo, ora cantando con uno strano, irreale ronzio. Lasciò andare la mano, e il cappio si allentò.
Ecco! Così non era male, ma il sangue gli rifluì dal cervello e le onde vorticarono intorno a lui, facendolo sentire paurosamente stordito. Si sentiva come un piccolo brigantino, sballottato in mezzo a un mare in tempesta, inerte, stordito, apatico.
In qualche modo si riprese. La polizia! Doveva essere per strada! Le onde lo chiamavano. Il loro sollevarsi implacabile gli martellava il cervello, intorpidendo la sua sensibilità. C’era pace in mezzo a quelle onde. Una pace immutevole!
Ma doveva fare in fretta. Una nuvola salì davanti ai suoi occhi, grigia e invitante. Gli sembrò di dimenticare. Cosa doveva fare? Dov’era quella pace? Pace, qualcosa che non conosceva da eoni, dolorosi, infiniti eoni di tempo. Dov’era? Ah, sì. In mezzo alle onde, quelle maestose, incessanti, insistenti onde.
“Sto arrivando,” mormorò sommessamente. Aveva la lingua gonfia. Non c’era fretta. Scosse la testa per schiarirsi le idee nello sforzo finale. Poi strinse il cappio con tutte le sue forze, e lo legò velocemente a una barra di destra del letto.
Le onde si aprirono e lui affondò. Vide una debole, iridescente luce sotto di sé. C’era qualcosa di prezioso laggiù. Era la pace.
“Sto arrivando,” sussurrò, sforzandosi di allungare le braccia verso di essa. “Sto arrivando!”
Mario Luca Moretti
Altri interessi oltre al cinema e alla letteratura SF, sono il cinema e la la letteratura tout-court, la musica e la storia. È laureato in Lingue (inglese e tedesco) e lavora presso l'aeroporto di Linate. Abita in provincia di Milano