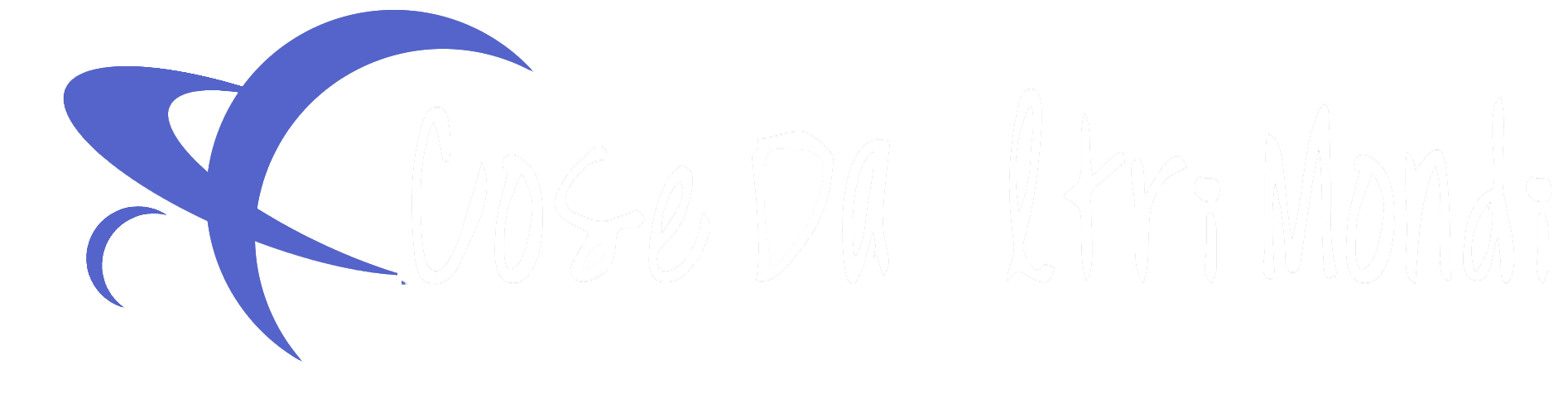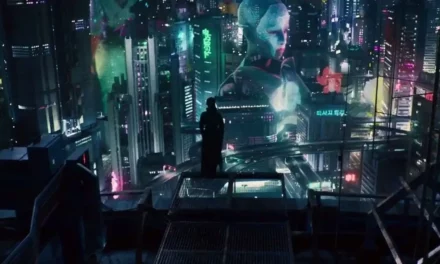PRESENZE INQUIETANTI A ROVERETO

Rovereto continua a essere uno dei centri più attenti alle problematiche della scienza, della tecnologia e della ricerca di frontiera, una piccola città con delle grandi idee, un’anomalia in Italia dove scienza e ricerca sono semisconosciute in ambito urbano o, quando va bene, vengono onorate dai media con due parole spesso enfatiche quanto imprecise, coronate da musichette di sottofondo e sorrisi degli speaker come per dire visto che bello?
Con questo non intendo dire che Rovereto sia l’unico luogo a dare risalto alla “materia oscura” italiana, però lo fa bene, con una scansione costante e in misura inversamente proporzionale ad altre città ben più importanti. Inoltre lo fa alla luce del sole, dandone risalto e senza quella specie di consorteria percepibile altrove quasi si trattasse di cosa riservata esclusivamente agli addetti ai lavori, e se qualcuno al di fuori della categoria volesse metterci il naso va bene, venga pure anche se non ha la tessera giusta ma non rompa troppo ché non è all’altezza.
Dal 21 maggio al 31 luglio 2009, nell’ambito dell’ultima manifestazione Back to the Moon in occasione del quarantennale dello sbarco sulla Luna, il Museo Civico ha organizzato una serie di eventi e di mostre di tutto rispetto nonché un incontro tra rappresentanti/collaboratori di Elara e un gruppo di studenti per discutere su argomenti fantascientifici e sulle tecniche di scrittura.
Io ho ricordi piacevolissimi di una mia precedente avventura roveretana: nel 2004 ci fu la manifestazione Orizzonte Spazio. L’esplorazione dell’universo tra scienza e fantascienza promossa dal Museo Civico, dall’Associazione Astronomica e dal Gruppo di Ricerca di Rovereto. In particolare ricordo una serata ammantata di surrealtà – e che nulla aveva a che fare con le cose serie – davanti a una pizza insieme a Ugo Malaguti, Carmine Villani, Vanni Mongini e sua moglie Manuela. Anche di questo esiste cronaca fedele. Comunque, sarà stata l’atmosfera di quella ormai lontana serata, sarà stato il contrasto tra una natura splendida e una tecnologia lunare che ambiguamente s’infiltrava nel quotidiano, fatto sta che da quando sono sceso dal treno a Rovereto a quando, tre giorni dopo, vi sono risalito a Ferrara, molte strane cose sono accadute, alcune in modo esplicito, altre apparentemente dovute a percezione personale ma, alla fine, obiettivamente enigmatiche per la loro ripetitività e comune sensazione.
Trovai Ugo Malaguti che mi aspettava alla stazione, e per prima cosa gli confessai che non sapevo ancora in quale albergo fossi destinato.
«Nessun problema,» disse lui, «Sarai alloggiato nella mia camera.»
Ugo è un grande amico, ma anche l’amicizia ha confini oltre ai quali credo sia meglio andare cauti. In un lampo rividi quella notte a San Cipriano Po ospiti entrambi di Lino Aldani, una notte terrificante intervallata da brevi assopimenti tra un rimbombante russare e l’altro… ma subito, forse preoccupato dalla mia espressione, Ugo si affrettò a chiarire: «Subentri al mio posto perché sono di partenza per Bellaria.»
Svanito lo scenario di una notte buia e tempestosa, mi immersi nell’ormai familiare atmosfera di ogni convention o equivalente, fatta di incontri previsti e imprevisti, di dibattiti pubblici e privati, di grandi tavolate e di ore piccole. Nelle vaste sale del Museo Civico c’era una gran quantità di oggetti sparsi un po’ ovunque tra cui molti pezzi dell’immensa collezione di Vanni Mongini. La Luna, ovviamente, la faceva da padrona: dal frammento di suolo lunare incapsulato in una piramide di plastica come un misterioso insetto nell’ambra, a un clone del Lunar Rover, alla tuta spaziale di Edwin Aldrin ricostruita perfettamente con materiali originali di provenienza Nasa da Luigi Pizzimenti il quale, ormai pendolare tra Italia, Houston e Cape Canaveral, è culo e braghe con tutti gli astronauti dei progetti Mercury, Gemini e Apollo (quelli rimasti, ovviamente).
Una sera, passeggiando alla ricerca dell’ultimo bicchiere, mi confessò: «Ormai sono diventati una seconda famiglia per me. Quando arrivo mi accolgono come uno di loro. Durante una riunione per il quarantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, hanno voluto mettermi al centro del gruppo per una foto ricordo. Ma il tempo passa veloce, e ogni volta che vado laggiù ho sempre paura di non trovarne qualcuno.» Era commosso nel descrivere l’emozione che provava a ogni sua trasferta negli States, e mentre lui parlava io sognavo a occhi aperti un’esperienza che finora non mi era stato possibile realizzare e che ormai non si sarebbe realizzata nemmeno in futuro. Quella sera non abbiamo trovato l’ultimo bicchiere, ma sono convinto che se l’avessimo trovato ce ne sarebbero stati molti altri innanzi all’alba.
Lasciata la stazione dove aleggiava ancora la presenza di Ugo (ma forse quell’odore di fumo di sigaretta era solo somatizzazione, una questione psicosomatica) arrivai al Museo Civico mentre era in corso un incontro pubblico con alcuni rappresentanti di Elara. Al tavolo c’erano Vanni Mongini, Antonino Fazio e Armando Corridore nella veste di coordinatore. Armando continuava a rivelarsi in molteplici aspetti a volte imprevedibili, almeno per me, ma sempre dimostrando una competenza e un aplomb invidiabili (sviolinata: Elara e la science fiction italiana di qualità ha trovato un altro personaggio determinante).
Stavo prendendo posto in sala, quando Vanni mi indicò con ampi cenni una sedia al tavolo della conferenza. Capii subito cosa mi aspettava. E infatti, quando gli fu ridata la parola, prese la cosa alla larga per arrivare alla fine al “ed ecco a voi…”, un’introduzione che non mi era nuova e sulla quale sapevo quanto lui ci avrebbe ricamato appena fossimo stati fuori dall’ufficialità. Divagare sulle varie interpretazioni del termine è diventato per Vanni un gioco ormai noto nell’ambiente, e il rimestare nell’ambiguità dei significati in modo vigliacco sembra sia diventata una necessaria parentesi ilare e goliardica all’interno dei suoi normali brontolamenti. Dico modo vigliacco perché il Nostro ama lanciare il sasso nei momenti in cui il destinatario, cioè io, si trova seduto intorno a una tavola o in un gruppo assieme ad altri soggetti inconsapevoli della maliziosità con cui condisce le sue capacità “introduttive” di fronte al pubblico, particolarmente quando ci si trova in compagnia di rispettose signore e signorine le quali, ignare testimoni di tanta aberrazione, non capiscono (o fanno finta di non capire). Io, peraltro, non posso rispondere adeguatamente poiché un po’ di compitezza mi è rimasta, e quindi sono costretto a incassare in dignitoso silenzio per rispondere più tardi e adeguatamente in altra sede.
A parte questo, anche l’argomento sul quale fui invitato a parlare non mi fu inaspettato. Il fatto che dal mio racconto Una notte di 21 ore sia stato tratto il film Terrore nello Spazio per la regia di Mario Bava è cosa ormai arcinota nell’ambito degli addetti ai lavori, ma quando c’è un pubblico alieno diventa sempre spunto di discussione. Tale accadimento, avvenuto nel lontano 1965, ha condizionato in una certa misura tutto il resto, e io francamente di questa menata mi sono stufato. Tanto più che la domanda ricorrente, una volta finita l’esibizione, è quanto mi hanno pagato, al che più passa il tempo e più mi vergogno di dirlo. Perciò il ripetere sempre le stesse cose ed essere “introdotto” dall’amico Vanni non è che mi renda proprio giulivo. Ad ogni modo, colto come fui al volo, feci ancora una volta buon viso e illustrai le magnifiche sorti e progressive dell’incontro con il mondo affascinante del cinema.
Ma questo fu un fatto personale che non può interessare più di tanto. Quello che invece, durante la nostra permanenza, destò l’attenzione di tutti noi, o comunque dei più attenti che a loro volta richiamarono l’attenzione dei più distratti, fu il comportamento di personaggi non direttamente legati alla manifestazione, e cioè hostess, camerieri di bar, personale di servizio al ristorante e umanità affine. Sembrava che tutta quella gente fosse come presa da incantamento, e che lo sforzo per entrare nella nostra sfera di risonanza non fosse sempre nelle loro possibilità. Forse dipendeva dall’aura lunare che in quei giorni avvolgeva Rovereto, una sorta di campo all’interno del quale la volontà di chi non è rotto a qualsiasi accadimento riceve fieri colpi; o forse dipendeva dalla nostra predisposizione a notare atteggiamenti del tutto normali con ottica viziata da eccessive letture di cronache da altri mondi e da immagini provenienti da sfrenata immaginazione; comunque sia, il risultato fu che la cosa assunse poco per volta uno spessore inquietante.
Riandando col pensiero al fenomeno, credo che tutto sia cominciato con la faccenda del cappuccino. Fu Valerio, figlio di Vanni, a chiedermi che ne pensavo. «Non prendo mai cappuccini,» dissi. E lui: «Non quello che si beve, intendo il frate.» Venni così a sapere che anche in altre occasioni s’era avvertita la presenza di un frate cappuccino che appariva e scompariva, oppure era visibile contemporaneamente in luoghi diversi. «Interessante,» dissi pensando di contribuire allo scherzo, ma Valerio continuò ad asserire con la massima serietà che si trattava di fenomeno noto nell’ambiente. «L’hai visto anche tu?» indagai. «Certo,» confermò senza ombra di incertezza, «Anche stamattina. Era davanti alla porta del Museo Civico. Ho girato la testa un attimo e quando ho guardato ancora da quella parte non c’era più.»
Valerio è un ragazzone sul metro e ottanta, robusto e tutt’altro che vanesio. Papà Vanni lo chiama ‘il mio cucciolo’ ma giustamente non lo fa mai in pubblico perché l’abbinamento può essere valido solo in ambito famigliare. Però è sempre figlio di Giovanni Mongini detto Vanni, e sapendo come marcia di fantasia il padre, tutto è possibile. Infatti, subito dopo avermi informato della visione, Valerio precisò: «È grande così,» e distese pollice e indice a distanza tra loro di cinque o sei centimetri. La cosa mi piacque, adoro quando si parla di stravaganze con un perfetto aplomb. E pensai anche che l’inizio del mio soggiorno roveretano non poteva essere migliore.
Comunque, ripeto, questo fu solo l’inizio, e di questo devo ringraziare Valerio perché il cappuccino che appariva di qua e di là rese ancor più decisa la spinta a osservare ciò che mi girava intorno; d’altra parte, non ho sempre sostenuto che chi fa science fiction deve servirsi di un certo modo di guardare le cose del mondo? E infatti fu grazie a quel certo modo di guardare che, una volta riuniti a tavola, notai lo stretto rapporto che Antonella Liscio, seduta di fronte a me, aveva con il cibo. Dicono che preparare il cibo sia un’arte, ma credo che anche utilizzarlo (come Hemingway faceva dire a Bill in Fiesta) sia un’arte. A guardarla mentre lo utilizzava si sentiva il sapore dei vari ingredienti, si assaporava la delicatezza dei contorni e dei dolci e la gradazione dei vini, il suo volto esprimeva il senso del gusto fin nelle più riposte sfumature, le sue papille gustative sembravano possedere facoltà non del tutto umane, e, come i gatti vedono al buio e percepiscono suoni a noi preclusi, lei dimostrava di possedere facoltà degustanti (non so se si dice così) a noi sconosciute. Insomma, ogni volta che portava la forchetta alle labbra trasmetteva ondate percettive tali da saziare. Pensai che l’unico esempio vagamente all’altezza fosse quello dei sommelier nell’assaggio dei vini e la loro cerimonia olfattiva e gustativa durante la quale sembrano non essere più con noi ma chissà dove. A un certo punto, non ricordo se durante una forchettata di spaghetti alla carbonara o di pappardelle ai funghi, vidi il suo sguardo rivolgersi verso l’alto in una sorta di epifania, di rapimento mistico, e per un attimo ebbi la certezza che stesse per sollevarsi dalla sedia in quell’ekstasis che ‘porta fuori di sé’. Io parlavo di questo e di quello con chi mi stava vicino, ma continuavo a osservare. E a pensare.
Con l’avvicendarsi delle portate, tutte eccellenti anche per chi era privo di poteri gustativi extra ordinari, e tutte di notevole possanza e varietà, notai che con la scusa di assaggiare quello che altri ai suoi lati decantavano, la fanciulla pescava a destra e a manca.
Chi legge queste parole si sarà costruito l’immagine mentale di una ragazza, come si dice, in carne, una di quelle ragazzotte rubiconde alle quali la tendenza all’anoressia tanto di moda è cosa sconosciuta. Niente di tutto questo: Antonella ha una figura sottile, il volto affilato, e la sua gestualità a tavola è tutt’altro che possessiva, è delicata e discreta. Solo instancabile.
Anche quanto sto dicendo può sembrare esercizio narrativo per dar colore a una normale tavolata di amici, ma non è così, è semplice cronaca di una tra le tante situazioni anomale che cominciarono a sommarsi sin dall’inizio con imprevedibile ripetitività. Perché un conto è dire che uno fa onore al cibo non solo suo ma anche quello graziosamente offerto dal vicino per assaggiare un piatto diverso, altra cosa è mugolare di piacere e utilizzare quello che il vicino è costretto a lasciare per raggiunti limiti di capienza.
Avevo cominciato questa digressione accennando a un avvicendamento di portate: Luigi Pizzimenti stava cercando di capire a chi fosse andato il piatto che aveva ordinato, e Armando Corridore, da parte sua, tentava una soluzione nello scambio con quello di Antonino Fazio. La cameriera, una giovane bionda proveniente da un Paese dell’est, aveva distribuito i piatti ma ne aveva imbroccato pochi, solo due o tre erano i piatti effettivamente ordinati. Anche a me capitò di trovarmi un risotto di radicchio al posto di tortelloni alla salvia. Il problema fu risolto quando una seconda cameriera, dalla chioma oscura, arrivò con altre ordinazioni; fu chiaro allora che le prime erano destinate altrove. Niente di straordinario, cose che càpitano quando ci sono parecchi tavoli da servire e gente che non sta zitta un attimo. L’aspetto insolito fu quando il disguido (con variazione) si ripeté il giorno successivo, e allora balenò l’idea che presentare come per errore piatti appartenenti a tavole diverse fosse un escamotage per far apprezzare de visu altre specialità della casa (in questo turbillon di vivande il mio pensiero era rivolto ad Antonio Bellomi e al suo Club Pigreco).
Detto per inciso, ricordo che quel secondo giorno, mentre mi avvicinavo alla tavola assieme a Ernesto Vegetti dopo una caccia alla grappa presso una distilleria locale (su cui riferirò in seguito) l’Antonella stava già utilizzando in solitudine una deliziosa piadina calda all’origano e contemporaneamente ne stava prendendo un’altra. La cosa non mi colpì più di tanto, ormai avevo inquadrato il meccanismo.
Dopo i taglieri con trionfo di antipasti e formaggi arrivarono i primi. Il disguido questa volta riguardava non tanto la qualità quanto la quantità: ci fu chi ebbe due piatti e chi nessuno. Il totale però non cambiava e tutto fu risolto dopo che il tentativo della solita Antonella di appropriarsi di un doppione fu sventato con gentile fermezza da parte di Antonino Fazio. Ma non era finita. Per secondo Vanni aveva ordinato uno stinco di maiale al forno, ma poi ci aveva ripensato e non l’aveva toccato. Antonella seguiva con un occhio quanto restava nel proprio piatto e con l’altro osservava lo stinco. Tra l’osso e la ragazza si stava intessendo un’attrazione reciproca seppur di natura masochista da parte del primo. Vanni se ne accorse e le chiese con tono scherzoso: «Lo vuoi?» L’esile ragazza non rispose subito, poi fece spallucce e mormorò: «Se per te va bene…» e lo stinco invase il piatto di Antonella. A quel punto si aprì un dibattito scientifico sulle facoltà metaboliche antonelliane. Si valutò la possibilità di un minibuco nero, di capacità allucinatorie, di disgregazione istantanea della materia al momento dell’assunzione… ma questo avrebbe comportato una trasformazione immediata in energia, in calore… intanto Antonella utilizzava indisturbata e indifferente mentre noi si discettava sulla soluzione del mistero. Che mistero rimase.
Nei ritagli di tempo tra una manifestazione e l’altra si andava a prendere un caffè o una bibita al bar vicino. Il bar si chiamava Antares, coerente in modo singolare con il tema della manifestazione. Il gestore era un ragazzo, ma le due volte che andai al banco trovai un uomo sui sessanta. Chissà perché, pensai si trattasse della stessa persona che, nell’attraversare la porta, passava da una dimensione all’altra. Quando andai al banco per pagare, il gestore nelle vesti del sessantenne sembrava non sapere di cosa stessi parlando. Elencai le consumazioni e lui mi dette lo scontrino. Ma poco dopo, nelle vesti del ragazzo, si avvicinò al tavolo e mi diede un secondo scontrino perché il primo era parziale. Tornai alla cassa e c’era il vecchio che mi guardava. Mi voltai per cercare il ragazzo ma non c’era nessuno. Forse perché mi trovavo in un bar, mi si presentò alla mente la figura del cappuccino. A quel punto il vecchio si scosse. «È per la differenza?» chiese. Feci per dire sì ma non uscì suono.
Parlandone poi con gli altri, seppi che situazioni simili si erano già verificate, e allora ricordai come tante altre situazioni a cui non avevo fatto caso adesso prendevano peso. Che fare? Decidemmo di continuare a far finta di niente, ma aleggiava nell’aria un’atmosfera da Villaggio dei dannati. Non è che tutto questo ci disturbasse, anzi, dentro il Museo Civico e fuori si respirava la stessa atmosfera di alterità.
Quella mattina ero andato assieme a Ernesto Vegetti alla mostra robotica e mi ero trovato di fronte al futuro. Un gruppetto di ragazzi stava lavorando su piccoli robot contornati da computer dove scorrevano labirinti di circuiti integrati e di schemi. Ernesto è un mago dell’informatica, e subito cominciò un dialogo con i ragazzi a me del tutto incomprensibile. Quei ragazzi appartenevano alla squadra che presentava, nell’ambito della manifestazione, La robotica nella scuola, formazione, ricerca, prodotto. Erano tutti sui venti venticinque anni, tutti alti dal metro e settanta in poi, tutti secchi, vestiti con braghe al polpaccio, T-shirt e scarpe da ginnastica slacciate. Alcuni erano rapati, altri avevano capelli a cespuglio incolto. Sembravano bisognosi di qualche opera pia e invece facevano lavorare piccoli aggeggi che si muovevano autonomamente tra ostacoli cercando il luogo adatto per parcheggiare, che andavano avanti e indietro ronzando sommessi, calcolavano distanze e spazi adatti e, una volta trovati, si fermavano soddisfatti. Altri piccoli robot giocavano una loro personale partita di calcio. Accanto, su una sedia posta davanti a uno schermo TV, sedeva una bambina sui sei anni, le gambette che non arrivavano al pavimento, e uno dei nuovi sacerdoti informatici le indicava i tasti per far muovere il robot sullo schermo. La bambina batteva le piccole dita qua e là, tutta compresa in quello che lei considerava un gioco e che invece, tra una ventina d’anni, sarebbe forse diventato il suo lavoro, magari sulla Luna o su Marte. Io la guardavo mentre ascoltava parole che non comprendevo. Qualche giorno prima giravano da quelle parti Charles Duke, uno dell’Apollo 16, e Umberto Guidoni, primo astronauta italiano nell’equipaggio dello Shuttle. Loro due, il gruppo di ragazzi e la bambina rappresentavano le prime tre generazioni dell’era spaziale.
Intanto Ernesto continuava a parlare con un paio di ragazzi nella loro lingua, ma mi accorsi che anche il mago informatico, pure lui, chiedeva chiarimenti: per la prima volta lo vedevo ascoltare per capire mentre lo avevo sempre sentito dare spiegazioni.
La sera del secondo giorno ha avuto luogo il secondo incontro con il pubblico. Il tema era Immaginare la scienza, incontro con gli scrittori di fantascienza della Casa Editrice Elara. La pattuglia era composta da Vanni Mongini, Gianfranco de Turris, Antonino Fazio, Ernesto Vegetti ed io. Coordinava Armando Corridore. Il pubblico era costituito da un gruppo selezionato di studenti degli istituti superiori i quali, a seguito delle indicazioni fornite, avrebbero composto un elaborato di fantasia, però su basi scientifiche, che sarebbe stato valutato, eventualmente discusso e quindi pubblicato da Elara in un volume speciale.
Non era la prima volta che partecipavo a incontri con studenti, e sono convinto che è proprio questa la strada giusta per gettare le basi di una nuova generazione di lettori, scrittori e saggisti, con la speranza che attraverso la loro maturità si scavalchi finalmente quelle banali e autocastranti lotte tra poveri che hanno caratterizzato il movimento per troppi anni, e anche con la speranza che tra essi si sviluppi una ricerca critica a sostituire le idiozie e la sofisticata ignoranza della critica ufficiale.
 Intanto io avevo cambiato alloggio. La nuova residenza si chiamava D&D, e già il nome non era del tutto normale. In compenso l’albergo, anzi la locanda, era splendida sia come struttura e servizi che come posizione. Collocata in collina, era stata ricavata da una vecchia casa con fienile e arredata da un architetto di nome. Tanto di cappello per le soluzioni, l’arredamento e il comfort. Intorno c’era una pace che solo in certi luoghi di montagna si può trovare, fuori dai sentieri inquinati dal turismo massificato e becero, nessun’altra costruzione intorno, solo silenzio, e alla sera libero accesso alla luce delle stelle. Sotto di noi si stendevano invece le luci di Rovereto. Era l’una passata quando Valerio ci portò lassù.
Intanto io avevo cambiato alloggio. La nuova residenza si chiamava D&D, e già il nome non era del tutto normale. In compenso l’albergo, anzi la locanda, era splendida sia come struttura e servizi che come posizione. Collocata in collina, era stata ricavata da una vecchia casa con fienile e arredata da un architetto di nome. Tanto di cappello per le soluzioni, l’arredamento e il comfort. Intorno c’era una pace che solo in certi luoghi di montagna si può trovare, fuori dai sentieri inquinati dal turismo massificato e becero, nessun’altra costruzione intorno, solo silenzio, e alla sera libero accesso alla luce delle stelle. Sotto di noi si stendevano invece le luci di Rovereto. Era l’una passata quando Valerio ci portò lassù.
Valerio fu il deus ex machina che con la sua macchina (appunto) fece in modo che quasi tutti noi, cioè gli dèi senza macchina, fossimo in grado di spostarci. Da veneziano doc non capirò mai come quel ragazzo abbia fatto a districarsi in modo così sublime tra le strade di Rovereto e fuori città senza mai un’indecisione, un errore; filava tranquillo e sicuro, sempre disponibile, sempre sereno, senza ricorrere ai brontolii che il padre avrebbe potuto trasmettergli con il proprio DNA.
Ma soffermiamoci ancora un attimo sul D&D. Quella stessa mattina eravamo saliti lassù per portare le nostre cose; la porta era chiusa e non si vedeva nessuno, la casa sembrava disabitata eppure c’era un portatile acceso. Finalmente apparve una signora dall’aspetto austero che ci consegnò un modulo da riempire e ci diede le indicazioni per aprire la porta esterna, quelle interne e l’illuminazione attraverso una chiave a scheda. Vanni disse che l’indomani mattina dovevamo essere al Museo presto e se poteva preparare la colazione per le otto.
«Basta alle otto e mezzo,» disse la signora salendo la scala di legno, «Non ci vuole molto per arrivare in città.»
«Potrei avere la colazione alle otto?» insistette Vanni.
«Facciamo alle otto e un quarto,» concluse la signora mentre saliva gli ultimi gradini per poi dileguarsi. Non si sentì più nessun rumore, nemmeno di passi lungo il corridoio, e il D&D cadde nel più profondo silenzio. Colto da stupefazione, chiesi a Vanni se conosceva la fantomatica signora.
«Sì,» disse, «È un tipo strano. Sai una cosa? Qui ci abitava un pazzo che alla notte girava con un fucile.»
«È come la faccenda del cappuccino?»
«No, no, è vero. Quel tipo ce l’aveva con il mondo e voleva ammazzare chi si avvicinava.»
«Adesso però non c’è più, vero? Nemmeno il suo spettro, intendo.»
«Questo non lo so. A me hanno solo raccontato che era pazzo.»
«Quella… quella signora, non sarà per caso una sua parente?»
«Non credo. Comunque sta tranquillo, vecchio mio, qui non verrà nessuno a disturbarci.»
Il giorno successivo era sabato 30 maggio. Non c’erano manifestazioni che ci riguardassero salvo la sera, una serata importante: Armando Corridore avrebbe dimostrato un altro lato della sua poliedrica personalità e abilità. Quando l’avevo conosciuto durante una delle ricorrenti riunioni nella redazione di Elara a Bologna con successivo pranzo no-limit, da come parlava di problemi giuridici l’avevo subito considerato un avvocato o comunque un esperto in questioni legali. Non lo era ma ne sapeva molto. Poi, conoscendolo più a fondo, pensai che avesse a che fare con l’editoria per le sue idee e le sue proposte di marketing e di iniziative future. Non era così però ne sapeva molto. Infine venni a sapere che era musicista e compositore. E per quella serata roveretana c’era in programma un suo concerto di musica elettronica con la collaborazione di Roberta Gottardi, clarinetto basso, e Annamaria Marini, flauto. Regista del suono era Luca Richelli. Il titolo del pezzo era Canti segreti di Saturno ed era basato nientemeno che sui segnali ricevuti dalla sonda Cassini e su registrazioni giunte alla NASA di cui Armando aveva eseguito un’elaborazione. Ma andiamo con ordine.
Quella mattina, quando la luce cominciò a filtrare decisa attraverso i raffinati tendaggi, non riuscii a starmene a poltrire e passai sotto la doccia. Breve consultazione del programma per calcolare come avrei potuto riempire il tempo libero, e giù per la colazione. Mentre scendevo la scala di legno intravidi nella penombra della saletta d’entrata una figura seduta in un angolo. Istintivamente rallentai la discesa, la mente subito al pazzo che nel passato aveva abitato quella casa. Ma realizzai che i tempi con potevano coincidere, non poteva essere lui… e nemmeno il suo fantasma perché, che io sappia, i fantasmi non si siedono mai. E poi quella che intravedevo non era massa da fantasma. Una voce provenì dall’angolo: «Dormito bene, vecchio mio?» Era il Vanni che, già fatto colazione, aspettava Valerio che ci portasse entrambi in città.
L’ottima colazione veniva ancor più arricchita dal fatto di essere servita su tavolo casereccio, non i soliti standardizzati tavoli d’albergo. Però, degno di albergo almeno a tre stelle era il buffet composto di caffè, latte, varie qualità di tè, succhi di frutta, fette di pane, croissant, marmellate e burro e un paniere con mele, pesche, arance, pere, uva e, a parte, noci sgusciate. Di solito, quando mi trovo fuori casa, faccio onore alla prima colazione per arrivare con comodo all’ora di pranzo senza necessità di interruzioni al bar. Quella mattina la colazione fu oggetto di particolare attenzione sotto gli occhi attenti di Vanni. La signora misteriosa non si fece vedere, al suo posto intravidi per un attimo un uomo che avrebbe potuto essere il figlio o il fratello o anche il marito data l’incomprensibile età della donna, ma subito anche lui svanì. Di sicuro non lo vidi salire la scala di legno.
«Che ne pensi?» chiesi a Vanni.
Lui fece una smorfia e si strinse nelle spalle, «Non lo so. La casa sembrerebbe disabitata, eppure…»
«Saranno parenti del pazzo?» Indagai ancora una volta.
«Può darsi.» Laconico.
Per un attimo pensai che Vanni fosse a conoscenza di cose che non voleva svelare. Pensai anche che avrei dovuto passare lì un’altra notte… ma ci sarebbero stati anche Ernesto e Gianfranco, insomma saremmo stati in quattro. Mi venne da ridere.
«Che c’è, vecchio mio?»
«Niente, niente,» dissi mandando giù la solita mezza pastiglia di Naprilene con un ultimo sorso di tè, «Avrai notato quante cose strane ci sono da queste parti. Comportamenti che…»
«Non dirlo a me, che qui sono di casa. Te l’avevo detto che questo era un luogo fantastico. Potresti scriverci qualcosa.»
Passai la mattina visitando gli stand, esaminando i pezzi esposti, assistendo alla proiezione di filmati in 3D, girando qua e là. Tra tante meraviglie c’era anche la copia esatta del Lunar Rover, la jeep usata dagli astronauti americani per spostarsi sulla superficie lunare. A guidarla sul suolo roveretano era un giovane con le stesse caratteristiche del gruppo di robotica, ma anziché portare braghe al polpaccio, T-shirt e scarpe da ginnastica era infilato in una tuta bianca della NASA, le trecce rasta che ballonzolavano sul logo. Il pubblico veniva invitato a prendere posto sul secondo seggiolino per un breve giro a dimostrazione dei sistemi di guida. Io guardavo e dentro di me c’era un demone che diceva ‘Vai! E vai!’, e un angioletto che mi ricordava ‘Non hai più l’età, non essere ridicolo’. Ma forse le parti erano invertite ed era l’angioletto a spingermi ad andare oltre il cielo. Alla fine, fosse stato l’uno o l’altro a spingermi, mi trovai seduto accanto all’astronauta. Può darsi che qualcuno abbia effettivamente pensato ‘Ma guarda quel vecchio rincoglionito che gioca con l’automobilina!’. Può darsi, ma se qualcuno ha compatito me, non sa quanto io ho compatito lui. Quello lì non sarebbe stato certo in grado di provare altrettanta emozione essendo cosa a lui sconosciuta. Poveretto. Però, se devo essere sincero, non ho notato nessun sorriso, nemmeno di benevola indulgenza.
Più tardi, passando davanti all’Antares, intravidi Antonella e Antonino Fazio seduti a un tavolo. Lei stava utilizzando cappuccino e brioche. Fu la prima della compagnia che quella sera trovai già sistemata a tavola. Davanti a lei c’era il solito tagliere con trionfo di affettati e formaggi e un paniere con fette di piadina calda all’origano e al rosmarino che lei sbocconcellava con fare apparentemente distratto. Ben presto fummo tutti riuniti, Antonino, Gianfranco, Valerio, Vanni, Armando, Rosa, Luigi ed Ernesto. Ricominciò il carosello impazzito dei piatti, alcuni rispondenti alla richiesta, altri di fantasia, alcuni destinati al nostro tavolo, altri a tavoli altrui, il tutto in un brioso scambio di specialità culinarie e di impressioni su cui aleggiava lo spirito di Jonesco. Non vorrei però che questa situazione fuori dai canoni fosse interpretata come cosa fastidiosa, tutt’altro, anche questo era perfettamente coerente con il contesto e dava quel tocco di estemporaneità e di sana allegrezza che rappresenta la nostra cifra sia a Rovereto che a Bologna che altrove.
Per due volte Antonella rovesciò il bicchiere di vino e per due volte utilizzò il dessert come conseguenza di una doppia ordinazione non richiesta ma servita sia dalla cameriera bionda che da quella con i capelli scuri.
In mattinata ci eravamo accorti che per un paio di noi i tagliandi per le colazioni non erano sufficienti, e così ci eravamo rivolti alla segreteria. Le ragazze rimasero a guardarci mute e sorridenti in attesa non so bene di cosa. Ripetemmo la situazione e allora, sempre sorridendo, ci consegnarono altri tagliandi e continuarono a guardarci sorridendo in attesa di non so bene cosa. Perplessi, ci allontanammo, e il mio pensiero – ma, accertai più tardi, non solo il mio – era andato al comportamento del barista dell’Antares, così sorpreso, così trasognato. Quell’atmosfera mi piaceva sempre di più, peccato che l’indomani era giorno di partenza; ma chissà, può darsi che in futuro ci sia un altro back to Rovereto.
Passai il pomeriggio vagando nei dintorni e approfittai per visitare il Museo Depero, immergendomi per un paio d’ore nel movimento futurista attraverso il quale venivano invocate tante cose come fossero benedizioni per un vivere migliore, rotture di schemi consolidati, esaltazione della potenza, della fabbrica e della velocità, della macchina e della conquista tecnologica, tutte cose puntualmente avveratesi ma che hanno trascinato dietro di sé un mondo sempre più alieno, una costante dissociazione tra possibilità creativa e adeguamento psicofisico. Pensai ai ragazzi della didattica robotica, alla bambina davanti al monitor mentre batteva sulla tastiera, e cercavo di immaginare il corrispettivo tra il movimento futurista nei confronti della mia generazione e le attuali previsioni scientifiche e tecnologiche nei confronti della generazione di quella bambina.
Una visita approfondita a un paio di librerie ed era ora di cena. Antonella si trovava già sul posto. Più tardi, del gruppo mancava solo Armando Corridore, occupato a definire gli ultimi dettagli tecnici del suo concerto.
Alle 21 il concerto ebbe inizio. L’esecuzione fu straordinaria. La sala era contornata da una decina di diffusori in modo che il pubblico si trovasse “immerso” nell’evento. Pensare che quelle vibrazioni erano la voce di Saturno mi dava i brividi. Non sono un esperto musicale, ma penso che ogni espressione artistica sia valida quando riesce a trasmettere un’emozione, e devo dire che quel concerto “cosmico” è stato, in musica, uno dei momenti più affascinanti. Quella fu un’ulteriore prova dell’abilità e della creatività del nostro Armando, la cui competenza e levatura erano già state giudicate e apprezzate, tanto che il concerto verrà ripetuto il 12 agosto nel quadro dell’Anno Internazionale dell’Astronomia accanto all’osservatorio di Monte Zugna allorché, tramontato Saturno, sorgerà Giove, e sarà la voce di quest’altro gigante del nostro sistema a crearne la base. Armando assicura che la voce di Giove è ancora più incantatrice, e c’è da crederci.
Era anche questa volta l’una di notte quando Valerio portò papà Vanni e me al D&D. Si ripeteva la magia fatta di silenzi, del tappeto di luci di Rovereto steso a valle sotto di noi e di un cielo frastagliato di stelle. Dalla casa non proveniva alcun segno di vita. Appoggiai la scheda al sensore e la porta si aprì con uno scatto. Una luce tenue traeva dalle ombre i grandi quadri appesi alle pareti, la scrivania con il portatile aperto, le masse dei mobili antichi, esemplari bellissimi di arte povera, la scala di legno che portava da una penombra all’altra. Ripetei l’operazione sul sensore della camera e la porta si aprì. Infilai la scheda nell’apposita fessura e la luce si accese.
Quella sofisticata tecnologia in quel contesto era anch’essa coerente con tutte le altre antinomie che mi si erano presentate da quando ero sceso dal treno. Indubbiamente si tratta di un luogo stregato che fa scaturire sensazioni riposte.
Durante la notte non successe nulla, o almeno non me ne accorsi. Dopo la doccia preparai la borsa con la massima calma gustando fino all’ultimo quei momenti… fino a quando sentii bussare. Chi poteva essere? Schiusi lentamente la porta e mi trovai di fronte a tre uomini. Suggestionato dalla presenza misteriosa di chi abitava quella casa, mi venne di alzare le mani in segno di resa, ma riuscii a trattenermi. Erano Ernesto,Valerio e Gianfranco.
«E allora?» chiesero.
«Va bene, vengo subito.»
Mentre facevo colazione, all’uomo che era subentrato alla signora misteriosa (mai più ricomparsa) e che continuava a portare squisitezze prese chissà da quale invisibile canto, chiesi se rispondeva a verità la storia dell’uomo pazzo. Lo dissi sorridendo tanto per non dare troppa importanza alla cosa. La risposta fu estremamente cortese ma priva di sorriso: «Certamente. Era il proprietario, un uomo vissuto sempre in solitudine. Ma sa, a volte succede che la solitudine faccia brutti scherzi, porta a vivere in dimensioni diverse e può portare alla pazzia. Lui era diventato pazzo, ce l’aveva con il mondo, e così girava sempre con un fucile.»
Già.
Scesi in città con la macchina di Ernesto assieme a Gianfranco. Volevano visitare una distilleria consigliata dal direttore del Museo Civico. La gita fu allietata dai canti di Ernesto. Ernesto è un altro personaggio che non finisce di intrigarmi. Lui sa tutto su qualsiasi argomento. Per esempio, lui che non usa alcoolici, ha dato una dimostrazione su come si può stabilire il grado alcoolico di uno spumante inclinando il bicchiere e osservando l’entità del bordo del liquido.
Quella mattina fui testimone di un’altra sua specialità ancora sconosciuta, almeno a me. Forse preso dall’atmosfera che aveva sedotto un po’ tutti, cominciò a cantare inni guerreschi dal vivo sapore nostalgico. Gianfranco non si unì ma seguiva con partecipazione. Io ricordavo qualcosa del tempo in cui ero stato Figlio della Lupa, ma poi non mi erano capitate altre occasioni per rinfrescare la memoria. Avrei potuto contribuire solo con frammenti dell’Inno dei sommergibilisti:
Taciti ed invisibili partono i sommergibili
Cuori e motori d’assaltatori contro l’immensità.
Andar pel vasto mar
Ridendo in faccia a Monna Morte ed al Destino
Ma non potevo competere, e mi astenni. Ernesto è fantastico. Spesso mi capita di confessargli le ambasce che il computer mi procura, e lui con la massima nonchalance e sicurezza mi svela segreti per me insondabili. Quella mattina, per esempio, gli dissi che, oltre a tante altre manifestazioni misteriose, da qualche tempo il mio PC si asteneva dal mostrare data e ora, rimanendo fermo alle ore 1:30 del 1° gennaio. «Brutto segno,» disse con lo stesso tono che avrebbe usato per dire che non ci sono più le mezze stagioni, «Potrebbe non accendersi più e perderesti tutto.»
A quelle parole mi chiusi nel mio dolore e dissi che sì, dovevo cambiarlo, ma avevo sempre qualcosa in corso e che insomma… «Aspetta luglio prima di cambiarlo,» aggiunse Ernesto, «A luglio sarà messo in commercio un nuovo programma.» Ecco, sapeva proprio tutto.
Per tornare a Venezia non presi il treno. Vanni tornava a Salara e così Valerio mi avrebbe dato un passaggio fino a Ferrara. Durante il viaggio, tanto per cambiare, notai un altro fatto strano. Evidentemente l’aria di Rovereto era stata incapsulata nella macchina di Valerio e ci stavamo portando dietro le sue misteriose proprietà facendo emergere facoltà latenti. Può darsi che io stesso, involontariamente, abbia rivelato particolarità sconosciute e bizzarre, chissà. Insomma, dopo il fenomeno Antonella, tutt’ora insoluto, ecco Ernesto che rivela incredibili doti canterine, e poi ecco Valerio che pensa di cambiare mestiere e fare il tassinaro grazie al suo straordinario senso dell’orientamento, e ancora Armando che dopo essere passato, nelle mie deduzioni, attraverso l’attività legale e quella di editor, si rivela musicista e compositore di successo. Chi mancava a questo punto? facile da capire: in macchina eravamo in tre, Valerio, Vanni ed io. Di Valerio ho già parlato, io non c’entro, quindi…
Lo svelamento cominciò dopo un’ora, un’ora e mezzo. Si stava parlando tutti e tre di non ricordo cosa e a un certo punto una domanda fatta a Vanni rimase senza risposta. «Allora, che ne pensi?» chiesi. Niente. Ne dedussi che forse stava pensando, troppo concentrato nella risposta da dare. Poi mi accorsi che dormiva. Non insistetti, ma dopo poco arrivò la risposta. La cosa si ripeté poco dopo, e ancora il suo parere, seppure in ritardo, fu coerente. Continuò così abbastanza a lungo, tanto da farci l’abitudine. Alla fine mi resi conto che il Vanni poteva manipolare a suo piacimento sia lo stato di veglia che quello del sonno. In altre parole, la pennichella poteva essere di lunga obnubilazione se in luogo canonico, oppure frammentata se in luogo insolito. L’aspetto straordinario era che con quel meccanismo riusciva a contrarre il tempo perché l’interruzione della capacità verbale non inficiava il contenuto di quanto si stava discutendo, lui captava il concetto però la risposta veniva formulata ed espressa solo alla conclusione della parentesi obnubilativa, ma per lui quelle parentesi non esistevano e, nella sua dimensione temporale, la discussione filava liscia.
Scendemmo al Pianeta Proibito, la cartolibreria tenuta da Manuela per un breve saluto, quindi eccoci all’altro Pianeta Proibito, la casa-museo di Vanni, luogo magico dove ogni volta che vai trovi sempre qualcosa di nuovo, una wunderkammer di cui una piccola parte era stata trasferita al Museo Civico di Rovereto.
A proposito di Wunderkammer, Vanni mi parlò di un progetto entusiasmante… ma sarà lui a parlarne quando e se vorrà.
E con questo ulteriore mistero chiudo.
Renato Pestriniero
Renato Pestriniero, veneziano, sposato, una figlia. Fino al 1988 capo reparto presso la filiale veneziana di multinazionale svizzera. Dal suo racconto “Una notte di 21 ore” il regista Mario Bava ha tratto il film “Terrore nello spazio.” Esperienze televisive, radiofoniche, fotografiche e figurative.