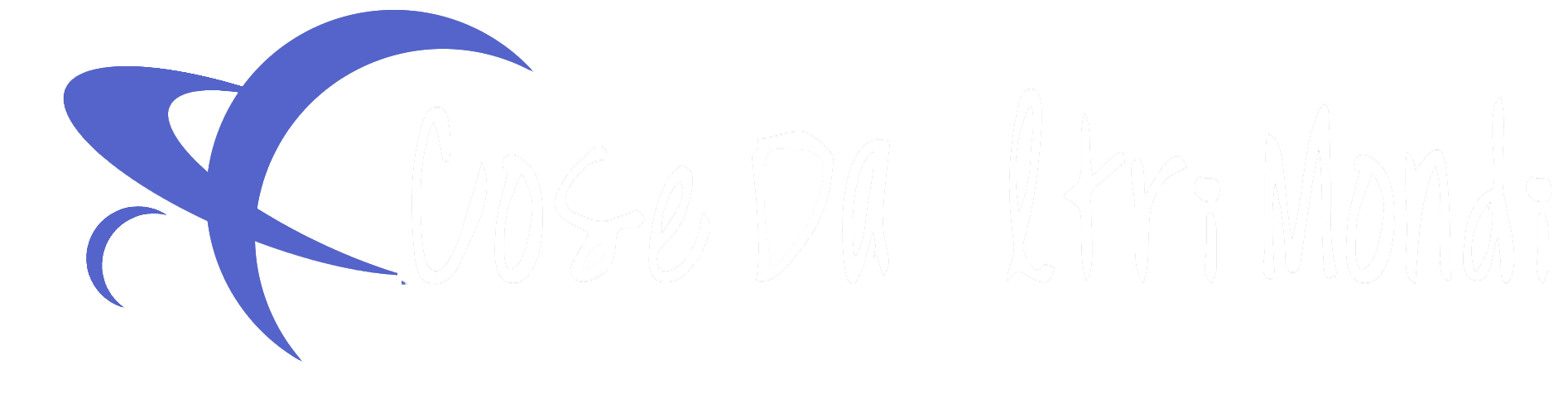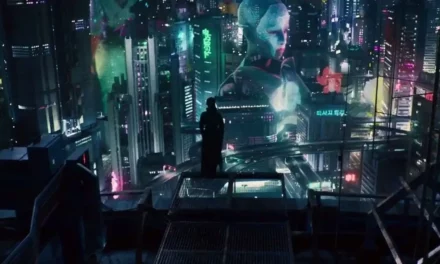L’odio dei vecchi

Dall’astronave, la vista dell’orizzonte assomigliava a un tessuto di una trama innaturale, così nero che nella fantasia era paragonabile solo all’odio.
Patrick Giuppi sentiva freddo. Era una sensazione che non provava da anni, novanta o forse cento. Aveva scrollato le spalle, sorpreso da un brivido. Il movimento, involontario e fulmineo, rispondeva a una lama di ghiaccio che era salita sulla schiena.
C’era davvero una parte del suo corpo vulnerabile?
Patrik osservava i peli rizzarsi sotto la manica aperta. La pelle era contratta, l’avambraccio appariva punteggiato di minuscole bolle che, all’inizio raccolte, poi si distanziavano in prossimità del gomito. Sentiva una pressione invisibile dietro la nuca, come se mani pesanti cercassero di schiacciarlo sul pavimento della cabina.
Patrick si era scoperto anche l’altra manica, all’apparenza l’avambraccio sinistro era del tutto identico al destro, ma senza brividi o bolle. Nell’altro braccio sentiva la vita scorrere in modo più familiare. Ruotò il polso, protese il palmo oltre il bracciolo della poltrona dove si trovava seduto. In un modo a lui sconosciuto il suo corpo si era adattato. Le labbra tornavano a chiudersi, anche se lo stupore non lo abbandonava.
Patrick Giuppi poteva ancora morire, poteva ancora espiare le sue colpe. Questa nuova consapevolezza rendeva più sopportabile il viaggio solitario nello spazio.
La poltrona di Patrick Giuppi era al centro di una cupola vuota in mezzo alle stelle. Vedeva soltanto un muro di oscurità, che si mostrava in tutte le gradazioni di buio, solcando una notte senza fine.
Da quando aveva smesso di prendere la pillola i demoni si erano risvegliati. Oltre al gelo improvviso, era tornata la vergogna indefinita di se stesso, e quella gli mozzava il respiro.
In un secondo la sua astronave percorreva nove milioni di km. Viaggiando a una velocità superiore di trenta volte a quella della luce. La cupola di osservazione in cui era seduto, pur avanzando, era diventata una mezza sfera d’inchiostro, che risucchiava ogni bagliore esterno così rapidamente da non lasciare alcuna traccia riconoscibile. La fisica del movimento si intuiva dall’alone in alto, non abbastanza netto da catturare la forma di una scintilla o le sfumature di una nebulosa ma, appena percettibile, restituiva il riflesso lucido di un nero ondeggiante, scomposto, che si incupiva allo zenit.
Forse aveva superato una stella di neutroni, si spiegava così il peso di una montagna sulle spalle: le forze di marea, che torcevano la fusoliera della nave e il pugnale di ghiaccio nella schiena, potevano indicare che si trovava vicino alla destinazione.
Il tempo si riavvolgeva e lo spazio sfuggiva lungo il confine infinito delle tenebre della velocità ultra-luce.
«Ricordi quando la tua vita era diversa?» la voce metallica dell’A.I. di bordo lo distrasse.
Patrick stava riordinando i ricordi. Gli effetti della pillola erano scomparsi, la memoria si sgretolava senza che riuscisse a ricollegare tutto in un ordine preciso.
«Ricordo mia moglie…» iniziò a parlare a voce alta.
La perdita delle cose più care, richiamata nella mente, apparteneva a un luogo e a un tempo così remoti da fargli dubitare della loro esistenza:
«Lei amava il sapore dolce della frutta. Doveva aver sofferto molto da piccola. Ricordo l’ombra del suo viso su di me, quando mi svegliavo e lei mi guardava. Ricordo i tatuaggi che aveva sulla fronte e sui polsi, nemmeno riesco più a pronunciare il suo nome nell’antica lingua tarsi, ma tutta la dolcezza del suo animo è ancora con me, in qualche modo. Anche se la mia è una memoria monca, ci sono scene nitide come quadri, dense di particolari, frammenti di storie che la pillola non ha cancellato. Devo solo chiudere gli occhi e i ricordi sono lì, pronti a rispondere a un mio richiamo, sommergendomi di dettagli. Mia moglie aveva lavorato in una frutteria. Aveva mani forti e denti splendenti, bianchi. Sono trascorsi milioni di anni, com’è possibile trattenere un ricordo tanto distante? Eppure, rivedo il suo viso, le mani che accarezzavano mele giazir, le sue preferite, con la buccia nera a causa dei raggi ultravioletti. Ricordo la sua gente, vestita con i samir, che faceva la spesa al mercato e poi proseguiva tra i banchi. Ero rimasto lì a osservarla. Ricordo la prima volta che ho letto nel suo sguardo la sua bellezza. I miei occhi giovani persi tra i passanti del bazar, che stabilivano un contatto con lei, con lei soltanto. Essere messi da parte, non contare nulla, imparare a rispettare il silenzio, non alzare la testa, “riuscirò a farle capire che nelle sue mani forti, nel suo cuore, e nella sua volontà può diventare una regina delle stelle.”» pensavo allora.
Il mio era il pensiero di un viaggiatore di mondi… di un dio sciocco e presuntuoso.
Era arrivata per me la breve stagione dell’amore, avevo solo mille anni allora.
Ancora non conoscevo del tutto la malattia degli dèi, l’odio dei vecchi.
Viaggiavo da un pianeta all’altro per sperimentare culture aliene. Ora i ricordi sono sbiaditi, appesantiti dall’assenza della pillola.
Quanto era dolce e bella mia moglie. Lei nemmeno lo vedeva, nemmeno lo sapeva, così perfetta, eppure così fragile. È proprio vero, ora trovo frammenti di un’altra vita che nemmeno sembrano più appartenere alla mia. Sento ogni giorno il dolore della sua perdita. Un evento imprevisto e crudele. Un furto, un’aggressione, un carro rovesciato e la notizia, io troppo lontano, l’avevo persa per sempre. Quei barbari l’avevano bruciata sulle pire dei morti, resa cenere e condannata, per me era ormai impossibile intervenire.
In mezzo al disordine della nostra camera da letto vuota, avevo sollevato il lenzuolo, conficcando le unghie e strappando, stringendo, ferendomi. Sul materasso c’era una fodera che avevo torto e graffiato.
Il dolore della sua perdita era tutto ciò che mi restava. Gridavo, mentre le lacrime si scioglievano sul viso. E non era più il viso di un dio il mio, ma solo il viso di un uomo. Le mie labbra, disidratate, la nausea. Ero atterrato nuovamente sul mondo dove mi ero innamorato e sentivo ingiustamente che quel pianeta mi aveva aggredito. Inferocito, avevo iniziato a odiare come mio padre.
Per questo lo avevo distrutto, l’intero pianeta era finito in cenere. E il mio amore e la mia perdita dovevano essere una lezione. La lezione di un dio!
***
Dagli angoli di prua della cupola brillavano alcuni flash. Sul nero si aprivano strappi profondi, si rincorrevano fino a dissolversi in tonalità dorate.
Silenziose esplosioni splendevano come se di colpo stessero sorgendo mille soli, la velocità tornava al di sotto di quella della luce. Il passato e il presente si sfioravano, il tempo tornava a scorrere, Patrick riprendeva a invecchiare.
Era arrivato nel suo sistema, ma nessuno conosceva il motivo. Come tutti i vecchi possedeva un angolo di universo. Ora, da quando aveva smesso la cura della pillola, il suo corpo cedeva, ma sperava di avere tempo sufficiente per un ultimo progetto. Per questo aveva chiesto all’A.I. della nave di attivare il droide, per sostenerlo, e per completare quanto lui avrebbe iniziato, se la fine fosse sopraggiunta troppo presto.
«Perché tutto questo?» chiese Patrick al computer di bordo.
Aveva previsto una perdita di memoria, sperava momentanea. Ora si chiedeva dove fosse finito, tutte le sue certezze si facevano confuse.
«Spero che ricorderai abbastanza.» era la sua voce quella, registrata e che lo guidava.
«Venimmo qui ottomila anni fa del nostro tempo, e sulla nostra giovane stella innescammo il raggio T-tauri per accelerare la fusione delle polveri cosmiche, e per creare nuovi mondi di roccia, metallo, idrogeno, carbonio, ossigeno.»
«Ci siamo riusciti?»
«Guarda tu stesso, sono trascorsi centoventi milioni di anni nel tempo del sistema.»
Il viso di Patrick era una maschera di rughe. Le sopracciglia incavate, la pelle screpolata. Sulla fronte i polpastrelli sfiorarono un piccolo cubo di metallo, il lato era poco meno di un centimetro. La pillola nera curava dalla morte. Presa regolarmente impediva di invecchiare. Questo lo ricordava, come ricordava di aver smesso di prenderla.
«Cosa c’è qui, in questa scatola sulla fronte?» chiese confuso.
«La tua anima,» rispose il droide, «ciò che ne resta, quanto basta almeno.»
Sentire la sua stessa voce provenire da quell’essere, che era nell’aspetto del tutto simile a lui, la sua copia esatta parlante, gli fece tornare in mente lo scopo del viaggio. Fu come un’illuminazione, sorrise e il suo sorriso, che sapeva di amarezza, subito dopo si spense.
«Ora ricordo. Dov’è il pianeta?»
Non ebbe il tempo di finire la domanda che l’emisfero superiore di un tenue color smeraldo invadeva metà della cupola di osservazione. Il rigoglio della vegetazione era evidente, si stendeva sulle pianure.
Cime innevate di montagne altissime bucavano i ciuffi di nuvole. Chiazze azzurre di laghi si ricongiungevano nel blu profondo dell’unico oceano verso i paralleli meridionali. Quella era la sua creazione, un pianeta di sua proprietà, forgiato dalla lava dei vulcani e generato dal fuoco delle stelle.
Una vertigine di vanità sembrò tornare nel suo sguardo, ma prontamente, Patrick la ricacciò all’indietro. Frammenti di una vita ordinaria e sepolta spuntavano a caso dalla memoria: reminiscenze di sconosciuti e amici, fitte reti di strade che aveva percorso. Relazioni si ricomponevano, quartieri e veicoli su ruote, fuochi e danze intorno al fuoco. I sogni portavano odori e sapori primitivi, di un passato irriconoscibile, di mondi antichi, visitati e distrutti.
«La carne è il male. Che cos’è un anno se paragonato alla formazione di una intera galassia. Dopo un attimo, il corpo marcisce e muore. L’uomo ha cercato di sottrarsi al suo destino. Stanco di veder appassire così presto le sue facoltà e stanco di seppellire i suoi genitori, premendo la terra sulle loro facce, come se fossero cespi di rafani o cipolle, era stanco di trasformare il suo cranio in nido di vermi. L’uomo si ribellò e con la scure della scienza spezzò le catene della natura, mutò il suo corpo e i suoi geni, vinse la morte. Ma sottovalutò la ragione della sua imperfezione, la giustizia che in essa si celava. Più la carne si rattrappiva, più la sua anima marciva, avvicinandosi alla sua essenza violenta. La vecchiaia mutava in odio un’indole irrequieta. Maggiore potere, maggiore forza lo rendevano privo di scrupoli e crudele. Milioni di tiranni vivevano in crociere infinite attraverso lo spazio profondo, incenerendo interi pianeti per assicurare a un solo essere l’eternità. Era questo il morbo più pericoloso e potente mai esistito, ma che ironicamente venne chiamato “La cura”. In un’epoca remota gli uomini vivevano e morivano vicini, raggruppati in comunità, ora erano esseri cupi, solitari, vagabondi delle stelle e pervasi dal loro potere, corrotti dal male più oscuro, l’odio. L’odio dei vecchi era il prezzo dell’immortalità. Ma c’è ancora una speranza, un’eccezione che può essere tentata…»
Il droide si fermò allarmato, un colpo al petto aveva scosso Patrick. Con le nocche stringeva il punto preciso del petto e per un nonnulla non svenne. Uno dei suoi tre cuori si era fermato. Perle di sudore si formavano sulla fronte, stava cedendo. Il droide lo sorresse, impedendogli di cadere.
«Quanto mi resta?»
«Un’ora, forse due.»
«Muoviamoci allora!»
«Sicuro di non voler avviare la rigenerazione?»
Patrick alzò lo sguardo, febbrilmente cercò le pillole nere, ne restavano ancora diverse, sparse da qualche parte. Sarebbe bastato prenderne una, una soltanto per guadagnare tempo: il cuore si sarebbe ripreso, gli altri due lo avrebbero sostenuto il tempo sufficiente per… esitò… per produrre altre migliaia di pillole di eternità, come quelle, succhiando la vita dal pianeta che brillava sotto di lui. In fondo era suo per diritto, era solo una sfera di carbonio e ossigeno. Lui era uno dei vecchi, uno dei sopravvissuti, perché dover rinunciare alla sua fortuna?
La sua era un’esistenza preziosa, che aveva attraversato ere e generato mondi, non era paragonabile a forme inferiori di rettili o pesci che vagavano confusi tra terra e acqua su un minuscolo sasso perso nell’infinito.
Da tempi immemorabili i vecchi facevano così, si nutrivano delle vite inferiori per rigenerarsi. Aveva già distrutto due mondi abitati prima di quello, e non aveva mai esitato nel farlo. Aveva spazzato via il mondo di sua moglie. Per la rabbia di averla persa, aveva sterminato l’intera civiltà umanoide dei Tarsum, senza battere ciglio, cosa era cambiato?
In poche ore lui sarebbe stato salvo e la sfera sotto di lui sarebbe diventata arida e deserta, come tutte le rocce di cui è pieno lo spazio.
Non cedette. Ancora il viso di sua moglie lo soccorse; Forse sotto la placca di metallo sulla fronte, dentro gli ultimi nove millimetri di carne viva, era conservata la sua anima e il ricordo della parola amore.
Erano stati sposati per soli tre anni, ma ecco tornato a salutarlo il suo viso. Si era voltata, un’onda di capelli castani svelava i lineamenti a lui così cari. Arrossiva facilmente, su una carnagione che rapidamente mutava i toni del bianco. Portava orecchini di opale, i suoi occhi splendevano di un trucco dorato. Il naso era contornato di lentiggini, con le labbra socchiuse gli sussurrava di tenere duro, qualche attimo ancora.
***
Non portò molto con sé, solo un minuscolo riproduttore sonoro. Gettò l’ultimo sguardo al suo riflesso sul metallo trasparente della cupola: alto, il viso glabro, ma segnato da rughe profonde, i lineamenti aristocratici e duri. Il suo aspetto non incuteva timore né tradiva esitazione. L’espressione era vaga, ma ancora insolente. Nonostante i secoli passati non aveva superato le sue paure.
«Portami giù.»
«Non protesteranno? Non si insospettiranno?»
«No, perché prenderai il mio posto. Questo sarà il tuo giardino e il tuo acquario… sono pochi, ma conosco vecchi che ne hanno. Ogni tanto tornerai a vedere cosa succede. Nemmeno mio padre potrà dubitare di te. Le tue banche dati sono talmente piene di me, che sei più reale di me stesso.»
«Perché rinunci alla vita?»
«Sono stanco di vivere in una inutile crociera, sono stanco di distruggere e di prendere. Non trovo un senso nel domani, ma posso trovarlo nella fine. Nella mia giovinezza è rimasta sepolta la felicità. Come vedi, ho molte risposte per un’unica domanda. Muoviamoci, c’è una speranza, un’eccezione che può essere tentata…»
«Se l’intelligenza fosse donata a una specie più mite e meno aggressiva. Una specie capace di trovare un’altra possibilità!» il droide completò la frase. Lo stava mettendo alla prova, voleva essere convinto che fosse lucido.
Patrick si spazientì, per dimostrare la sua fermezza ricordò con estrema semplicità quanto dovevano ancora terminare:
«L’anima di uno squalo bianco è diversa da quella di una balena, eppure sono entrambi dominatori del mare. Pur essendo plasmati dall’oceano e condizionati dagli stessi fattori ambientali, tanto che assumono una forma simile, il primo resta un pesce aggressivo e violento, l’altro mite e armonioso; questo è dovuto a una diversa natura. La crudeltà è figlia dell’uomo! Muoviamoci!»
***
Il silenzio accompagnava il breve viaggio, il computer aveva scelto il luogo migliore, planando dolcemente in quella che dallo spazio assomigliava a una goccia di verde.
Nella mente di Patrick Giuppi si sovrapponevano i pensieri ai ricordi. Non sapeva quanto fosse passato dalla nascita dell’ultimo neonato, e questo gli parve un abominio, come se fosse lui stesso colpevole di aver ucciso il futuro per fermare il presente.
Le forze erano quasi esaurite. Si era assopito un momento per riprendere fiato. Sentiva la voce del droide in lontananza, sotto i piedi nudi scopriva la terra umida, steli d’erba soffici, tagliati da ragnatele di rugiada:
«Riesci a sentire il profumo di erba calpestata, trasportato dal soffio del vento?» chiese il droide.
Il silenzio scendeva dalle pendici del picco, accompagnato dal lento allungarsi delle ombre dei boschi. Il tramonto infiammava nastri sciolti di nebbia all’orizzonte. Era giunta l’ora in cui esseri simili a caprioli prendevano coraggio e le loro piccole corna a forma di rami scansavano i cespugli.
Piccoli animali dalla pelliccia dorata, golosi di erba e radici, si mimetizzavano tra le tenebre. Rimasti per tutto il giorno appartati, al riparo dai predatori, battevano i lunghi itinerari per scendere verso la radura.
Patrick Giuppi era morto contemplando questa carovana di animali benevoli. Il suo droide lo aveva seppellito in quel luogo lontano, in un bosco fitto di alberi che ricordavano le betulle, gli olmi e le querce.
Occhi rossi, non visti, fissavano la scena dal profondo della notte, sulla sommità dei rami. Sei paia di occhi, silenziosi e appostati, contemplavano il rapido movimento delle mani del droide.
Quest’ultimo aveva un frutto rotondo e rosso, vi inserì un minuscolo involucro di metallo, era quello che stava prima sulla fronte di Patrick. Una debole luminescenza si dissolse a contatto col frutto.
Lo aveva lasciato su una sporgenza di roccia, proprio lungo il sentiero dei nobili animali che avevano visto e poi si era allontanato.
Infine, aveva posto a terra, accendendolo, il minuscolo riproduttore sonoro. La voce di Patrick Giuppi riecheggiava tra i fusti degli alberi, era l’ultima parola di un dio:
«Ho odiato mio padre e lui ha odiato me fin da quando sono stato generato. Pensavo che la mia vita fosse sconvolta da un’interminabile malattia insita nella specie umana e chiamata “l’odio dei vecchi”; poi ho considerato che potesse trasformarsi in una lunga convalescenza, che attraverso un ripensamento potessi estirpare tutto il veleno di cui abbiamo intriso la speranza, rinchiudendoci in un’epoca immobile. In principio la morte, sopraggiungendo dopo appena ottant’anni, ci garantiva di scorgerne solo i primi sintomi. Avevamo appena il tempo di percepire una qualche traccia di arroganza. Una velata prepotenza si affacciava insieme alle rughe più profonde, si intuiva insieme agli scatti d’ira più frequenti, ma la saggezza di una fine certa riusciva a compensare la nostra natura di scimmie, aggressive e spietate. Da mortali, sapevamo dare valore alla giovinezza e al senso di curiosità. Oggi invece, prolunghiamo la vecchia, dilatandola all’infinito. Crediamo di curarci dalla mortalità, ma tutto questo ci ha portato ad acuire lo spirito malvagio della nostra natura. Esaurite in fretta le novità, è stato come se milioni di possibilità, in miliardi di anni si fossero collegate in un unico libro, letto e riletto così tante volte da rendere lo straordinario asfissiante e monotono. Per questo io, Patrick Giuppi, ho deciso di morire qui e come mia ultima volontà sperimento un nuovo innesto, un nuovo inizio. Un seme di intelligenza ha potuto generare, nel nostro caso, una ginestra spinosa, amara e velenosa, così voglio trasmettere a una specie erbivora e nobile, non aggressiva, certe facoltà superiori, e sono certo che questo porterà del bene nell’infimo paradiso che abbiamo costruito e che è solo una casa di bambole. Sarà forse un nuovo capitolo nella lotta tra istinto e ragione, sarà forse una nuova era? I miei geni, un frammento di me, un pezzetto della mia anima, troveranno la strada della redenzione. Forse non sarò dannato, dopo aver vissuto da schiavo, oggi muoio libero!» la voce si spense al calare della notte.»
***
Il frutto, lasciato dal droide, era tondeggiante, appetitoso e croccante; dalla cavità superiore spuntava un picciolo, attendeva di trasmettere il suo dono. Un seme di intelligenza, ciò che restava dell’anima millenaria di Patrick Giuppi si sarebbe tramandato in una nuova specie. Questo era stato il suo ultimo esperimento, bastava che il frutto fosse mangiato per mutare nella discendenza del suo ospite capacità inaspettate e grandiose, codificandole in precise alterazioni del DNA.
Il muso umido di uno dei ruminanti si avvicinò alla roccia, richiamato dal profumo dolce e dal rosso invitante, ma quando aveva aperto la bocca e i suoi denti squadrati stavano per dare un morso, fu colpito da un sasso sulle corna.
Scosse la testa, poi arrivò un urlo stridulo.
Un nuovo sasso, più grande, lo centrò. Un fischio risuonò ancora più forte. L’animale deglutì nervoso, osservando interdetto il nulla, con le grosse pupille marroni sgranate, incastonate nell’ossatura sporgente delle corna. Cercò nella direzione delle grida, non trovando che ombre.
L’animale, simile a un capriolo, voltò ancora la testa confuso.
Un movimento dai rami più alti rivelò la discesa di una scimmia, i suoi occhi rossi e cattivi fecero fare un saltello indietro al capriolo. Aveva provato a sostenere lo sguardo, ma un altro sasso lo scacciò definitivamente, due balzi e il capriolo si era dileguato lungo il sentiero, verso la radura e il suo branco.
La scimmia soffiò in direzione delle altre due che l’avevano raggiunta.
Quelle videro il frutto e subito cercarono di mangiarlo. Ma la prima, più grossa, iniziò a mostrare i canini, a sbuffare e a battere i pugni a terra. Le sfidava, smuovendo il fogliame e strappando l’erba. Solo una delle due si era fatta avanti.
Era scoppiato un parapiglia, ma la prima scimmia con un sasso piatto e pesante, ancora stretto tra le dita, aveva colpito a morte l’avversaria dietro la nuca.
Calpestava e scalciava un corpo privo di vita, che aveva spento senza un particolare motivo. Poi si era voltata, l’altra era immobile, abbassava la testa.
Sotto il naso schiacciato, la scimmia aprì la bocca in segno di vittoria, i denti larghi disegnavano un ghigno, gli occhi piccoli scintillarono. Mangiò il frutto e soffiò soddisfatta, battendosi il petto.
In un paradiso malato, in cui non si festeggiavano più i compleanni, in cui una nuova nascita era vista con risentimento, perché significava la morte di un vecchio, la natura stava organizzando la sua vendetta.
Questo potere, in fondo, l’odio della vita, l’odio dei vecchi, si sarebbe moltiplicato, aggravato, proprio per mano di chi avrebbe voluto contrastarla.
Patrick Giuppi aveva contribuito alla nascita di una nuova razza di scimmie, ancora più mostruose e spietate di quelle che avevano generato l’uomo. C’era una sorta di umorismo crudele in tutto questo, perché il frutto che lo avrebbe rese possibile era del tutto simile a una mela.
***
“Little Fly
Thy summer’s play,
My thoughtless hand
Has brush’d away.
Am not I
A fly like thee?
Or art not thou
A man like me?
For I dance
And drink & sing;
Till some blind hand
Shall brush my wing.
If thought is life
And strength & breath;
And the want
Of thought is death;
Then am I
A happy fly,
If I live,
Or if I die.
William Blake, The Fly, 1795”
Dedicato a Jerome Bixby, autore di “The Man From Earth”.
La traduzione della poesia di William Blake è offerta da Cose da Altri Mondi:
La mosca
Piccola mosca,
Questo gioco d’estate
La mia spensierata mano
Ha spazzato via.
Non sono io
Una mosca come te?
O non sei tu
Un uomo come me?
E io danzo
E bevo, e canto,
Fino a quando una mano cieca
Spezzerà la mia ala.
Se il pensiero è vita
E forza e respiro
E il desiderio
Di pensiero è la morte;
Allora sono
Una mosca felice,
Se vivo,
O se muoio.
Tratto da https://lyricstranslate.com/it/fly-la-mosca.html-2

Diego Rossi
Fisico, classe ‘75; scrive anche con lo pseudonimo Mr. Onion. Ha pubblicato "Io sono cattivo", Iride - 2009 e "Cyber poker", DGS3 - 2012. Ha vinto nel 2013 il XLII concorso nazionale per il racconto sportivo del CONI, è arrivato secondo al premio internazionale Alberoandronico del 2018. Nel 2020 ha pubblicato sulla “Bottega del Barbieri” il primo racconto di SF “Anja 44i” e il secondo per Watson “Il cane verde”