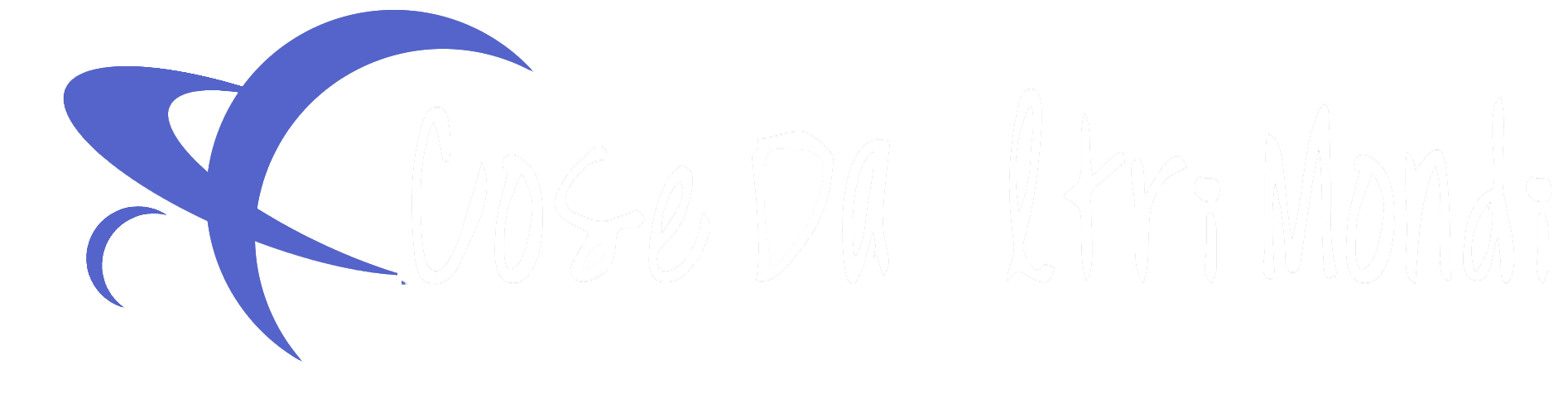UN ANACRONISMO

ovvero Perdere la corsa della carrozza
(An Anachronism, or Missing One’s Coach, Dublin University Magazine, giugno 1838)
La copertina di ‘Un anacronismo‘ è di Roberta Guardascione
Questo racconto apparve per la prima volta sulla Dublin University Gazette nel 1838, una rivista che pubblicava articoli di filosofia e politica, oltre a racconti narrativi originali. Una sua prerogativa è che i suoi scritti apparivano senza il nome dell’autore, solo con il titolo. Se oggi sappiamo che fra i suoi autori c’erano scrittori famosi come Sheridan Le Fanu e Oscar Wilde, è perché i loro contributi furono poi ristampati in altre sedi con le loro firme. An Anachronism è apparso da allora in diverse antologie in lingua inglese, anche recenti, ma sempre attribuito ad “Anonimo”. È considerato il primo esempio di racconto che tratta il tema del viaggio nel tempo, eppure, stando alle mie ricerche, non è mai stato pubblicato in italiano. Se ho ragione, questa curata dal sottoscritto è la prima traduzione in italiano. Se qualcuno conoscesse precedenti traduzioni in italiano ce lo potrà comunicare.
Mario Luca Moretti
Gentile e fiducioso lettore, e non mi rivolgo a nessun altro, ti sia reso noto che io sono uno di coloro che frugano nei recessi degli antiquari, e che per giunta appartengo a quella tribù mai paga di lunghe passeggiate solitarie, in cerca di relitti e reliquie di cose dimenticate, dimenticate da tutti ma non dalla famiglia dei “Sotuttoio”. E non dovrei nascondere il fatto che (quando un giorno di cammino non è bastato a portarmi verso i monumenti di epoche remote) io sono portato a indulgere in speculazioni filosofico-poetiche concernenti il futuro; in questo modo prendo in prestito dal tempo venturo passatempi per il tempo presente, al posto di quelli che dovrebbero fornirmi i tempi andati. Molte insegne “San Giorgio e il Dragone” o “Robin Hood”, dove ho trovato rifugio per la notte, sono state testimoni dell’economica felicità che ho creato per me stesso in mezzo a queste meditazioni su futuro e passato.
Durante molti afosi giorni dello scorso agosto, o se preferite, di qualche altro agosto, mi ero alzato al primo albeggiare, e mi ero spinto nel mio pellegrinaggio fino al tramonto, seguendo attentamente il sentiero della muraglia di Pict, a partire dalle spiagge di Solway Firth, in direzione est. Sul finire dell’ultimo di quei giorni, tutte le mie riflessioni sul passato, come pure ogni piacevole e luminoso sogno sul futuro, erano stati consumati, o avevano perso il loro abituale fascino sulla mia immaginazione, in parte a causa della mia stanchezza fisica e della mia fiacchezza mentale, e in parte per l’intrusione da ogni parte, di oggetti decisamente lontani dal sentimento e dalla speculazione di qualunque tipo, fosse essa retrospettiva o anticipatrice; il che m’impediva qualunque pensiero che non riguardasse i vivaci interessi della generazione attuale. Chi, domando io, può essere poetico a 10 miglia da Newcastle-upon-Tyne?
Non pensate che io disprezzi la città e i suoi dintorni, da dove si dipanano ogni giorno incalcolabili flussi di comodità, cibo e illuminazione a gas, per non parlare dei benefici delle nostre spiagge orientali!
Entrai in questo radiante, se non radioso mercato di carbone, alle 5 del pomeriggio – zoppicante, assetato, nero di polvere, e spogliato di ogni sentimentalismo; e nonostante l’orrore che provo – un orrore istintivo, irragionevole per le grandi città commerciali e industriali, in quel momento il mio spirito era talmente a pezzi e i miei piedi così indolenziti, che mi rassegnai passivamente a passare la notte nella migliore locanda che si degnasse di accogliere un viandante impolverato, ma con un portafoglio in tasca.
A questo scopo, feci una discreta cernita fra i caravanserragli di Newcastle, abbassando il mio orgoglio al livello di un albergo di quarta categoria; e lì, assumendo una certa aria di importanza, mi assicurai il riguardo e i buoni servigi di camerieri, portabagagli e di una servetta e fui ristorato nel giro di due ore, dopo di che mi ritrovai un uomo nuovo, o meglio di nuovo me stesso; insomma né tanto nuovo né tanto vecchio; ma per lo meno adesso ero sbarbato, rinfrescato, riposato, nutrito, e per giunta vivificato da una sobria pinta di cattivo sherry. Per farla breve, alle 7 cominciavo a riammettere in testa sciami di “belle idee” e a gingillarmi con esse che si affollavano attorno ai miei vivacizzati sensi.
In questo stato d’animo, proprio perché un uomo prudente l’avrebbe fatto, mi sembrò fuor di questione restare dov’ero: in una buia sala da caffè macchiata di fumo. Proprio nel cuore di una Babilonia come Newcastle.
Sebbene chiunque al mio posto avrebbe pensato di aver camminato già abbastanza per quel giorno, io decisi di correre fuori; eppure non intendevo fare altro che occupare il letto che avevo affittato; o forse meditare per un po’ all’ora del crepuscolo sulla riva del fiume, se avessi trovato uno spazio libero. Avvenne comunque che, zoppicando per la piazza del mercato, diretto verso le banchine, fui quasi investito dall’impetuosa carrozza “Edinburgh and Leeds Mercury” che in quel momento svoltò l’angolo con le sue quattro ruote fumanti. Si fermò – e io mi fermai – e, pensando a malapena a quel che dicevo, mi avvicinai al postiglione, mentre toccava il suolo, con la laconica domanda: «C’è posto?», alla quale ricevetti la non più verbosa risposta:
«Solo per uno, signore.»
«Quando partite?»
«Fra 10 minuti, al completo.»
«Mi tenga un posto sul davanti, allora.»
Alla prima vista del “Mercury”, nella mia mente scattò il confronto fra una soffocante camera in una tetra locanda per la notte, e gli splendori del cielo e le glorie della prossima alba – mai meglio gustate che all’esterno di una carrozza notturna nei mesi estivi. Questo immediato confronto spazzò via tutti i miei piani e persino sentii svanire le mie sensazioni di fatica corporea.
Tornai di corsa all’antro al cui interno pensavo che avrei boccheggiato fino al mattino. Pagai il conto – dispensai mance a camerieri, facchini e servetta; afferrai il mio zaino, e con la precipitazione di un uomo che ha appena scavalcato le mura di un carcere e con l’orecchio teso ai suoi inseguitori, zoppicai verso il grande “Commercial”, da dove dovevo partire.
Scoprii che le prime chiamate non erano ancora state emesse. Afferrai il postiglione per la manica e gli dissi che volevo far due passi, e mi incamminai, come a sottolineare l’inaspettato piacere della mia fuga da Newcastle, o come per prevenire ogni possibile delusione, sebbene, col senno di poi, sarei stato molto più saggio a occupare il mio posto sulla carrozza e a sopportare la fuligginosa atmosfera della città qualche minuto in più, come dimostrarono gli eventi successivi.
Invece, disprezzati i banali suggerimenti della prudenza, passeggiai con un affrettato, saltellante passo in mezzo alle strade declinanti e sopra il ponte che scavalca le profonde acque del Tyne, risalendo poi la ripida collina di fronte a Durham Road dalla cui sommità si dipana, a est e a ovest, una prospettiva ampia e bella (quando non è imbrattata dal fumo).
Forse un cocchiere puntiglioso, esaminando il sentiero, o un passeggero in ritardo avrebbero ritardato il Mercury oltre i “10 minuti” concessi dal postiglione. Di fatto, quando raggiunsi la cima della collina, invano mi misi in ascolto delle ruote cigolanti, o del corno.
In quello sfortunato – o forse fortunato – momento, io notai, un po’ sulla sinistra, un monticello da cui si poteva agevolmente vedere il corso del fiume. Col rischio (quasi la certezza) di perdere il mio posto, mi lanciai verso questa salita; e trovando un punto tentatore sulle nodose radici di una quercia morta, mi ci sedetti; sì, proprio così; e, dirà il mio scettico lettore, mi ci accomodai e addormentai.
Non sono convinto che questa sia la spiegazione di ciò che seguì; ma anche ammettendolo, non è meno certo che io mi sia guardato attorno, dacché mi ero seduto con la stessa chiara percezione della realtà che avevo poco prima quando avevo mangiato una bistecca allo Swan.
Forse ci saranno alcuni che mi insulteranno, insinuando, che, stanco come io stesso confesso di essere stato, ero sprofondato nel sonno sul mio divano nella sala da caffè, con l’ultimo mezzo bicchiere di “cattivo sherry” davanti a me; e che l’intero affare del Mercury non sia stato altro che un sogno di una notte di mezza estate.
Non mi degnerò di discutere questo punto con tali obiettori, fin troppo saggi nelle loro stesse opinioni; ma in tutta semplicità continuerò a riferire di come, seduto su quella menzionata poltrona naturale, mi guardassi attorno e sotto di me, e cercassi invano, in lontananza, i tetti, e le ciminiere e le guglie della squallida Newcastle – le sue intrecciatissime banchine, le sue focose fornaci, i suoi falò luminosi alle bocche dei pozzi; o, per farla breve, un qualunque oggetto tipico dei tempi moderni, o delle ferventi meraviglie di una metropoli di fuliggine; e di tutto ciò che fino a un momento prima si dipanava di fronte a me.
Invece di tali familiari apparizioni, abituali nel tempo corrente, nell’agosto del 1837 (o agosto di qualche altra data recente), c’era, è vero, lo stesso cielo splendente, e lo stesso paesaggio campestre sullo sfondo; lo stesso fiume tortuoso, che però si torceva in modo un po’ diverso, e si vedeva solo a tratti in mezzo a rigogliosi gruppi di alberi.
Eppure invece della vasta città e delle sue strutture, scrutavo una selvaggia solitudine; forse non una solitudine, non sarebbe esatto, ma qualcosa di simile. Il terreno attorno a me era una foresta incolta, attraversata da rozzi sentieri, eppure lungo il lato della collina, e nei pianori al di sotto, notavo molti piccoli recinti, ciascuno contenente un tugurio o una capanna, e al cui interno cerano segni di una frugale accoglienza. I tratti verso nord e verso ovest erano fitti di ampie foreste, per lo più dall’aspetto tetro, cupe e ombrose come oggi, subito sotto quell’abbagliante distesa, dove il sole era appena calato.
Ma ora – lo preciso, lettore – la cosa più sorprendente in questo istantaneo mutamento di scena, fu che io lo osservavo con freddezza, come se non ci fosse nulla di sorprendente; come se fosse quello che mi ero aspettato, come se lo avessi osservato un centinaio di volte.
Mai in vita mia mi ero sentito più me stesso, più sveglio, o più tranquillamente familiare e confidente con le cose attorno a me. Non avvertivo alcuna eccitazione, nessuna poetica elevazione, nessuna meraviglia, nessuna sensazione esasperata; non c’erano fantastiche miscele di chimere con realtà ordinarie; tutto all’interno e tutto all’esterno era sobria realtà.
Io, che quello stesso pomeriggio ero entrato allo Swan coperto di polvere – io, che solo pochi minuti prima avevo prenotato la mia corsa per Leeds e ascoltavo la chiamata della carrozza – lo stesso reale e veritiero io – ora fissavo uno scenario del tutto diverso in aspetto e sostanza.
Nel guardarmi attorno, mi accorsi di un rozzo personaggio – lo chiamerò contadino o rustico – che stava trascinando i suoi stanchi passi verso casa – se così si poteva chiamare quello che era l’incavo di un albero. La sua testa scoperta era arruffata da una zazzera pel di carota, che spazzolava le sue spalle ampie e nude, e quasi nascondeva un florido viso tagliato quasi come una falce, segnato da disperata cupezza, da selvaggia insensatezza, con le quali la crudele schiavitù deforma l’aspetto umano.
Un giustacuore di lana strappato, del più grezzo tessuto, lasciava scoperto il suo ispido petto e le sue braccia muscolose. Quell’uomo, e ciò mi stupì ancor più della sua strana apparizione, mi passò tanto vicino da sfiorarmi quasi coi suoi stracci, eppure sembrò che non mi avrebbe notato di più se fossi stato un’anima dipartita. Lo accostai con la domanda: «Che posto è questo?»
Trasalì al suono della mia voce, ma guardò in direzione opposta, come se si fosse sentito chiamare da lontano, ma non vedendo nessuno, tirò dritto.
Eppure, non appena la domanda fu scappata dalle mie labbra, la risposta a essa uscì dai miei ricordi. Dove sono? Dove dovrei essere dopo aver passato il corso del Tina – dove, se non di fronte a Gaetshefed? Sì, Gaetshefed (Gateshead), e a portata di mano dev’esserci il sacro Girvum (Janoro), e l’appartato chiostro del colto e venerabile storico della chiesa britannica e sassone!
Mi guardai attorno, e sebbene dovessi fare poca strada per soddisfare i miei semplici dubbi topografici, sarebbe stato sufficiente a farmi perdere ogni speranza di prendere il Mercury; eppure mi capitò, o almeno mi sembrò di scorgere una fila di edifici, seminascosta da un boschetto di querce, all’apparenza appena usciti dalla mano del muratore, regolari nella forma, ma non grandi in larghezza o in altezza.
La struttura principale era circondata da un basso muro smerlato di pietre a secco, attraverso il quale si accedeva a un rozzo cortile da uno stretto passaggio, occupato da stalle e legname sparso. Dietro l’edificio, comunque, vidi un muro molto più alto, che all’apparenza circondava un giardino.
L’edificio stesso – il monastero, perché di fatto quello era – presentava, nel suo aspetto generale, le caratteristiche combinate di una chiesa, una fortezza, una prigione, una magione signorile e una fattoria – almeno c’era qualcosa, proprio di ciascuno di questi stili di costruzione, discernibile in questo santuario di pietà, i cui abitanti, che dedicavano le loro vite in primo luogo alle opere di carità, occupavano quel terreno in mezzo a orde senza legge, in parte aiutati da difese concrete, in parte dal timor di Dio.
Nel frattempo, pur sottoposti a volontaria carcerazione (così come il ragno si sostiene alla ragnatela che lui stesso ha tessuto), esercitavano una potente e lucrativa giurisdizione sulle lande circostanti, e in attestazione della terrena realtà che risultava da questa influenza, potevano esibire una sala abbastanza grande da contenere foraggio e bestiame di ogni sorta.
L’edificio principale, oblungo nella sua forma complessiva, si alzava all’altezza di due piani, o piuttosto di un piano e mezzo.
La posizione delle finestre superiori e delle feritoie sembrava indicare che gli appartamenti più elevati, o le sale del pianterreno, fossero sormontate da minuscole camere, o da bassi chiostri vicino al tetto.
Una torre circolare sosteneva ciascun angolo del fronte occidentale dell’edificio; e curiosamente queste torri erano circondate da audaci estensioni in mattoni, come degli anelli, a intervalli regolari dalle basi fino alle sommità delle torri.
A conti fatti, chiunque avesse abbastanza equilibrio, avrebbe potuto scalare le torri usando quegli anelli come gradini. I lati dell’edificio erano adornati e sostenuti da pilastri, ognuno dei quali esibiva come capitello una severa scultura, ognuna delle quali rivaleggiava con la sua vicina in assurdità.
Sul lato meridionale dell’edificio, vicino alla torre, c’era una porta ad angolo in quercia, alta e massiccia, dagli stretti pannelli e dalle linee ampie, rafforzata da pesanti sbarre, che si chiudevano all’interno.
Questa porta doveva aprirsi in rare occasioni, a giudicare dall’erba cresciuta attorno alla soglia. Pochi piedi di fronte all’altra torre, quella settentrionale, c’era una colonna isolata, sottile e contorta, sormontata da un santo – voglio dire, l’immagine di un santo, presumo St. Cutberto, il fondatore.
Una fila di stretti gradini di pietra, partendo dal muro fra le due torri, e assicurata da un sottile corrimano, portava a una sala balconata all’aperto, o anticamera, fronteggiata da una tenda, che appoggiava su fantastici piloni in legno.
Da sotto, dove stavo io, si potevano discernere le strette aperture nei muri interni di questa sala, attraverso le quali parsimoniose quantità di aria e luce passavano agli appartamenti interni.
Mi avvicinai ai sacri ricetti con una curiosità non comune; non invitato, attraversai la porticina del recinto esterno, al cui interno trovai una variopinta assemblea di persone, e più trambusto e chiacchiericcio di quanto ci si aspetterebbe di vedere e ascoltare in un così sacro luogo.
Diversi gruppi occupavano l’area di fronte al monastero; qualcuno stava salendo e scendendo la fila di gradini, e sulla balconata si scorgevano tanti gruppi, quanti ne poteva ben contenere, e lo stesso nella sala o nel corridoio aperto già menzionati.
Queste persone, alcuni laici, altri religiosi, lontani dal mostrare l’umile raccoglimento che si ritiene conveniente a una pia dimora, erano impegnati in accese e, talvolta giocose discussioni, o pettegolezzi, i cui soggetti non erano necessariamente elevati o importanti.
Gustose facezie, a giudicare dagli scoppi di risa con cui erano salutate, ravvivavano poi questi colloqui e un corpulento monaco, le cui morbide guance esprimevano una luminosa felicità interiore, quale che ne fosse la fonte, in realtà faceva risuonare gli echi delle sue allegre risate contro le mura del monastero, mentre ascoltava la storiella raccontata da un laico magro e ossuto, che aveva l’aspetto di un viaggiatore.
Ai piedi degli scalini di pietra, con un piede alzato e un’aria di impaziente attesa, stava un giovane confratello della casa, la cui tunica fluttuante era trattenuta supplichevolmente da un servo della gleba, o villano, che sembrava implorare una qualche richiesta di giustizia a un orecchio sordo, oppure richiamare dei ricordi a una memoria ingrata.
Nella sala al di sopra c’erano alcuni personaggi di rango superiore, all’apparenza sia religiosi che laici – gli amministratori della casa – e due o tre proprietari terrieri, il cui atteggiamento verso i confratelli, benché di sottomissione, non era di mendicanza. Qua e là potevo però notare che le stoffe pregiate e il taglio curato di alcune di queste mortificate persone esibivano un’ostentazione e un costo persino maggiori di quanto fosse discernibile nell’abito del laico meglio vestito presente alla festa.
Un commento appropriato, pensai io, al monastico aforisma di San Gregorio: ” Quid est habitus monachi, nisi des, pectus mundi?“. E mi sovvenni anche di un’altra regola dello stesso sant’uomo: “Ne mulieres in monasterio tuo deinceps qualibet occasione permittas ascendere” – perché, guardando in su, vicino alla sommità di una delle già menzionate torri, a una finestra su cui erano appoggiati molti grandi vasi di fiori di campo, c’era una ragazza bellissima, i cui capelli biondi riflettevano le sbiadite glorie del cielo dell’ovest, indaffarata nell’innaffiare con un fascio di giunchi le piante che contenevano. Non ditelo a Roma!
In mezzo a questo andirivieni, a questi allegri pettegolezzi, ora mi fermai, ora scivolai qui e là, ignorato; o piuttosto sembrava che nessuno di quegli occhi avesse la facoltà di fissarsi sulla mia sostanza corporea; o che, tra la mia esistenza e la loro, fosse venuto a mancare il legame di comunicazione corporea.
Intanto, dall’area di sotto io fissavo i bui recessi della sala superiore, desideroso e insieme timoroso, di salirvi. Notai una stretta porta nell’angolo estremo, che si aprì lentamente, e di colpo apparve in cima ai gradini una corpulenta ma malferma figura – un reverendo monaco, reverendo davvero – reverendo per maestà d’intelligenza e qualità personali.
Egli afferrò con fermezza il corrimano della scalinata, preparandosi a scendere i gradini, e si fermò alcuni minuti per concludere la conversazione con un confratello importuno che lo aveva seguito, così sembrava, dalla porta della sua cella e che lo tormentava con qualche pettegolezzo impertinente.
Dopo aver cortesemente ma sbrigativamente cacciato questa zanzara, il monaco si portò avanti, scivolando lungo i gradini, aiutando i suoi arti irrigiditi con la forza del suo forte braccio. Quando arrivò in fondo, aveva evidentemente fatto un non lieve sforzo per tagliare la folla, a una tale velocità da scoraggiare chiunque cercasse di trattenerlo per la manica.
Si fece strada, indisturbato, attraverso il cortile, e verso il limite orientale del convento, dove c’era l’ingresso al giardino. D’istinto mi spinsi avanti per seguirlo e accostarlo.
Mai prima mi era capitato di incontrare un vecchio amico per strada, o a un crocicchio, con una più spontanea, facile e confidente impressione di familiare conoscenza – mai ho stretto la mano di qualcuno e detto «Come stai? Come stanno a casa?» – mai ho guardato un viso noto e sorridente con un sentimento più sicuro di quello con cui, mentre fissavo il mio sguardo sul volto di fronte a me, esclamai: «Il venerabile Beda!»
E non appena ebbi parlato, il vecchio, volgendosi un poco e abbassando il cappuccio che gli ostruiva un poco le orecchie col suo dito medio (un gesto tipico) mi diede uno sguardo di reciproco riconoscimento, lanciandomi un “come stai”.
Ora, per strano che possa sembrare, è un fatto che questo scambio di saluti, come se Beda e io fossimo stati vecchi amici, non mi diede più sorpresa di quanta ne avessi provata quando gli anneriti tetti di Newcastle lasciarono il posto alle macchie di foresta e alla natura di un’altra epoca.
Affrettai il passo; il monaco rallentò il suo e io fui subito al suo fianco. Essendo più alto di me, mise la mano sulla mia spalla e conversando in maniera piacevole e (posso dire così?) confidenziale, entrammo insieme nel giardino del convento.
Era una recinzione di ampie dimensioni, ben tenuta e sembrava ben fornita di qualunque cosa: una ben munita cucina dal mondo vegetale. Raggiungemmo una panchina all’angolo estremo del giardino, sopra cui pendeva una zucca, e sedendoci ci gustammo la quiete di quella scena, tenuemente svelata dal cielo luminoso.
Nel tentativo, che ripetutamente ho fatto da allora, di ricostruire la porzione precedente della conversazione, mi sono sempre sentito come se una pagina, o una mezza pagina, di quel resoconto fosse stata strappata in quel punto; e così, sebbene ogni sillaba del nostro discorso successivo rimanga fissata indelebilmente nella mia memoria, la sua parte iniziale è del tutto scomparsa.
Allora basti dire che, nel momento in cui io ritornai in completo possesso della mia coscienza, il venerabile monaco e io stavamo conferendo amabilmente su vari argomenti legati alla sua epoca, o alla mia, ed entrambi avevamo la chiara consapevolezza, e il perfetto ricordo, del fatto che lui stava di fatto vivendo nell’ottavo secolo, e io altrettanto realmente nel diciannovesimo; e questa minuscola differenza di almeno 1000 anni – questa frattura, come l’avrebbero chiamata i geologi – questa faglia negli strati del tempo – non turbava o impensieriva nessuno di noi, neanche un po’; non più di quanto sarebbero infastiditi due amici dalla circostanza che un loro incontro capiti mentre arrivano da emisferi opposti.
«C’è un mondo di cose» dissi io, «di cui potrei parlare, che potrei riferire, che a te non dispiacerebbe ascoltare, che sono successe nella florida Albione in questi ultimi mille anni. E c’è anche un mondo di cose che tu potresti descrivere a me, riguardo alla tua epoca, su cui la Storia, capricciosa e avara com’è, ha deciso di non informarci. E ti assicuro che da questo genere di informazioni, per le quali oggi c’è una famelica curiosità fra i miei contemporanei, potrei trarre un buon guadagno – anzi, ricavarne una fortuna, se ben elaborate. Ma dobbiamo far tesoro del nostro tempo, scegliere i momenti così come sono; per quanto tempo tu possa avere a disposizione, io posso a malapena contare su cinque minuti, perché, sappi, io sto aspettando che mi prenda il Leeds Mercury.»
«Il Leeds Mercury!»
«Ahm, avrei dovuto dire Lhydes, e mi avresti capito.»
«Capito! Non voglia il Cielo! Forse che allora il popolo di Eborascyre, dopo essere usciti così pienamente dall’idolatria, ed essersi consegnato al grembo della Chiesa, è ricaduto nel paganesimo? È tornato all’orrida adorazione del suo Wotan – del suo Mercurio? E cos’è questo esser preso che tu aspetti? Sei in procinto di un’apoteosi, o di un arresto da parte degli ufficiali di giustizia?»
«Né l’uno né l’altro; e possiamo impiegare i nostri fugaci momenti meglio se non entrassimo nella spiegazione delle frasi che io sventatamente lascio cadere. In breve, stai sicuro che non sono né sulla strada delle stelle né della prigione.»
«Allora che questa difficoltà resti in sospeso fino al nostro prossimo incontro. Nel frattempo, e dal momento che puoi essere portato via da me in qualunque momento, permettimi, prima che entriamo in argomenti più importanti, di chiederti in una parola – perdona un vecchio, e uno scrittore recluso, che ha ricevuto scarsa giustizia dai suoi contemporanei – perdonami se ti chiedo cosa ne è stato del nome e degli scritti del – dell’indegno Beda?»
Un rossore, prima di umana modestia, poi di religiosa vergogna e di rimorso, salì lungo la distinta figura del vecchio – un rossore che risalì fino alle tempie, e suffuse la sua fronte ampia e liscia di un cremisi simile al cielo occidentale che splendeva allora, e anche di una rugiada simile a quella che stava scendendo sulla terra. E pulendo il volto con la manica, lui continuò prima che potessi replicare: «No, ritiro la mia sconveniente domanda – non rispondere a uno stupido accondiscendendo alla sua stupidità – nil tam inglorium, quam gloriae cupidum, deprehendi.»
«Molto vero,» dissi io, «ma, in parole povere, se i grandi uomini e i grandi scrittori solo sapessero, nella loro vita, a quale umile briciola si ridurrebbe la loro reputazione alla fine di mille anni (o anche solo di cento), sull’ampia tavolata della pubblica conoscenza, penso che i più spregevoli riceverebbero un sufficiente castigo, così che potrebbero ascoltare, con sicuro profitto, tutto quello che si potrebbe dire della loro reputazione presso la posterità.»
«Parla allora, così che ciò che mi dirai serva da frusta alla mia presuntuosa vanità.»
«Sappi allora che tu, in Inghilterra e fuori, da mille anni o giù di lì, sei solitamente menzionato come ‘il venerabile Beda’, e sei indicato come la luce e la lampada della Chiesa d’Inghilterra; la stella dei nostri tempi; l’ornamento della tua nazione; e degno, se mai qualcuno lo fu, di fama immortale – così istruito (cito le testuali parole dei nostri agiografi), così istruito da far pensare che tu sia vissuto solo per lo studio; così pio da far pensare che tu sia vissuto solo per la preghiera.»
«Fermo, fermo – è più che abbastanza.»
«Oh, devo continuare, o ti avrò dato il veleno senza l’antidoto.»
«Ascolto.»
«Senti allora – i lavori del venerabile Beda, i migliori almeno, sono andati ovunque si pratichi l’insegnamento orale, e hanno preso il loro posto in tutte le biblioteche europee. Inoltre, in tempi recenti, sono state pubblicate in molte edizioni costose. Che mi ricordi, sono state stampate a…»
«Stampate?»
«Sì, stampate; ma ignora la domanda riguardo il significato di questo neologismo – una parola che ha rivoluzionato, e sta rivoluzionando il mondo. Ti basti sapere, al momento, che gli eruditi di tutte le nazioni hanno potuto, con una facilità che tu non mai hai sognato, istruirsi coi tuoi scritti, purché ne avessero la voglia.»
«Vuoi dire, in parole povere, che quasi tutti gli uomini nella tua moderna Europa, mediamente ben istruiti, hanno letto la Historia Ecclesiastica e…»
«Non esageriamo. Per restare nei confini della verità, diciamo piuttosto che – nella massa dei ben informati e dei più istruiti d’Europa – più o meno uno su diecimila può vantarsi di aver messo gli occhi sulla copertina della Historia Ecclesiastica; e poi di quelli che hanno davvero visto il libro, uno su mille può sostenere di averlo tolto dallo scaffale, soffiato la polvere dalla cima, e di averne letto venti pagine. Senza dubbio si può anche trovarne qualcuno (così come si possono trovare uomini con sei dita della mano o del piede) che abbia studiato il venerabile Beda a fondo.»
Il vecchio sprofondò in meditazione, mentre parlavo, e sembrava rimuginare profondi pensieri. Mormorò alla fine un “vanitas vanitatum”; e volse di nuovo il suo orecchio a me. In modo da poter collegarmi in maniera più congrua alle sue meditazioni, continuando osservai saggiamente che: «La fama, una fiamma mai così vivida e ampia come al suo inizio, si riduce, alla fine di mille anni, spesso anche molto prima, al livello di un puntino, come l’immagine del sole glorioso, dopo essere passata attraverso un buchetto in un foglio. Nondimeno dovresti sapere che il venerabile Beda – ‘la lampada della Chiesa d’Inghilterra’ – fu canonizzato poco dopo la sua morte dal Sommo Pontefice, e che i suoi offici sono ancora tenuti dai Benedettini il 29 ottobre; da altri il 27 maggio.»
Avevo appena pronunciato queste parole che il vecchio si drizzò come ferito a morte, e poi cadde in una specie di pallida trance, od orrore – tutti i suoi arti irrigiditi. Neanch’io so come, lo riportai alla fine a una tranquilla padronanza di sé; ma anche allora tremava come se avesse visto un fantasma. Per cambiare argomento, e mostrando noncuranza, continuai:
«Eppure, lasciami dire che, per quanto mai piccola, una porzione della luce e del calore goduto da noi moderni può a ragione essere attribuito all’influenza degli scritti del venerabile Beda, ed è anche vero, e tu dovresti saperlo, che una larghissima quantità di entrambi – voglio dire la luce e il calore effettivamente diffusi fra la gente d’Inghilterra nel diciannovesimo secolo – emana, anno dopo anno, dall’immediata vicinanza di questo stesso monastero. Sì, verissimo è che il ricco e il povero, il colto e il semplice, giorno e notte risplendono dell’aura che si spande da questo luminoso distretto – sì, si potrebbe giustamente chiamare questo Gateshead, e il territorio circostante, la lampada e il focolare d’Inghilterra.»
«Sia benedetto San Cutberto,» esclamò il buon uomo, «mio padre e buon intercessore; benedetto San Cutberto, fondatore e patrono di questa casa – che avvenga, allora (e io sono contento che sia così) – che avvenga che le fatiche del tuo indegno figlio siano cadute a terra quasi senza dare frutto, o che siano lontane dagli occhi degli uomini; ma non è stato lo stesso con le tue: no; dacché sembra che questa sacra fondazione, il devoto lavoro della tua pietà e saggezza, abbia non solo sfidato le tempeste e le rivoluzioni di un millennio, ma sia continuato di epoca in epoca, che abbia ispirato coloro che hanno illuminato tutta la nazione! Immortale e tre volte felice San Cutberto! Da qui in poi sarò orgoglioso solo di averti conosciuto e seguito!» Mi addolorò capire che il vecchio fino a quel punto era stato ingannato da un mio double entendre, ed era stato spinto a esprimere un encomio del suo patrono così poco adorno di fatti. Non ebbi comunque il cuore di disilluderlo dicendogli delle centinaia di migliaia di vagoni di carbone che ogni anno dalla “bella Wallsend” stillano lungo il Tyne.
«Su, continua,» disse lui; «ora, in poche parole, dimmi: quale è stato il destino dei nostri sette regni?»
«Essere mescolati in uno solo – essere razziati, e trascinati nella polvere, da padrone dopo padrone di razziatori stranieri, che vendicarono i Britanni, che furono strappati dalle loro case dai Sassoni; poi essere conquistati ancora da un feroce despota, che non permetteva che si bruciasse un solo giunco dopo il tramonto, ovunque tra Gwaede e Michaelstowe, tranne che nei suoi castelli. Da allora in poi l’Inghilterra si è piegata a dinastie straniere.»
«Ahimè! Senza dubbio questa bella isola, che stava assumendo, finalmente, un posto d’onore fra le nazioni del mondo, è crollata, e ha perso ogni gloria e potere!»
«Questa bella isola, conquistata quattro volte, tormentata da lotte intestine, e da dispute per la corona, scossa da possenti rivoluzioni, questa defraudata e convulsa isola, è ora riconosciuta come regina dei mari, e anche padrona di un impero coloniale, più esteso di quello di Assiria, Macedonia e Roma, messe una sopra l’altra.»
«Ah, vedo che allora ha dato vita a dei giganti; dimmi i nomi dei vostri moderni Sesostre, Ciro, Alessandro, Cesare, che, da soli o in gruppo, hanno conquistato il mondo.»
«Non posso; abbiamo avuto i nostri potenti spiriti; e potremmo vantare un nome che, anche adesso, non sfiguri nelle pagine della storia; ma, in sincera verità, l’Inghilterra, sovrana com’è di tutto il mondo, non vede un principe guerriero sul suo trono da cinque secoli.»
«Allora il regime politico dev’essere del tipo più dispotico, se lascia nelle mani del monarca un potere senza controllo.»
«Nessuna democrazia su cui il sole abbia brillato ha mai lasciato più spazio alla libertà personale, o garantito più influenza al popolo nel limitare l’autorità regale. La prerogativa regale in Inghilterra è quella del leone chiuso in gabbia, che si affida al suo custode per ogni boccone che mangia, e che deve alzarsi, esibirsi e ruggire ogni volta che viene stuzzicato.»
«Almeno un re su dieci è morto nel suo letto?»
«Neanche uno su dieci è morto al di fuori; e solo uno di fatto è stato linciato dalla popolazione.»
«Allora i re d’Inghilterra sono stati semi-dei, o arcangeli.»
«Quasi tutti hanno dato sufficiente prova della loro origine terrena, e in questo momento l’Impero d’Inghilterra, all’apice della sua potenza, detta legge a centinaia di milioni di uomini – uomini di ogni colore – quest’impero è dominato da una giovane e bella mano, sì, e il cuore che batte al suo polso, batte, non ne dubito, con la stessa tranquillità come batte ogni cuore che solleva un dolce seno, fra le bellezze senza pari della sua corte.»
«Bene allora, risolvo l’indovinello. Bisogna riconoscere questo diffusissimo potere, e questa pace, all’universale supremazia della Chiesa. Sì, quindi dev’essere successo che la giusta e paterna autorità della Chiesa dei successori di San Pietro ha piegato a sé tutte le nazioni; e perciò è un giovane, anzi una dolce fanciulla, è in grado di governare un emisfero, poiché gli occhi di tutti gli uomini sono devotamente fissi alle richieste di San Pietro; non è così?»
«Non devo nasconderti la verità; il trono di San Pietro è considerato dal popolo d’Inghilterra, o dalle nazioni che lei governa, alla stessa stregua del cuscino su cui il re di Persia poggia il suo corpo; oppure, semmai, è considerata con maggior riverenza proprio da coloro che lei trova più difficili da gestire. Ma vorrei risparmiarti questi discorsi. Lasciami aggiungere che, in realtà, la diffusione dei sentimenti come ragione, giustizia, benevolenza nei tempi moderni rende praticabili molte cose negli affari di governo che, secoli fa, non si sarebbero neppure tentate.»
«Ah, che luminosa idea si apre alla mia fioca vista! Un vasto impero tranquillamente governato – una dolce e gentile ragazza, angelo dell’ordine e simbolo di divinità! Quanto potenti devono essere diventati, allora, questi dominanti sentimenti di ragione, giustizia, benevolenza, di cui tu parli; nessuno nella tua epoca accampa diritti su un altro. Non si conosce la schiavitù; non avete prigioni, né leggi penali. Quanto sarà passato, cent’anni, da che le nazioni d’Europa si sono confrontate per l’ultima volta, spada in mano?»
«Ahimè, è stato poco più di vent’anni fa circa 200.000 uomini, inglesi, sassoni, tedeschi, francesi, si sono scontrati nel territorio del Belgio, dove un sesto di loro ha ingrassato la terra con il suo sangue.»
«Ti prego, amico, trova argomenti di discussione meno irti di paradossi di quelli che hai toccato, perché, sebbene un propugnatore d’indovinelli trovi pronti ascoltatori fra i giovani e i curiosi, le cui menti sono acute, questo genere di divertimenti infastidisce l’età grigia.»
«Tutto quello che ti ho detto è la nuda verità, ma mi tocca ricordare a un uomo così sagace che le vicende di un’epoca, viste fuori dalle loro cause e dal loro conteso, appaiono sempre come indovinelli agli uomini di un’altra epoca. Ma come mi chiedi cambio argomento, e un facile passaggio dal nostro ultimo discorso mi porta a menzionare una meravigliosa invenzione e progresso – segna questa parola, progresso – dei tempi moderni. Voglio dire un modo per abbreviare la fatica del massacro in un campo di battaglia, o per uccidere centinaia di uomini alla volta, invece di decine. Immagina quindi due nemici opposti, che non gettano più, come una volta, bastoni o pietre l’uno contro l’altro, come in un gioco di bambini, ma che vomitano morte – lanciano lampi e fuoco, più fatali dei pietosi tuoni e fulmini del cielo; sì, si gettano uragani di zolfo e fumo l’un contro l’altro, e grandine di piombo e ferro, con un ruggito più forte di cento cascate, e spazzano via schiere di uomini, o assottigliano forti squadroni – pensa, ti dico, a teste e arti che volano in tutte le direzioni, come i frutti e i rami in un frutteto squassato dalla tormenta.»
«E le nazioni praticano la guerra a questo livello? L’Europa allora sarà diventata una desolazione; ecco perché un impero esteso può essere così facilmente governato, perché in realtà i re comandano mandrie di cervi, non di uomini – su foreste, paludi, deserti, non su province popolose – confessa la verità.»
«Invece la verità è che, nonostante le nostre guerre trattino la morte all’ingrosso, la popolazione è così aumentata nei regni europei, e specialmente in Inghilterra, che la marea della vita ha rotto le dighe e si è rovesciata come un vasto diluvio su continenti scoperti da poco; e l’inondazione umana scorre, di anno in anno, in un flusso pieno e forte, da est a ovest come una volta scorreva da nord a sud.»
«Nuovi continenti? Soddisfa un po’ la mia curiosità. Quanti? Venti?»
«Due; o puoi chiamarli uno solo, proprio come noi chiamiamo le bisacce che pendono dalla schiena di un mulo due, o una.»
«Di che genere? E dove?»
«Uno, una selvaggia distesa di foreste, ripide montagne, paludi senza sentieri, deserti di ghiaccio, laghi sferzati dai lampi, eppure piuttosto fertile a tratti. L’altro, tranne che a tratti, tumido, prolifico, inesauribile; le sue viscere sono cariche di oro, argento, diamanti.»
«Questi continenti sono caduti in mano alle nazioni europee come eredità? E, se sì, a quali fra loro? Ma senza dubbio è l’Inghilterra che ha carpito il regno di oro e diamanti: da qui la vastità del suo impero.»
«No, è l’Inghilterra che ha carpito il premio selvaggio, lasciando i suoi vicini a impoverirsi con montagne di ricchezza. I figli d’Inghilterra, strappati dal suo ventre, e in cerca di una casa dove vivere, in una natura non invidiata, ora mantengono un impero di tale grandezza. Non sai che non sono i metalli preziosi in se stessi che arricchiscono un popolo, ma i motivi per ottenerli?»
«Lo so; bisogna essere infantili per confondere l’oro con la ricchezza. Ma dove sono questi nuovi mondi?»
«Dove tu potresti aver indovinato che siano; quando dicesti che i tuoi contemporanei ignorano che la nostra Terra è una sfera, perché non hai mandato alcuni dei tuoi audaci avventurieri Sassoni a cercare qualcosa che eri sicuro avrebbero trovato: un nuovo continente?»
«Perché la più semplice e probabile verità, avanzata come ipotesi, stupisce e sconvolge anche coloro che hanno acume a sufficienza per scorgerla, mentre terrorizza e scandalizza gli ignoranti. Se ora riuniamo i confratelli di questa casa religiosa, e racconto loro che l’altro lato del mondo è sovrastato da un drago rosso che misura 5.000 miglia dal muso alla punta della sua coda, scommetto che si berranno la favola a bocca aperta. Il drago scenderà su di loro lesto come un’ostrica. Ma lascia che io mostri valide ragioni per credere che il nostro oceano occidentale bagni le coste di un altro continente, e Beda, se non sarà così fortunato da essere confinato in convento con un custode, sarà condannato e, molto probabilmente, bruciato come stregone o eretico.»
«Le cose vanno piuttosto meglio ai nostri giorni; gli ignoranti sono ancora ignoranti; ma hanno imparato a farsi guidare un po’ da coloro che ne sanno di più. La ragione ai nostri tempi ha ottenuto così tanti trionfi agli occhi della gente, che ha guadagnato abbastanza credito da fargli capire qual è il suo posto.»
«Ma com’è possibile raggiungere questi nuovi continenti dell’emisfero occidentale dalle nostre coste? Sono uniti da un tratto di terra?»
«Sono raggiunti allo stesso modo, e con la stessa facilità, con cui la foce del Tyna è raggiunta dalla barca del pescatore che discende il flusso della corrente. Ogni vascello è guidato con sicurezza nel suo percorso senza sentieri attraverso l’oceano – e in una distanza di duemila miglia da qualunque terra, da…»
«Da un angelo?»
«Da… un ago!»
«Oh, oh, allora le genti d’Europa, come dubitarlo?, se non sono ricadute nel paganesimo, si sono orrendamente dedicate alla magia nera. Quello di cui parli è magia bella e buona; un mercimonio con…»
«Bene, di’ così se vuoi; e in verità, se parliamo degli inglesi, e specialmente di quelli del nord dell’isola, non saprei come potrebbero discolparsi del tutto da una tale accusa. Se tu adesso visitassi una qualunque delle grandi città a nord dello Humber, temo che penseresti che, in quell’indaffarata e curiosa gente, tutte le loro arti siano magiche; e molto di quello che vedresti è più stupefacente di qualunque cosa tentata o simulata dalla magia.»
«Buon amico, la mia mente non trova parole comuni o comprensibili. Con tutti questi fatti strani, e cupi mercimoni, l’Inghilterra è ricca?»
«Al di là degli esempi – quasi al di là del calcolo – cosa diresti se dovessi raccontarti che i suoi stessi figli le hanno prestato una somma, presa dalle loro tasche, dai loro risparmi, così grande che chiunque parlasse di rimborso sembrerebbe uno stupido – una somma grande abbastanza per comprare l’Europa – terre, case, schiavi, gioielli, tesori, il quadruplo dei tesori della tua epoca; eppure questo prestito, che non può essere restituito, non inquieta nessuno – né il debitore, né il creditore.»
«Da dove fluisce questo diluvio di ricchezze, se le montagne occidentali d’oro sono in possesso di altri?»
«Te lo dirò con un esempio. Noi mandiamo le nostre navi lontano 14.000 miglia per qualche baccello di cotone: quando li abbiamo, li lavoriamo in stoffe di varie tessiture e colori. Poi li riportiamo da dove sono venuti – 14.000 miglia – e li rivendiamo agli stessi popoli che hanno raccolto il materiale grezzo, a un prezzo così basso che nessuno può farci concorrenza; eppure è grazie al profitto di questo mercato che siamo ricchi come principi.»
«In questo modo, e se è così facile riempire le vostre valige, non possono esserci più poveri in mezzo a voi.»
«No, se escludi alcuni milioni di poveri, mantenuti a spese dello Stato, e alcuni altri milioni lasciati a morire di fame, o quasi. Ma non pensare che noi siamo così duri di cuore. Costruiamo palazzi per i nostri poveri; sì, farebbe girare la testa ai più potenti dei tuoi Sassoni diventare padroni di un edificio, e puoi trovarne parecchi ai nostri giorni, dove i nostri miserabili trovano un rifugio e rimangono: fino a che non capiscono che ciò che i senzatetto chiedono è preferibile a un tale spettacolo.»
«Chi, allora, afferra e gode dei vasti profitti delle vostre tessiture, filande e macine?»
«Stai tranquillo che i telai e le ruote non richiedono più petrolio di quanto ce ne voglia per accendere un fuoco; e, sfortunatamente, le tessiture, le filande e le macine sono ormai considerate, dalle nostre persone istruite, come niente più che ingranaggi e manovelle di un macchinario, e perciò è considerata una follia e uno spreco versare nelle loro mani o nei loro cuori una sola goccia dell’olio della felicità di quanto sia necessario per tenerlo in attività.»
«Perché non fate delle leggi che sostengano una più equa divisione dei profitti?»
«Vogliamo farlo, quando escogiteremo degli statuti che proibiscano i venti dell’est, la ruggine, le estati fredde, e che migliorino le stagioni.»
«Ecco allora che il tuo governo, che comanda vasti imperi, come tu dici, così come una dolce fanciulla alleva un vitello ben pasciuto, è però incapace di garantire i diritti naturali, e un tozzo di pane ai poveri.»
«I nostri governi, è vero, possono fare poco; ciò nonostante l’uomo dei tempi moderni ha molto esteso il suo potere su…»
«Sulle passioni e sull’egoismo? Sugli esseri invisibili e sui demoni malvagi?»
«Né sugli uni né sugli altri, ma sulla natura.»
«E quindi? Cambiate il corso dei pianeti?»
«No; però possiamo portarli vicino all’occhio, come se potessimo avvicinarli per milioni di miglia dalle loro sfere, o se potessimo noi stessi camminare per i cieli.»
«Potete comandare i venti?»
«No; ma possiamo spesso sorpassarli – in terra; e sugli oceani, e forzare un passaggio proprio in bocca a un uragano.»
«Spiegami in parole povere questa nuova gigantesca forza che padroneggiate.»
«È la potenza di un bollitore; ecco il semplice fatto. Sì, e se mi farai compagnia questa sera, ti mostrerò, volteggiante in mezzo alle paludi e alle brughiere di Cealclythe, una lunga carovana di gente e mercanzia – come quelle che scorrono nel deserto d’Arabia; si, in un volo che si lascia alle spalle i venti dell’ovest; tutti, tutti, grazie al vapore di un bollitore!»
«Amico, non abusare così della mia semplicità!»
«Venerabile uomo, non fidarti più di me se non riesco a convincerti di quel che dico. Ti darò subito una prova. Ma nel frattempo ricevi da me la norma generale che, quali che siano le tue abituali meditazioni nel giardino di questo monastero, puoi pensare che siano affidabili come che non lo siano; mentre, qualunque cosa ti sia stata esplicitamente menzionata, per quanto tu la reputi grossolanamente assurda e incredibile (e infatti sei propenso a respingere il mio racconto), si è davvero realizzata, e ora è considerata fra le più familiari e ordinarie delle cose ordinarie.»
«Tutto questo è il frutto di una nuova dispensazione di miracoli? O della sottomissione delle tribù eteree alla volontà dell’uomo, o della concessione alla natura umana di facoltà impensate?»
«Né la prima ipotesi, né la seconda, né la terza è l’ipotesi giusta. L’uomo, individualmente o in generale, non è nulla di più, né più intelligente di quanto lo fosse ai tempi di Tubalcain. Ma ha imparato a usare le sue facoltà in modo migliore; o, piuttosto, a tentare solo ciò che rientra nell’ambito delle sue facoltà; mentre, prima d’ora, gli uomini intelligenti hanno rifiutato ciò che sapevano, o che potevano apprendere facilmente; mentre spendevano le loro forze nel cercare di sapere e fare ciò che è imperscrutabile, o non disponibile, o impraticabile. Dovrei comunque aggiungere che noi moderni dobbiamo molto a quello che chiamiamo casualità, o scoperte di un tale genere che ci meravigliamo della stoltezza dei nostri predecessori nel non aver visto l’ovvio, piuttosto che ammirare il nostro acume nel vederlo adesso. E, mentre ringraziamo Dio, che alla fine ha garantito questo o quel dono all’uomo, tremiamo e parimenti siamo perplessi dal pensiero di quella misteriosa Provvidenza che ha tenuto nascosto agli occhi degli uomini cose che essi avrebbero anche potuto scorgere prima che il mondo avesse cinque secoli di vita.»
«Figliolo, ringraziamo Dio per quello che si è compiaciuto di concedere a noi – indegni del più piccolo dei suoi favori; e non facciamoGli domande su quello di cui ritiene giusto privarci. Tutte queste domande finiscono con il chiedersi: perché un uomo non dovrebbe essere stato un verme, un uomo un serafino, un serafino un dio? E quindi arriviamo all’enigma: perché dovrebbe esistere una cosa qualsiasi nell’universo a parte Dio stesso? Torniamo alla nostra conversazione.»
«Bene, allora. Ti ho appena visto circondato da proprietari terrieri e signori del contado; puoi scrivere tutti i loro nomi?»
«A malapena uno o due.»
«Che cosa fanno allora, quando devono dare una concessione o siglare un patto?»
«Usano un timbro, e molti di loro li portano su anelli alle loro dita, come ornamenti.»
«Quelle dita forse portano, in embrione, il principio o l’elemento della più grande fra tutte le invenzioni, moderne o antiche – un’invenzione che ha già cambiato tutto, si può dire così, tranne i colori del cielo, e che ha solo cominciato a mostrare l’ambito delle sue potenzialità – in se stesso niente di tanto semplice, in termini di meccanica – niente di così meraviglioso come energia – eppure la prima delle sue meraviglie è che nessuno nei secoli precedenti ci abbia pensato o l’abbia messa in pratica. Paragonando i due congegni, si potrebbe pensare che l’arte della stampa avrebbe dovuto precedere la costruzione di un telaio di un migliaio d’anni.»
«E che cos’è questo mistero, l’arte della stampa?»
«Un’arte che rende semplice la moltiplicazione dei libri, che sono diventati la più vile delle merci, e così raggiungono le mani di molti che spesso non riescono a mettere insieme un penny per mangiare.»
«Allora, senza dubbio tutti gli uomini sono diventati sapienti…»
«Molti di più di quanto sono diventati saggi.»
«Eppure quelli fra noi che sono del tutto ignoranti sono in senso assoluto molti di più dell’intera popolazione dell’eptarchia.»
«Fermati amico; prima che tu racconti qualche altra meraviglia, dammi la risposta a questa domanda: tu e i tuoi contemporanei del diciannovesimo secolo siete uomini più felici e migliori di noi dell’ottavo? O siete più saggi?»
«La tua domanda non permette una risposta semplice e categorica; ma bisogna soddisfarle separatamente. Allora dico, senza dubbio, che molti del mio tempo sono incomparabilmente più sapienti, e sono meglio motivati di quanto fosse chiunque nel tuo tempo. Inoltre mi sento di dire che molti di noi sono migliori di quasi tutti fra voi, e moltitudini – migliaia nel diciannovesimo secolo – sono decisamente e generalmente più felici di tutti, o quasi, nell’ottavo; eppure, neanch’io posso nascondere il fatto che i miserabili, gli ignoranti e i viziosi nella mia era sono decisamente venti volte in più che nella tua era.»
«Allora a che servono i tuoi strabilianti progressi?»
«Invece di cercare di rispondere alla tua domanda, semplicemente ti ricordo il fatto che è una legge del sistema umano che, sebbene le nazioni possano restare per migliaia di anni nello stesso stato barbarico, o semibarbarico, ma una volta che lo sviluppo della ragione comincia, questo deve sempre continuare, buone o cattive che siano le conseguenze; niente ferma quel processo che dobbiamo chiamare progresso; niente se non la morte di una nazione o la distruzione sociale del popolo che vive quel progresso. La domanda cui bono, perciò, può trovare risposta in un altro cui bono. Quale sarà il definitivo beneficio che segue lo sviluppo della mente, lo vedremo seguendo il suo processo inevitabile: il lievito, una volta mischiato nel trogolo, agirà.»
«Dovrò chiedere in prestito agli Scandinavi una scopa del nord, per spazzare via le tue arti moderne, e riportare l’umanità a una felice ignoranza?»
«Puoi fare così, se credi. Ma a parte il fatto che siamo ben preparati per affrontarli sulle nostre spiagge, il rimedio non sarebbe efficace – quelle arti hanno più di un santuario nel mondo. Affonda nel mare le isole britanniche – invadi o rivoluziona l’Europa – le arti ancora vivranno. Anche la stampa, di cui ti ho parlato, immortala la filosofia, la letteratura e le arti della moderna Europa.»
«Allora c’è spazio per sperare che tali altri progressi possano ancora aver luogo, in modo da rendere la tua filosofia e le tue arti davvero benefici per la massa dell’umanità; e potranno così assicurare una moderata porzione di benessere e gioia a molti?»
«Sì, lo penso – purché… ma cos’è questo trambusto qui fuori?»
Prima che potessi avere una risposta, il cancello del giardino del monastero si spalancò, e almeno una dozzina di confratelli, spingendosi a vicenda, sbraitando con voci rauche, si sparsero per il giardino. Non trovando il loro reverendo maestro al suo posto nel refettorio all’ora solita, e temendo che gli fosse capitato qualcosa, s’erano tutti agitati alla sua ricerca. Mi alzai, e non sapendo come sarei stato trattato da quegli scalmanati, molti dei quali tenevano in mano mazze ferrate, mi guardai attorno spaventato in cerca di un’uscita diversa dal cancello del giardino. Mi misi a correre, non sapevo neanch’io dove, e, raggiunto il muro, lo scavalcai; e all’istante vidi non il paesaggio selvaggio che era prima davanti ai miei occhi, ma l’alta strada di Durham, avvolta nella polvere, attraverso cui scorsi debolmente, fuori dalla portata della mia voce, il Leeds Mercury che correva via, mandando sprecato l’acquisto del mio biglietto, e lasciandomi nel dubbio se prendere la strada, o fare un vergognoso ritorno allo Swan di Newcastle.
Mario Luca Moretti
Altri interessi oltre al cinema e alla letteratura SF, sono il cinema e la la letteratura tout-court, la musica e la storia. È laureato in Lingue (inglese e tedesco) e lavora presso l'aeroporto di Linate. Abita in provincia di Milano